DE PROFUNDIS
. . . Suffering is one very long moment. We cannot divide it by seasons. We can only record its moods, and chronicle their return. With us time itself does not progress. It revolves. It seems to circle round one centre of pain. The paralysing immobility of a life every circumstance of which is regulated after an unchangeable pattern, so that we eat and drink and lie down and pray, or kneel at least for prayer, according to the inflexible laws of an iron formula: this immobile quality, that makes each dreadful day in the very minutest detail like its brother, seems to communicate itself to those external forces the very essence of whose existence is ceaseless change. Of seed-time or harvest, of the reapers bending over the corn, or the grape gatherers threading through the vines, of the grass in the orchard made white with broken blossoms or strewn with fallen fruit: of these we know nothing and can know nothing.
For us there is only one season, the season of sorrow. The very sun and moon seem taken from us. Outside, the day may be blue and gold, but the light that creeps down through the thickly-muffled glass of the small iron-barred window beneath which one sits is grey and niggard. It is always twilight in one's cell, as it is always twilight in one's heart. And in the sphere of thought, no less than in the sphere of time, motion is no more. The thing that you personally have long ago forgotten, or can easily forget, is happening to me now, and will happen to me again to- morrow. Remember this, and you will be able to understand a little of why I am writing, and in this manner writing. . . .
A week later, I am transferred here. Three more months go over and my mother dies. No one knew how deeply I loved and honoured her. Her death was terrible to me; but I, once a lord of language, have no words in which to express my anguish and my shame. She and my father had bequeathed me a name they had made noble and honoured, not merely in literature, art, archaeology, and science, but in the public history of my own country, in its evolution as a nation. I had disgraced that name eternally. I had made it a low by-word among low people. I had dragged it through the very mire. I had given it to brutes that they might make it brutal, and to fools that they might turn it into a synonym for folly. What I suffered then, and still suffer, is not for pen to write or paper to record. My wife, always kind and gentle to me, rather than that I should hear the news from indifferent lips, travelled, ill as she was, all the way from Genoa to England to break to me herself the tidings of so irreparable, so irremediable, a loss. Messages of sympathy reached me from all who had still affection for me. Even people who had not known me personally, hearing that a new sorrow had broken into my life, wrote to ask that some expression of their condolence should be conveyed to me. . . .
Three months go over. The calendar of my daily conduct and labour that hangs on the outside of my cell door, with my name and sentence written upon it, tells me that it is May. . . .
Prosperity, pleasure and success, may be rough of grain and common in fibre, but sorrow is the most sensitive of all created things. There is nothing that stirs in the whole world of thought to which sorrow does not vibrate in terrible and exquisite pulsation. The thin beaten-out leaf of tremulous gold that chronicles the direction of forces the eye cannot see is in comparison coarse. It is a wound that bleeds when any hand but that of love touches it, and even then must bleed again, though not in pain.
Where there is sorrow there is holy ground. Some day people will realise what that means. They will know nothing of life till they do,--and natures like his can realise it. When I was brought down from my prison to the Court of Bankruptcy, between two policemen,--waited in the long dreary corridor that, before the whole crowd, whom an action so sweet and simple hushed into silence, he might gravely raise his hat to me, as, handcuffed and with bowed head, I passed him by. Men have gone to heaven for smaller things than that. It was in this spirit, and with this mode of love, that the saints knelt down to wash the feet of the poor, or stooped to kiss the leper on the cheek. I have never said one single word to him about what he did. I do not know to the present moment whether he is aware that I was even conscious of his action. It is not a thing for which one can render formal thanks in formal words. I store it in the treasure-house of my heart. I keep it there as a secret debt that I am glad to think I can never possibly repay. It is embalmed and kept sweet by the myrrh and cassia of many tears. When wisdom has been profitless to me, philosophy barren, and the proverbs and phrases of those who have sought to give me consolation as dust and ashes in my mouth, the memory of that little, lovely, silent act of love has unsealed for me all the wells of pity: made the desert blossom like a rose, and brought me out of the bitterness of lonely exile into harmony with the wounded, broken, and great heart of the world. When people are able to understand, not merely how beautiful ---'s action was, but why it meant so much to me, and always will mean so much, then, perhaps, they will realise how and in what spirit they should approach me. . . .
The poor are wise, more charitable, more kind, more sensitive than we are. In their eyes prison is a tragedy in a man's life, a misfortune, a casuality, something that calls for sympathy in others. They speak of one who is in prison as of one who is 'in trouble' simply. It is the phrase they always use, and the expression has the perfect wisdom of love in it. With people of our own rank it is different. With us, prison makes a man a pariah. I, and such as I am, have hardly any right to air and sun. Our presence taints the pleasures of others. We are unwelcome when we reappear. To revisit the glimpses of the moon is not for us. Our very children are taken away. Those lovely links with humanity are broken. We are doomed to be solitary, while our sons still live. We are denied the one thing that might heal us and keep us, that might bring balm to the bruised heart, and peace to the soul in pain. . . .
I must say to myself that I ruined myself, and that nobody great or small can be ruined except by his own hand. I am quite ready to say so. I am trying to say so, though they may not think it at the present moment. This pitiless indictment I bring without pity against myself. Terrible as was what the world did to me, what I did to myself was far more terrible still.
I was a man who stood in symbolic relations to the art and culture of my age. I had realised this for myself at the very dawn of my manhood, and had forced my age to realise it afterwards. Few men hold such a position in their own lifetime, and have it so acknowledged. It is usually discerned, if discerned at all, by the historian, or the critic, long after both the man and his age have passed away. With me it was different. I felt it myself, and made others feel it. Byron was a symbolic figure, but his relations were to the passion of his age and its weariness of passion. Mine were to something more noble, more permanent, of more vital issue, of larger scope.
The gods had given me almost everything. But I let myself be lured into long spells of senseless and sensual ease. I amused myself with being a _flaneur_, a dandy, a man of fashion. I surrounded myself with the smaller natures and the meaner minds. I became the spendthrift of my own genius, and to waste an eternal youth gave me a curious joy. Tired of being on the heights, I deliberately went to the depths in the search for new sensation. What the paradox was to me in the sphere of thought, perversity became to me in the sphere of passion. Desire, at the end, was a malady, or a madness, or both. I grew careless of the lives of others. I took pleasure where it pleased me, and passed on. I forgot that every little action of the common day makes or unmakes character, and that therefore what one has done in the secret chamber one has some day to cry aloud on the housetop. I ceased to be lord over myself. I was no longer the captain of my soul, and did not know it. I allowed pleasure to dominate me. I ended in horrible disgrace. There is only one thing for me now, absolute humility.
I have lain in prison for nearly two years. Out of my nature has come wild despair; an abandonment to grief that was piteous even to look at; terrible and impotent rage; bitterness and scorn; anguish that wept aloud; misery that could find no voice; sorrow that was dumb. I have passed through every possible mood of suffering. Better than Wordsworth himself I know what Wordsworth meant when he said--
'Suffering is permanent, obscure, and dark And has the nature of infinity.'
But while there were times when I rejoiced in the idea that my sufferings were to be endless, I could not bear them to be without meaning. Now I find hidden somewhere away in my nature something that tells me that nothing in the whole world is meaningless, and suffering least of all. That something hidden away in my nature, like a treasure in a field, is Humility.
It is the last thing left in me, and the best: the ultimate discovery at which I have arrived, the starting-point for a fresh development. It has come to me right out of myself, so I know that it has come at the proper time. It could not have come before, nor later. Had any one told me of it, I would have rejected it. Had it been brought to me, I would have refused it. As I found it, I want to keep it. I must do so. It is the one thing that has in it the elements of life, of a new life, _Vita Nuova_ for me. Of all things it is the strangest. One cannot acquire it, except by surrendering everything that one has. It is only when one has lost all things, that one knows that one possesses it.
Now I have realised that it is in me, I see quite clearly what I ought to do; in fact, must do. And when I use such a phrase as that, I need not say that I am not alluding to any external sanction or command. I admit none. I am far more of an individualist than I ever was. Nothing seems to me of the smallest value except what one gets out of oneself. My nature is seeking a fresh mode of self-realisation. That is all I am concerned with. And the first thing that I have got to do is to free myself from any possible bitterness of feeling against the world.
I am completely penniless, and absolutely homeless. Yet there are worse things in the world than that. I am quite candid when I say that rather than go out from this prison with bitterness in my heart against the world, I would gladly and readily beg my bread from door to door. If I got nothing from the house of the rich I would get something at the house of the poor. Those who have much are often greedy; those who have little always share. I would not a bit mind sleeping in the cool grass in summer, and when winter came on sheltering myself by the warm close-thatched rick, or under the penthouse of a great barn, provided I had love in my heart. The external things of life seem to me now of no importance at all. You can see to what intensity of individualism I have arrived--or am arriving rather, for the journey is long, and 'where I walk there are thorns.'
Of course I know that to ask alms on the highway is not to be my lot, and that if ever I lie in the cool grass at night-time it will be to write sonnets to the moon. When I go out of prison, R--- will be waiting for me on the other side of the big iron-studded gate, and he is the symbol, not merely of his own affection, but of the affection of many others besides. I believe I am to have enough to live on for about eighteen months at any rate, so that if I may not write beautiful books, I may at least read beautiful books; and what joy can be greater? After that, I hope to be able to recreate my creative faculty.
But were things different: had I not a friend left in the world; were there not a single house open to me in pity; had I to accept the wallet and ragged cloak of sheer penury: as long as I am free from all resentment, hardness and scorn, I would be able to face the life with much more calm and confidence than I would were my body in purple and fine linen, and the soul within me sick with hate.
And I really shall have no difficulty. When you really want love you will find it waiting for you.
I need not say that my task does not end there. It would be comparatively easy if it did. There is much more before me. I have hills far steeper to climb, valleys much darker to pass through. And I have to get it all out of myself. Neither religion, morality, nor reason can help me at all.
Morality does not help me. I am a born antinomian. I am one of those who are made for exceptions, not for laws. But while I see that there is nothing wrong in what one does, I see that there is something wrong in what one becomes. It is well to have learned that.
Religion does not help me. The faith that others give to what is unseen, I give to what one can touch, and look at. My gods dwell in temples made with hands; and within the circle of actual experience is my creed made perfect and complete: too complete, it may be, for like many or all of those who have placed their heaven in this earth, I have found in it not merely the beauty of heaven, but the horror of hell also. When I think about religion at all, I feel as if I would like to found an order for those who _cannot_ believe: the Confraternity of the Faithless, one might call it, where on an altar, on which no taper burned, a priest, in whose heart peace had no dwelling, might celebrate with unblessed bread and a chalice empty of wine. Every thing to be true must become a religion. And agnosticism should have its ritual no less than faith. It has sown its martyrs, it should reap its saints, and praise God daily for having hidden Himself from man. But whether it be faith or agnosticism, it must be nothing external to me. Its symbols must be of my own creating. Only that is spiritual which makes its own form. If I may not find its secret within myself, I shall never find it: if I have not got it already, it will never come to me.
Reason does not help me. It tells me that the laws under which I am convicted are wrong and unjust laws, and the system under which I have suffered a wrong and unjust system. But, somehow, I have got to make both of these things just and right to me. And exactly as in Art one is only concerned with what a particular thing is at a particular moment to oneself, so it is also in the ethical evolution of one's character. I have got to make everything that has happened to me good for me. The plank bed, the loathsome food, the hard ropes shredded into oakum till one's finger-tips grow dull with pain, the menial offices with which each day begins and finishes, the harsh orders that routine seems to necessitate, the dreadful dress that makes sorrow grotesque to look at, the silence, the solitude, the shame--each and all of these things I have to transform into a spiritual experience. There is not a single degradation of the body which I must not try and make into a spiritualising of the soul.
I want to get to the point when I shall be able to say quite simply, and without affectation that the two great turning-points in my life were when my father sent me to Oxford, and when society sent me to prison. I will not say that prison is the best thing that could have happened to me: for that phrase would savour of too great bitterness towards myself. I would sooner say, or hear it said of me, that I was so typical a child of my age, that in my perversity, and for that perversity's sake, I turned the good things of my life to evil, and the evil things of my life to good.
What is said, however, by myself or by others, matters little. The important thing, the thing that lies before me, the thing that I have to do, if the brief remainder of my days is not to be maimed, marred, and incomplete, is to absorb into my nature all that has been done to me, to make it part of me, to accept it without complaint, fear, or reluctance. The supreme vice is shallowness. Whatever is realised is right.
When first I was put into prison some people advised me to try and forget who I was. It was ruinous advice. It is only by realising what I am that I have found comfort of any kind. Now I am advised by others to try on my release to forget that I have ever been in a prison at all. I know that would be equally fatal. It would mean that I would always be haunted by an intolerable sense of disgrace, and that those things that are meant for me as much as for anybody else--the beauty of the sun and moon, the pageant of the seasons, the music of daybreak and the silence of great nights, the rain falling through the leaves, or the dew creeping over the grass and making it silver--would all be tainted for me, and lose their healing power, and their power of communicating joy. To regret one's own experiences is to arrest one's own development. To deny one's own experiences is to put a lie into the lips of one's own life. It is no less than a denial of the soul.
For just as the body absorbs things of all kinds, things common and unclean no less than those that the priest or a vision has cleansed, and converts them into swiftness or strength, into the play of beautiful muscles and the moulding of fair flesh, into the curves and colours of the hair, the lips, the eye; so the soul in its turn has its nutritive functions also, and can transform into noble moods of thought and passions of high import what in itself is base, cruel and degrading; nay, more, may find in these its most august modes of assertion, and can often reveal itself most perfectly through what was intended to desecrate or destroy.
The fact of my having been the common prisoner of a common gaol I must frankly accept, and, curious as it may seem, one of the things I shall have to teach myself is not to be ashamed of it. I must accept it as a punishment, and if one is ashamed of having been punished, one might just as well never have been punished at all. Of course there are many things of which I was convicted that I had not done, but then there are many things of which I was convicted that I had done, and a still greater number of things in my life for which I was never indicted at all. And as the gods are strange, and punish us for what is good and humane in us as much as for what is evil and perverse, I must accept the fact that one is punished for the good as well as for the evil that one does. I have no doubt that it is quite right one should be. It helps one, or should help one, to realise both, and not to be too conceited about either. And if I then am not ashamed of my punishment, as I hope not to be, I shall be able to think, and walk, and live with freedom.
Many men on their release carry their prison about with them into the air, and hide it as a secret disgrace in their hearts, and at length, like poor poisoned things, creep into some hole and die. It is wretched that they should have to do so, and it is wrong, terribly wrong, of society that it should force them to do so. Society takes upon itself the right to inflict appalling punishment on the individual, but it also has the supreme vice of shallowness, and fails to realise what it has done. When the man's punishment is over, it leaves him to himself; that is to say, it abandons him at the very moment when its highest duty towards him begins. It is really ashamed of its own actions, and shuns those whom it has punished, as people shun a creditor whose debt they cannot pay, or one on whom they have inflicted an irreparable, an irremediable wrong. I can claim on my side that if I realise what I have suffered, society should realise what it has inflicted on me; and that there should be no bitterness or hate on either side.
Of course I know that from one point of view things will be made different for me than for others; must indeed, by the very nature of the case, be made so. The poor thieves and outcasts who are imprisoned here with me are in many respects more fortunate than I am. The little way in grey city or green field that saw their sin is small; to find those who know nothing of what they have done they need go no further than a bird might fly between the twilight and the dawn; but for me the world is shrivelled to a handsbreadth, and everywhere I turn my name is written on the rocks in lead. For I have come, not from obscurity into the momentary notoriety of crime, but from a sort of eternity of fame to a sort of eternity of infamy, and sometimes seem to myself to have shown, if indeed it required showing, that between the famous and the infamous there is but one step, if as much as one.
Still, in the very fact that people will recognise me wherever I go, and know all about my life, as far as its follies go, I can discern something good for me. It will force on me the necessity of again asserting myself as an artist, and as soon as I possibly can. If I can produce only one beautiful work of art I shall be able to rob malice of its venom, and cowardice of its sneer, and to pluck out the tongue of scorn by the roots.
And if life be, as it surely is, a problem to me, I am no less a problem to life. People must adopt some attitude towards me, and so pass judgment, both on themselves and me. I need not say I am not talking of particular individuals. The only people I would care to be with now are artists and people who have suffered: those who know what beauty is, and those who know what sorrow is: nobody else interests me. Nor am I making any demands on life. In all that I have said I am simply concerned with my own mental attitude towards life as a whole; and I feel that not to be ashamed of having been punished is one of the first points I must attain to, for the sake of my own perfection, and because I am so imperfect.
Then I must learn how to be happy. Once I knew it, or thought I knew it, by instinct. It was always springtime once in my heart. My temperament was akin to joy. I filled my life to the very brim with pleasure, as one might fill a cup to the very brim with wine. Now I am approaching life from a completely new standpoint, and even to conceive happiness is often extremely difficult for me. I remember during my first term at Oxford reading in Pater's _Renaissance_--that book which has had such strange influence over my life--how Dante places low in the Inferno those who wilfully live in sadness; and going to the college library and turning to the passage in the _Divine Comedy_ where beneath the dreary marsh lie those who were 'sullen in the sweet air,' saying for ever and ever through their sighs--
'Tristi fummo Nell aer dolce che dal sol s'allegra.'
I knew the church condemned _accidia_, but the whole idea seemed to me quite fantastic, just the sort of sin, I fancied, a priest who knew nothing about real life would invent. Nor could I understand how Dante, who says that 'sorrow remarries us to God,' could have been so harsh to those who were enamoured of melancholy, if any such there really were. I had no idea that some day this would become to me one of the greatest temptations of my life.
While I was in Wandsworth prison I longed to die. It was my one desire. When after two months in the infirmary I was transferred here, and found myself growing gradually better in physical health, I was filled with rage. I determined to commit suicide on the very day on which I left prison. After a time that evil mood passed away, and I made up my mind to live, but to wear gloom as a king wears purple: never to smile again: to turn whatever house I entered into a house of mourning: to make my friends walk slowly in sadness with me: to teach them that melancholy is the true secret of life: to maim them with an alien sorrow: to mar them with my own pain. Now I feel quite differently. I see it would be both ungrateful and unkind of me to pull so long a face that when my friends came to see me they would have to make their faces still longer in order to show their sympathy; or, if I desired to entertain them, to invite them to sit down silently to bitter herbs and funeral baked meats. I must learn how to be cheerful and happy.
The last two occasions on which I was allowed to see my friends here, I tried to be as cheerful as possible, and to show my cheerfulness, in order to make them some slight return for their trouble in coming all the way from town to see me. It is only a slight return, I know, but it is the one, I feel certain, that pleases them most. I saw R--- for an hour on Saturday week, and I tried to give the fullest possible expression of the delight I really felt at our meeting. And that, in the views and ideas I am here shaping for myself, I am quite right is shown to me by the fact that now for the first time since my imprisonment I have a real desire for life.
There is before me so much to do, that I would regard it as a terrible tragedy if I died before I was allowed to complete at any rate a little of it. I see new developments in art and life, each one of which is a fresh mode of perfection. I long to live so that I can explore what is no less than a new world to me. Do you want to know what this new world is? I think you can guess what it is. It is the world in which I have been living. Sorrow, then, and all that it teaches one, is my new world.
I used to live entirely for pleasure. I shunned suffering and sorrow of every kind. I hated both. I resolved to ignore them as far as possible: to treat them, that is to say, as modes of imperfection. They were not part of my scheme of life. They had no place in my philosophy. My mother, who knew life as a whole, used often to quote to me Goethe's lines--written by Carlyle in a book he had given her years ago, and translated by him, I fancy, also:--
'Who never ate his bread in sorrow, Who never spent the midnight hours Weeping and waiting for the morrow,-- He knows you not, ye heavenly powers.'
They were the lines which that noble Queen of Prussia, whom Napoleon treated with such coarse brutality, used to quote in her humiliation and exile; they were the lines my mother often quoted in the troubles of her later life. I absolutely declined to accept or admit the enormous truth hidden in them. I could not understand it. I remember quite well how I used to tell her that I did not want to eat my bread in sorrow, or to pass any night weeping and watching for a more bitter dawn.
I had no idea that it was one of the special things that the Fates had in store for me: that for a whole year of my life, indeed, I was to do little else. But so has my portion been meted out to me; and during the last few months I have, after terrible difficulties and struggles, been able to comprehend some of the lessons hidden in the heart of pain. Clergymen and people who use phrases without wisdom sometimes talk of suffering as a mystery. It is really a revelation. One discerns things one never discerned before. One approaches the whole of history from a different standpoint. What one had felt dimly, through instinct, about art, is intellectually and emotionally realised with perfect clearness of vision and absolute intensity of apprehension.
I now see that sorrow, being the supreme emotion of which man is capable, is at once the type and test of all great art. What the artist is always looking for is the mode of existence in which soul and body are one and indivisible: in which the outward is expressive of the inward: in which form reveals. Of such modes of existence there are not a few: youth and the arts preoccupied with youth may serve as a model for us at one moment: at another we may like to think that, in its subtlety and sensitiveness of impression, its suggestion of a spirit dwelling in external things and making its raiment of earth and air, of mist and city alike, and in its morbid sympathy of its moods, and tones, and colours, modern landscape art is realising for us pictorially what was realised in such plastic perfection by the Greeks. Music, in which all subject is absorbed in expression and cannot be separated from it, is a complex example, and a flower or a child a simple example, of what I mean; but sorrow is the ultimate type both in life and art.
Behind joy and laughter there may be a temperament, coarse, hard and callous. But behind sorrow there is always sorrow. Pain, unlike pleasure, wears no mask. Truth in art is not any correspondence between the essential idea and the accidental existence; it is not the resemblance of shape to shadow, or of the form mirrored in the crystal to the form itself; it is no echo coming from a hollow hill, any more than it is a silver well of water in the valley that shows the moon to the moon and Narcissus to Narcissus. Truth in art is the unity of a thing with itself: the outward rendered expressive of the inward: the soul made incarnate: the body instinct with spirit. For this reason there is no truth comparable to sorrow. There are times when sorrow seems to me to be the only truth. Other things may be illusions of the eye or the appetite, made to blind the one and cloy the other, but out of sorrow have the worlds been built, and at the birth of a child or a star there is pain.
More than this, there is about sorrow an intense, an extraordinary reality. I have said of myself that I was one who stood in symbolic relations to the art and culture of my age. There is not a single wretched man in this wretched place along with me who does not stand in symbolic relation to the very secret of life. For the secret of life is suffering. It is what is hidden behind everything. When we begin to live, what is sweet is so sweet to us, and what is bitter so bitter, that we inevitably direct all our desires towards pleasures, and seek not merely for a 'month or twain to feed on honeycomb,' but for all our years to taste no other food, ignorant all the while that we may really be starving the soul.
I remember talking once on this subject to one of the most beautiful personalities I have ever known: a woman, whose sympathy and noble kindness to me, both before and since the tragedy of my imprisonment, have been beyond power and description; one who has really assisted me, though she does not know it, to bear the burden of my troubles more than any one else in the whole world has, and all through the mere fact of her existence, through her being what she is--partly an ideal and partly an influence: a suggestion of what one might become as well as a real help towards becoming it; a soul that renders the common air sweet, and makes what is spiritual seem as simple and natural as sunlight or the sea: one for whom beauty and sorrow walk hand in hand, and have the same message. On the occasion of which I am thinking I recall distinctly how I said to her that there was enough suffering in one narrow London lane to show that God did not love man, and that wherever there was any sorrow, though but that of a child, in some little garden weeping over a fault that it had or had not committed, the whole face of creation was completely marred. I was entirely wrong. She told me so, but I could not believe her. I was not in the sphere in which such belief was to be attained to. Now it seems to me that love of some kind is the only possible explanation of the extraordinary amount of suffering that there is in the world. I cannot conceive of any other explanation. I am convinced that there is no other, and that if the world has indeed, as I have said, been built of sorrow, it has been built by the hands of love, because in no other way could the soul of man, for whom the world was made, reach the full stature of its perfection. Pleasure for the beautiful body, but pain for the beautiful soul.
When I say that I am convinced of these things I speak with too much pride. Far off, like a perfect pearl, one can see the city of God. It is so wonderful that it seems as if a child could reach it in a summer's day. And so a child could. But with me and such as me it is different. One can realise a thing in a single moment, but one loses it in the long hours that follow with leaden feet. It is so difficult to keep 'heights that the soul is competent to gain.' We think in eternity, but we move slowly through time; and how slowly time goes with us who lie in prison I need not tell again, nor of the weariness and despair that creep back into one's cell, and into the cell of one's heart, with such strange insistence that one has, as it were, to garnish and sweep one's house for their coming, as for an unwelcome guest, or a bitter master, or a slave whose slave it is one's chance or choice to be.
And, though at present my friends may find it a hard thing to believe, it is true none the less, that for them living in freedom and idleness and comfort it is more easy to learn the lessons of humility than it is for me, who begin the day by going down on my knees and washing the floor of my cell. For prison life with its endless privations and restrictions makes one rebellious. The most terrible thing about it is not that it breaks one's heart--hearts are made to be broken--but that it turns one's heart to stone. One sometimes feels that it is only with a front of brass and a lip of scorn that one can get through the day at all. And he who is in a state of rebellion cannot receive grace, to use the phrase of which the Church is so fond--so rightly fond, I dare say--for in life as in art the mood of rebellion closes up the channels of the soul, and shuts out the airs of heaven. Yet I must learn these lessons here, if I am to learn them anywhere, and must be filled with joy if my feet are on the right road and my face set towards 'the gate which is called beautiful,' though I may fall many times in the mire and often in the mist go astray.
This New Life, as through my love of Dante I like sometimes to call it, is of course no new life at all, but simply the continuance, by means of development, and evolution, of my former life. I remember when I was at Oxford saying to one of my friends as we were strolling round Magdalen's narrow bird-haunted walks one morning in the year before I took my degree, that I wanted to eat of the fruit of all the trees in the garden of the world, and that I was going out into the world with that passion in my soul. And so, indeed, I went out, and so I lived. My only mistake was that I confined myself so exclusively to the trees of what seemed to me the sun-lit side of the garden, and shunned the other side for its shadow and its gloom. Failure, disgrace, poverty, sorrow, despair, suffering, tears even, the broken words that come from lips in pain, remorse that makes one walk on thorns, conscience that condemns, self- abasement that punishes, the misery that puts ashes on its head, the anguish that chooses sack-cloth for its raiment and into its own drink puts gall:--all these were things of which I was afraid. And as I had determined to know nothing of them, I was forced to taste each of them in turn, to feed on them, to have for a season, indeed, no other food at all.
I don't regret for a single moment having lived for pleasure. I did it to the full, as one should do everything that one does. There was no pleasure I did not experience. I threw the pearl of my soul into a cup of wine. I went down the primrose path to the sound of flutes. I lived on honeycomb. But to have continued the same life would have been wrong because it would have been limiting. I had to pass on. The other half of the garden had its secrets for me also. Of course all this is foreshadowed and prefigured in my books. Some of it is in _The Happy Prince_, some of it in _The Young King_, notably in the passage where the bishop says to the kneeling boy, 'Is not He who made misery wiser than thou art'? a phrase which when I wrote it seemed to me little more than a phrase; a great deal of it is hidden away in the note of doom that like a purple thread runs through the texture of _Dorian Gray_; in _The Critic as Artist_ it is set forth in many colours; in _The Soul of Man_ it is written down, and in letters too easy to read; it is one of the refrains whose recurring _motifs_ make _Salome_ so like a piece of music and bind it together as a ballad; in the prose poem of the man who from the bronze of the image of the 'Pleasure that liveth for a moment' has to make the image of the 'Sorrow that abideth for ever' it is incarnate. It could not have been otherwise. At every single moment of one's life one is what one is going to be no less than what one has been. Art is a symbol, because man is a symbol.
It is, if I can fully attain to it, the ultimate realisation of the artistic life. For the artistic life is simply self-development. Humility in the artist is his frank acceptance of all experiences, just as love in the artist is simply the sense of beauty that reveals to the world its body and its soul. In _Marius the Epicurean_ Pater seeks to reconcile the artistic life with the life of religion, in the deep, sweet, and austere sense of the word. But Marius is little more than a spectator: an ideal spectator indeed, and one to whom it is given 'to contemplate the spectacle of life with appropriate emotions,' which Wordsworth defines as the poet's true aim; yet a spectator merely, and perhaps a little too much occupied with the comeliness of the benches of the sanctuary to notice that it is the sanctuary of sorrow that he is gazing at.
I see a far more intimate and immediate connection between the true life of Christ and the true life of the artist; and I take a keen pleasure in the reflection that long before sorrow had made my days her own and bound me to her wheel I had written in _The Soul of Man_ that he who would lead a Christ-like life must be entirely and absolutely himself, and had taken as my types not merely the shepherd on the hillside and the prisoner in his cell, but also the painter to whom the world is a pageant and the poet for whom the world is a song. I remember saying once to Andre Gide, as we sat together in some Paris _cafe_, that while meta-physics had but little real interest for me, and morality absolutely none, there was nothing that either Plato or Christ had said that could not be transferred immediately into the sphere of Art and there find its complete fulfilment.
Nor is it merely that we can discern in Christ that close union of personality with perfection which forms the real distinction between the classical and romantic movement in life, but the very basis of his nature was the same as that of the nature of the artist--an intense and flamelike imagination. He realised in the entire sphere of human relations that imaginative sympathy which in the sphere of Art is the sole secret of creation. He understood the leprosy of the leper, the darkness of the blind, the fierce misery of those who live for pleasure, the strange poverty of the rich. Some one wrote to me in trouble, 'When you are not on your pedestal you are not interesting.' How remote was the writer from what Matthew Arnold calls 'the Secret of Jesus.' Either would have taught him that whatever happens to another happens to oneself, and if you want an inscription to read at dawn and at night-time, and for pleasure or for pain, write up on the walls of your house in letters for the sun to gild and the moon to silver, 'Whatever happens to oneself happens to another.'
Christ's place indeed is with the poets. His whole conception of Humanity sprang right out of the imagination and can only be realised by it. What God was to the pantheist, man was to Him. He was the first to conceive the divided races as a unity. Before his time there had been gods and men, and, feeling through the mysticism of sympathy that in himself each had been made incarnate, he calls himself the Son of the one or the Son of the other, according to his mood. More than any one else in history he wakes in us that temper of wonder to which romance always appeals. There is still something to me almost incredible in the idea of a young Galilean peasant imagining that he could bear on his own shoulders the burden of the entire world; all that had already been done and suffered, and all that was yet to be done and suffered: the sins of Nero, of Caesar Borgia, of Alexander VI., and of him who was Emperor of Rome and Priest of the Sun: the sufferings of those whose names are legion and whose dwelling is among the tombs: oppressed nationalities, factory children, thieves, people in prison, outcasts, those who are dumb under oppression and whose silence is heard only of God; and not merely imagining this but actually achieving it, so that at the present moment all who come in contact with his personality, even though they may neither bow to his altar nor kneel before his priest, in some way find that the ugliness of their sin is taken away and the beauty of their sorrow revealed to them.
I had said of Christ that he ranks with the poets. That is true. Shelley and Sophocles are of his company. But his entire life also is the most wonderful of poems. For 'pity and terror' there is nothing in the entire cycle of Greek tragedy to touch it. The absolute purity of the protagonist raises the entire scheme to a height of romantic art from which the sufferings of Thebes and Pelops' line are by their very horror excluded, and shows how wrong Aristotle was when he said in his treatise on the drama that it would be impossible to bear the spectacle of one blameless in pain. Nor in AEschylus nor Dante, those stern masters of tenderness, in Shakespeare, the most purely human of all the great artists, in the whole of Celtic myth and legend, where the loveliness of the world is shown through a mist of tears, and the life of a man is no more than the life of a flower, is there anything that, for sheer simplicity of pathos wedded and made one with sublimity of tragic effect, can be said to equal or even approach the last act of Christ's passion. The little supper with his companions, one of whom has already sold him for a price; the anguish in the quiet moon-lit garden; the false friend coming close to him so as to betray him with a kiss; the friend who still believed in him, and on whom as on a rock he had hoped to build a house of refuge for Man, denying him as the bird cried to the dawn; his own utter loneliness, his submission, his acceptance of everything; and along with it all such scenes as the high priest of orthodoxy rending his raiment in wrath, and the magistrate of civil justice calling for water in the vain hope of cleansing himself of that stain of innocent blood that makes him the scarlet figure of history; the coronation ceremony of sorrow, one of the most wonderful things in the whole of recorded time; the crucifixion of the Innocent One before the eyes of his mother and of the disciple whom he loved; the soldiers gambling and throwing dice for his clothes; the terrible death by which he gave the world its most eternal symbol; and his final burial in the tomb of the rich man, his body swathed in Egyptian linen with costly spices and perfumes as though he had been a king's son. When one contemplates all this from the point of view of art alone one cannot but be grateful that the supreme office of the Church should be the playing of the tragedy without the shedding of blood: the mystical presentation, by means of dialogue and costume and gesture even, of the Passion of her Lord; and it is always a source of pleasure and awe to me to remember that the ultimate survival of the Greek chorus, lost elsewhere to art, is to be found in the servitor answering the priest at Mass.
Yet the whole life of Christ--so entirely may sorrow and beauty be made one in their meaning and manifestation--is really an idyll, though it ends with the veil of the temple being rent, and the darkness coming over the face of the earth, and the stone rolled to the door of the sepulchre. One always thinks of him as a young bridegroom with his companions, as indeed he somewhere describes himself; as a shepherd straying through a valley with his sheep in search of green meadow or cool stream; as a singer trying to build out of the music the walls of the City of God; or as a lover for whose love the whole world was too small. His miracles seem to me to be as exquisite as the coming of spring, and quite as natural. I see no difficulty at all in believing that such was the charm of his personality that his mere presence could bring peace to souls in anguish, and that those who touched his garments or his hands forgot their pain; or that as he passed by on the highway of life people who had seen nothing of life's mystery, saw it clearly, and others who had been deaf to every voice but that of pleasure heard for the first time the voice of love and found it as 'musical as Apollo's lute'; or that evil passions fled at his approach, and men whose dull unimaginative lives had been but a mode of death rose as it were from the grave when he called them; or that when he taught on the hillside the multitude forgot their hunger and thirst and the cares of this world, and that to his friends who listened to him as he sat at meat the coarse food seemed delicate, and the water had the taste of good wine, and the whole house became full of the odour and sweetness of nard.
Renan in his _Vie de Jesus_--that gracious fifth gospel, the gospel according to St. Thomas, one might call it--says somewhere that Christ's great achievement was that he made himself as much loved after his death as he had been during his lifetime. And certainly, if his place is among the poets, he is the leader of all the lovers. He saw that love was the first secret of the world for which the wise men had been looking, and that it was only through love that one could approach either the heart of the leper or the feet of God.
And above all, Christ is the most supreme of individualists. Humility, like the artistic, acceptance of all experiences, is merely a mode of manifestation. It is man's soul that Christ is always looking for. He calls it 'God's Kingdom,' and finds it in every one. He compares it to little things, to a tiny seed, to a handful of leaven, to a pearl. That is because one realises one's soul only by getting rid of all alien passions, all acquired culture, and all external possessions, be they good or evil.
I bore up against everything with some stubbornness of will and much rebellion of nature, till I had absolutely nothing left in the world but one thing. I had lost my name, my position, my happiness, my freedom, my wealth. I was a prisoner and a pauper. But I still had my children left. Suddenly they were taken away from me by the law. It was a blow so appalling that I did not know what to do, so I flung myself on my knees, and bowed my head, and wept, and said, 'The body of a child is as the body of the Lord: I am not worthy of either.' That moment seemed to save me. I saw then that the only thing for me was to accept everything. Since then--curious as it will no doubt sound--I have been happier. It was of course my soul in its ultimate essence that I had reached. In many ways I had been its enemy, but I found it waiting for me as a friend. When one comes in contact with the soul it makes one simple as a child, as Christ said one should be.
It is tragic how few people ever 'possess their souls' before they die. 'Nothing is more rare in any man,' says Emerson, 'than an act of his own.' It is quite true. Most people are other people. Their thoughts are some one else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation. Christ was not merely the supreme individualist, but he was the first individualist in history. People have tried to make him out an ordinary philanthropist, or ranked him as an altruist with the scientific and sentimental. But he was really neither one nor the other. Pity he has, of course, for the poor, for those who are shut up in prisons, for the lowly, for the wretched; but he has far more pity for the rich, for the hard hedonists, for those who waste their freedom in becoming slaves to things, for those who wear soft raiment and live in kings' houses. Riches and pleasure seemed to him to be really greater tragedies than poverty or sorrow. And as for altruism, who knew better than he that it is vocation not volition that determines us, and that one cannot gather grapes of thorns or figs from thistles?
To live for others as a definite self-conscious aim was not his creed. It was not the basis of his creed. When he says, 'Forgive your enemies,' it is not for the sake of the enemy, but for one's own sake that he says so, and because love is more beautiful than hate. In his own entreaty to the young man, 'Sell all that thou hast and give to the poor,' it is not of the state of the poor that he is thinking but of the soul of the young man, the soul that wealth was marring. In his view of life he is one with the artist who knows that by the inevitable law of self-perfection, the poet must sing, and the sculptor think in bronze, and the painter make the world a mirror for his moods, as surely and as certainly as the hawthorn must blossom in spring, and the corn turn to gold at harvest- time, and the moon in her ordered wanderings change from shield to sickle, and from sickle to shield.
But while Christ did not say to men, 'Live for others,' he pointed out that there was no difference at all between the lives of others and one's own life. By this means he gave to man an extended, a Titan personality. Since his coming the history of each separate individual is, or can be made, the history of the world. Of course, culture has intensified the personality of man. Art has made us myriad-minded. Those who have the artistic temperament go into exile with Dante and learn how salt is the bread of others, and how steep their stairs; they catch for a moment the serenity and calm of Goethe, and yet know but too well that Baudelaire cried to God--
'O Seigneur, donnez moi la force et le courage De contempler mon corps et mon coeur sans degout.'
Out of Shakespeare's sonnets they draw, to their own hurt it may be, the secret of his love and make it their own; they look with new eyes on modern life, because they have listened to one of Chopin's nocturnes, or handled Greek things, or read the story of the passion of some dead man for some dead woman whose hair was like threads of fine gold, and whose mouth was as a pomegranate. But the sympathy of the artistic temperament is necessarily with what has found expression. In words or in colours, in music or in marble, behind the painted masks of an AEschylean play, or through some Sicilian shepherds' pierced and jointed reeds, the man and his message must have been revealed.
To the artist, expression is the only mode under which he can conceive life at all. To him what is dumb is dead. But to Christ it was not so. With a width and wonder of imagination that fills one almost with awe, he took the entire world of the inarticulate, the voiceless world of pain, as his kingdom, and made of himself its eternal mouthpiece. Those of whom I have spoken, who are dumb under oppression, and 'whose silence is heard only of God,' he chose as his brothers. He sought to become eyes to the blind, ears to the deaf, and a cry in the lips of those whose tongues had been tied. His desire was to be to the myriads who had found no utterance a very trumpet through which they might call to heaven. And feeling, with the artistic nature of one to whom suffering and sorrow were modes through which he could realise his conception of the beautiful, that an idea is of no value till it becomes incarnate and is made an image, he made of himself the image of the Man of Sorrows, and as such has fascinated and dominated art as no Greek god ever succeeded in doing.
For the Greek gods, in spite of the white and red of their fair fleet limbs, were not really what they appeared to be. The curved brow of Apollo was like the sun's disc crescent over a hill at dawn, and his feet were as the wings of the morning, but he himself had been cruel to Marsyas and had made Niobe childless. In the steel shields of Athena's eyes there had been no pity for Arachne; the pomp and peacocks of Hera were all that was really noble about her; and the Father of the Gods himself had been too fond of the daughters of men. The two most deeply suggestive figures of Greek Mythology were, for religion, Demeter, an Earth Goddess, not one of the Olympians, and for art, Dionysus, the son of a mortal woman to whom the moment of his birth had proved also the moment of her death.
But Life itself from its lowliest and most humble sphere produced one far more marvellous than the mother of Proserpina or the son of Semele. Out of the Carpenter's shop at Nazareth had come a personality infinitely greater than any made by myth and legend, and one, strangely enough, destined to reveal to the world the mystical meaning of wine and the real beauties of the lilies of the field as none, either on Cithaeron or at Enna, had ever done.
The song of Isaiah, 'He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief: and we hid as it were our faces from him,' had seemed to him to prefigure himself, and in him the prophecy was fulfilled. We must not be afraid of such a phrase. Every single work of art is the fulfilment of a prophecy: for every work of art is the conversion of an idea into an image. Every single human being should be the fulfilment of a prophecy: for every human being should be the realisation of some ideal, either in the mind of God or in the mind of man. Christ found the type and fixed it, and the dream of a Virgilian poet, either at Jerusalem or at Babylon, became in the long progress of the centuries incarnate in him for whom the world was waiting.
To me one of the things in history the most to be regretted is that the Christ's own renaissance, which has produced the Cathedral at Chartres, the Arthurian cycle of legends, the life of St. Francis of Assisi, the art of Giotto, and Dante's _Divine Comedy_, was not allowed to develop on its own lines, but was interrupted and spoiled by the dreary classical Renaissance that gave us Petrarch, and Raphael's frescoes, and Palladian architecture, and formal French tragedy, and St. Paul's Cathedral, and Pope's poetry, and everything that is made from without and by dead rules, and does not spring from within through some spirit informing it. But wherever there is a romantic movement in art there somehow, and under some form, is Christ, or the soul of Christ. He is in _Romeo and Juliet_, in the _Winter's Tale_, in Provencal poetry, in the _Ancient Mariner_, in _La Belle Dame sans merci_, and in Chatterton's _Ballad of Charity_.
We owe to him the most diverse things and people. Hugo's _Les Miserables_, Baudelaire's _Fleurs du Mal_, the note of pity in Russian novels, Verlaine and Verlaine's poems, the stained glass and tapestries and the quattro-cento work of Burne-Jones and Morris, belong to him no less than the tower of Giotto, Lancelot and Guinevere, Tannhauser, the troubled romantic marbles of Michael Angelo, pointed architecture, and the love of children and flowers--for both of which, indeed, in classical art there was but little place, hardly enough for them to grow or play in, but which, from the twelfth century down to our own day, have been continually making their appearances in art, under various modes and at various times, coming fitfully and wilfully, as children, as flowers, are apt to do: spring always seeming to one as if the flowers had been in hiding, and only came out into the sun because they were afraid that grown up people would grow tired of looking for them and give up the search; and the life of a child being no more than an April day on which there is both rain and sun for the narcissus.
It is the imaginative quality of Christ's own nature that makes him this palpitating centre of romance. The strange figures of poetic drama and ballad are made by the imagination of others, but out of his own imagination entirely did Jesus of Nazareth create himself. The cry of Isaiah had really no more to do with his coming than the song of the nightingale has to do with the rising of the moon--no more, though perhaps no less. He was the denial as well as the affirmation of prophecy. For every expectation that he fulfilled there was another that he destroyed. 'In all beauty,' says Bacon, 'there is some strangeness of proportion,' and of those who are born of the spirit--of those, that is to say, who like himself are dynamic forces--Christ says that they are like the wind that 'bloweth where it listeth, and no man can tell whence it cometh and whither it goeth.' That is why he is so fascinating to artists. He has all the colour elements of life: mystery, strangeness, pathos, suggestion, ecstasy, love. He appeals to the temper of wonder, and creates that mood in which alone he can be understood.
And to me it is a joy to remember that if he is 'of imagination all compact,' the world itself is of the same substance. I said in _Dorian Gray_ that the great sins of the world take place in the brain: but it is in the brain that everything takes place. We know now that we do not see with the eyes or hear with the ears. They are really channels for the transmission, adequate or inadequate, of sense impressions. It is in the brain that the poppy is red, that the apple is odorous, that the skylark sings.
Of late I have been studying with diligence the four prose poems about Christ. At Christmas I managed to get hold of a Greek Testament, and every morning, after I had cleaned my cell and polished my tins, I read a little of the Gospels, a dozen verses taken by chance anywhere. It is a delightful way of opening the day. Every one, even in a turbulent, ill- disciplined life, should do the same. Endless repetition, in and out of season, has spoiled for us the freshness, the naivete, the simple romantic charm of the Gospels. We hear them read far too often and far too badly, and all repetition is anti-spiritual. When one returns to the Greek; it is like going into a garden of lilies out of some, narrow and dark house.
And to me, the pleasure is doubled by the reflection that it is extremely probable that we have the actual terms, the _ipsissima verba_, used by Christ. It was always supposed that Christ talked in Aramaic. Even Renan thought so. But now we know that the Galilean peasants, like the Irish peasants of our own day, were bilingual, and that Greek was the ordinary language of intercourse all over Palestine, as indeed all over the Eastern world. I never liked the idea that we knew of Christ's own words only through a translation of a translation. It is a delight to me to think that as far as his conversation was concerned, Charmides might have listened to him, and Socrates reasoned with him, and Plato understood him: that he really said [Greek text], that when he thought of the lilies of the field and how they neither toil nor spin, his absolute expression was [Greek text], and that his last word when he cried out 'my life has been completed, has reached its fulfilment, has been perfected,' was exactly as St. John tells us it was: [Greek text]--no more.
While in reading the Gospels--particularly that of St. John himself, or whatever early Gnostic took his name and mantle--I see the continual assertion of the imagination as the basis of all spiritual and material life, I see also that to Christ imagination was simply a form of love, and that to him love was lord in the fullest meaning of the phrase. Some six weeks ago I was allowed by the doctor to have white bread to eat instead of the coarse black or brown bread of ordinary prison fare. It is a great delicacy. It will sound strange that dry bread could possibly be a delicacy to any one. To me it is so much so that at the close of each meal I carefully eat whatever crumbs may be left on my tin plate, or have fallen on the rough towel that one uses as a cloth so as not to soil one's table; and I do so not from hunger--I get now quite sufficient food--but simply in order that nothing should be wasted of what is given to me. So one should look on love.
Christ, like all fascinating personalities, had the power of not merely saying beautiful things himself, but of making other people say beautiful things to him; and I love the story St. Mark tells us about the Greek woman, who, when as a trial of her faith he said to her that he could not give her the bread of the children of Israel, answered him that the little dogs--([Greek text], 'little dogs' it should be rendered)--who are under the table eat of the crumbs that the children let fall. Most people live for love and admiration. But it is by love and admiration that we should live. If any love is shown us we should recognise that we are quite unworthy of it. Nobody is worthy to be loved. The fact that God loves man shows us that in the divine order of ideal things it is written that eternal love is to be given to what is eternally unworthy. Or if that phrase seems to be a bitter one to bear, let us say that every one is worthy of love, except him who thinks that he is. Love is a sacrament that should be taken kneeling, and _Domine, non sum dignus_ should be on the lips and in the hearts of those who receive it.
If ever I write again, in the sense of producing artistic work, there are just two subjects on which and through which I desire to express myself: one is 'Christ as the precursor of the romantic movement in life': the other is 'The artistic life considered in its relation to conduct.' The first is, of course, intensely fascinating, for I see in Christ not merely the essentials of the supreme romantic type, but all the accidents, the wilfulnesses even, of the romantic temperament also. He was the first person who ever said to people that they should live 'flower-like lives.' He fixed the phrase. He took children as the type of what people should try to become. He held them up as examples to their elders, which I myself have always thought the chief use of children, if what is perfect should have a use. Dante describes the soul of a man as coming from the hand of God 'weeping and laughing like a little child,' and Christ also saw that the soul of each one should be _a guisa di fanciulla che piangendo e ridendo pargoleggia_. He felt that life was changeful, fluid, active, and that to allow it to be stereotyped into any form was death. He saw that people should not be too serious over material, common interests: that to be unpractical was to be a great thing: that one should not bother too much over affairs. The birds didn't, why should man? He is charming when he says, 'Take no thought for the morrow; is not the soul more than meat? is not the body more than raiment?' A Greek might have used the latter phrase. It is full of Greek feeling. But only Christ could have said both, and so summed up life perfectly for us.
His morality is all sympathy, just what morality should be. If the only thing that he ever said had been, 'Her sins are forgiven her because she loved much,' it would have been worth while dying to have said it. His justice is all poetical justice, exactly what justice should be. The beggar goes to heaven because he has been unhappy. I cannot conceive a better reason for his being sent there. The people who work for an hour in the vineyard in the cool of the evening receive just as much reward as those who have toiled there all day long in the hot sun. Why shouldn't they? Probably no one deserved anything. Or perhaps they were a different kind of people. Christ had no patience with the dull lifeless mechanical systems that treat people as if they were things, and so treat everybody alike: for him there were no laws: there were exceptions merely, as if anybody, or anything, for that matter, was like aught else in the world!
That which is the very keynote of romantic art was to him the proper basis of natural life. He saw no other basis. And when they brought him one, taken in the very act of sin and showed him her sentence written in the law, and asked him what was to be done, he wrote with his finger on the ground as though he did not hear them, and finally, when they pressed him again, looked up and said, 'Let him of you who has never sinned be the first to throw the stone at her.' It was worth while living to have said that.
Like all poetical natures he loved ignorant people. He knew that in the soul of one who is ignorant there is always room for a great idea. But he could not stand stupid people, especially those who are made stupid by education: people who are full of opinions not one of which they even understand, a peculiarly modern type, summed up by Christ when he describes it as the type of one who has the key of knowledge, cannot use it himself, and does not allow other people to use it, though it may be made to open the gate of God's Kingdom. His chief war was against the Philistines. That is the war every child of light has to wage. Philistinism was the note of the age and community in which he lived. In their heavy inaccessibility to ideas, their dull respectability, their tedious orthodoxy, their worship of vulgar success, their entire preoccupation with the gross materialistic side of life, and their ridiculous estimate of themselves and their importance, the Jews of Jerusalem in Christ's day were the exact counterpart of the British Philistine of our own. Christ mocked at the 'whited sepulchre' of respectability, and fixed that phrase for ever. He treated worldly success as a thing absolutely to be despised. He saw nothing in it at all. He looked on wealth as an encumbrance to a man. He would not hear of life being sacrificed to any system of thought or morals. He pointed out that forms and ceremonies were made for man, not man for forms and ceremonies. He took sabbatarianism as a type of the things that should be set at nought. The cold philanthropies, the ostentatious public charities, the tedious formalisms so dear to the middle-class mind, he exposed with utter and relentless scorn. To us, what is termed orthodoxy is merely a facile unintelligent acquiescence; but to them, and in their hands, it was a terrible and paralysing tyranny. Christ swept it aside. He showed that the spirit alone was of value. He took a keen pleasure in pointing out to them that though they were always reading the law and the prophets, they had not really the smallest idea of what either of them meant. In opposition to their tithing of each separate day into the fixed routine of prescribed duties, as they tithe mint and rue, he preached the enormous importance of living completely for the moment.
Those whom he saved from their sins are saved simply for beautiful moments in their lives. Mary Magdalen, when she sees Christ, breaks the rich vase of alabaster that one of her seven lovers had given her, and spills the odorous spices over his tired dusty feet, and for that one moment's sake sits for ever with Ruth and Beatrice in the tresses of the snow-white rose of Paradise. All that Christ says to us by the way of a little warning is that every moment should be beautiful, that the soul should always be ready for the coming of the bridegroom, always waiting for the voice of the lover, Philistinism being simply that side of man's nature that is not illumined by the imagination. He sees all the lovely influences of life as modes of light: the imagination itself is the world of light. The world is made by it, and yet the world cannot understand it: that is because the imagination is simply a manifestation of love, and it is love and the capacity for it that distinguishes one human being from another.
But it is when he deals with a sinner that Christ is most romantic, in the sense of most real. The world had always loved the saint as being the nearest possible approach to the perfection of God. Christ, through some divine instinct in him, seems to have always loved the sinner as being the nearest possible approach to the perfection of man. His primary desire was not to reform people, any more than his primary desire was to a relieve suffering. To turn an interesting thief into a tedious honest man was not his aim. He would have thought little of the Prisoners' Aid Society and other modern movements of the kind. The conversion of a publican into a Pharisee would not have seemed to him a great achievement. But in a manner not yet understood of the world he regarded sin and suffering as being in themselves beautiful holy things and modes of perfection.
It seems a very dangerous idea. It is--all great ideas are dangerous. That it was Christ's creed admits of no doubt. That it is the true creed I don't doubt myself.
Of course the sinner must repent. But why? Simply because otherwise he would be unable to realise what he had done. The moment of repentance is the moment of initiation. More than that: it is the means by which one alters one's past. The Greeks thought that impossible. They often say in their Gnomic aphorisms, 'Even the Gods cannot alter the past.' Christ showed that the commonest sinner could do it, that it was the one thing he could do. Christ, had he been asked, would have said--I feel quite certain about it--that the moment the prodigal son fell on his knees and wept, he made his having wasted his substance with harlots, his swine- herding and hungering for the husks they ate, beautiful and holy moments in his life. It is difficult for most people to grasp the idea. I dare say one has to go to prison to understand it. If so, it may be worth while going to prison.
There is something so unique about Christ. Of course just as there are false dawns before the dawn itself, and winter days so full of sudden sunlight that they will cheat the wise crocus into squandering its gold before its time, and make some foolish bird call to its mate to build on barren boughs, so there were Christians before Christ. For that we should be grateful. The unfortunate thing is that there have been none since. I make one exception, St. Francis of Assisi. But then God had given him at his birth the soul of a poet, as he himself when quite young had in mystical marriage taken poverty as his bride: and with the soul of a poet and the body of a beggar he found the way to perfection not difficult. He understood Christ, and so he became like him. We do not require the Liber Conformitatum to teach us that the life of St. Francis was the true _Imitatio Christi_, a poem compared to which the book of that name is merely prose.
Indeed, that is the charm about Christ, when all is said: he is just like a work of art. He does not really teach one anything, but by being brought into his presence one becomes something. And everybody is predestined to his presence. Once at least in his life each man walks with Christ to Emmaus.
As regards the other subject, the Relation of the Artistic Life to Conduct, it will no doubt seem strange to you that I should select it. People point to Reading Gaol and say, 'That is where the artistic life leads a man.' Well, it might lead to worse places. The more mechanical people to whom life is a shrewd speculation depending on a careful calculation of ways and means, always know where they are going, and go there. They start with the ideal desire of being the parish beadle, and in whatever sphere they are placed they succeed in being the parish beadle and no more. A man whose desire is to be something separate from himself, to be a member of Parliament, or a successful grocer, or a prominent solicitor, or a judge, or something equally tedious, invariably succeeds in being what he wants to be. That is his punishment. Those who want a mask have to wear it.
But with the dynamic forces of life, and those in whom those dynamic forces become incarnate, it is different. People whose desire is solely for self-realisation never know where they are going. They can't know. In one sense of the word it is of course necessary, as the Greek oracle said, to know oneself: that is the first achievement of knowledge. But to recognise that the soul of a man is unknowable, is the ultimate achievement of wisdom. The final mystery is oneself. When one has weighed the sun in the balance, and measured the steps of the moon, and mapped out the seven heavens star by star, there still remains oneself. Who can calculate the orbit of his own soul? When the son went out to look for his father's asses, he did not know that a man of God was waiting for him with the very chrism of coronation, and that his own soul was already the soul of a king.
I hope to live long enough and to produce work of such a character that I shall be able at the end of my days to say, 'Yes! this is just where the artistic life leads a man!' Two of the most perfect lives I have come across in my own experience are the lives of Verlaine and of Prince Kropotkin: both of them men who have passed years in prison: the first, the one Christian poet since Dante; the other, a man with a soul of that beautiful white Christ which seems coming out of Russia. And for the last seven or eight months, in spite of a succession of great troubles reaching me from the outside world almost without intermission, I have been placed in direct contact with a new spirit working in this prison through man and things, that has helped me beyond any possibility of expression in words: so that while for the first year of my imprisonment I did nothing else, and can remember doing nothing else, but wring my hands in impotent despair, and say, 'What an ending, what an appalling ending!' now I try to say to myself, and sometimes when I am not torturing myself do really and sincerely say, 'What a beginning, what a wonderful beginning!' It may really be so. It may become so. If it does I shall owe much to this new personality that has altered every man's life in this place.
You may realise it when I say that had I been released last May, as I tried to be, I would have left this place loathing it and every official in it with a bitterness of hatred that would have poisoned my life. I have had a year longer of imprisonment, but humanity has been in the prison along with us all, and now when I go out I shall always remember great kindnesses that I have received here from almost everybody, and on the day of my release I shall give many thanks to many people, and ask to be remembered by them in turn.
The prison style is absolutely and entirely wrong. I would give anything to be able to alter it when I go out. I intend to try. But there is nothing in the world so wrong but that the spirit of humanity, which is the spirit of love, the spirit of the Christ who is not in churches, may make it, if not right, at least possible to be borne without too much bitterness of heart.
I know also that much is waiting for me outside that is very delightful, from what St. Francis of Assisi calls 'my brother the wind, and my sister the rain,' lovely things both of them, down to the shop-windows and sunsets of great cities. If I made a list of all that still remains to me, I don't know where I should stop: for, indeed, God made the world just as much for me as for any one else. Perhaps I may go out with something that I had not got before. I need not tell you that to me reformations in morals are as meaningless and vulgar as Reformations in theology. But while to propose to be a better man is a piece of unscientific cant, to have become a deeper man is the privilege of those who have suffered. And such I think I have become.
If after I am free a friend of mine gave a feast, and did not invite me to it, I should not mind a bit. I can be perfectly happy by myself. With freedom, flowers, books, and the moon, who could not be perfectly happy? Besides, feasts are not for me any more. I have given too many to care about them. That side of life is over for me, very fortunately, I dare say. But if after I am free a friend of mine had a sorrow and refused to allow me to share it, I should feel it most bitterly. If he shut the doors of the house of mourning against me, I would come back again and again and beg to be admitted, so that I might share in what I was entitled to share in. If he thought me unworthy, unfit to weep with him, I should feel it as the most poignant humiliation, as the most terrible mode in which disgrace could be inflicted on me. But that could not be. I have a right to share in sorrow, and he who can look at the loveliness of the world and share its sorrow, and realise something of the wonder of both, is in immediate contact with divine things, and has got as near to God's secret as any one can get.
Perhaps there may come into my art also, no less than into my life, a still deeper note, one of greater unity of passion, and directness of impulse. Not width but intensity is the true aim of modern art. We are no longer in art concerned with the type. It is with the exception that we have to do. I cannot put my sufferings into any form they took, I need hardly say. Art only begins where Imitation ends, but something must come into my work, of fuller memory of words perhaps, of richer cadences, of more curious effects, of simpler architectural order, of some aesthetic quality at any rate.
When Marsyas was 'torn from the scabbard of his limbs'--_della vagina della membre sue_, to use one of Dante's most terrible Tacitean phrases--he had no more song, the Greek said. Apollo had been victor. The lyre had vanquished the reed. But perhaps the Greeks were mistaken. I hear in much modern Art the cry of Marsyas. It is bitter in Baudelaire, sweet and plaintive in Lamartine, mystic in Verlaine. It is in the deferred resolutions of Chopin's music. It is in the discontent that haunts Burne-Jones's women. Even Matthew Arnold, whose song of Callicles tells of 'the triumph of the sweet persuasive lyre,' and the 'famous final victory,' in such a clear note of lyrical beauty, has not a little of it; in the troubled undertone of doubt and distress that haunts his verses, neither Goethe nor Wordsworth could help him, though he followed each in turn, and when he seeks to mourn for _Thyrsis_ or to sing of the _Scholar Gipsy_, it is the reed that he has to take for the rendering of his strain. But whether or not the Phrygian Faun was silent, I cannot be. Expression is as necessary to me as leaf and blossoms are to the black branches of the trees that show themselves above the prison walls and are so restless in the wind. Between my art and the world there is now a wide gulf, but between art and myself there is none. I hope at least that there is none.
To each of us different fates are meted out. My lot has been one of public infamy, of long imprisonment, of misery, of ruin, of disgrace, but I am not worthy of it--not yet, at any rate. I remember that I used to say that I thought I could bear a real tragedy if it came to me with purple pall and a mask of noble sorrow, but that the dreadful thing about modernity was that it put tragedy into the raiment of comedy, so that the great realities seemed commonplace or grotesque or lacking in style. It is quite true about modernity. It has probably always been true about actual life. It is said that all martyrdoms seemed mean to the looker on. The nineteenth century is no exception to the rule.
Everything about my tragedy has been hideous, mean, repellent, lacking in style; our very dress makes us grotesque. We are the zanies of sorrow. We are clowns whose hearts are broken. We are specially designed to appeal to the sense of humour. On November 13th, 1895, I was brought down here from London. From two o'clock till half-past two on that day I had to stand on the centre platform of Clapham Junction in convict dress, and handcuffed, for the world to look at. I had been taken out of the hospital ward without a moment's notice being given to me. Of all possible objects I was the most grotesque. When people saw me they laughed. Each train as it came up swelled the audience. Nothing could exceed their amusement. That was, of course, before they knew who I was. As soon as they had been informed they laughed still more. For half an hour I stood there in the grey November rain surrounded by a jeering mob.
For a year after that was done to me I wept every day at the same hour and for the same space of time. That is not such a tragic thing as possibly it sounds to you. To those who are in prison tears are a part of every day's experience. A day in prison on which one does not weep is a day on which one's heart is hard, not a day on which one's heart is happy.
Well, now I am really beginning to feel more regret for the people who laughed than for myself. Of course when they saw me I was not on my pedestal, I was in the pillory. But it is a very unimaginative nature that only cares for people on their pedestals. A pedestal may be a very unreal thing. A pillory is a terrific reality. They should have known also how to interpret sorrow better. I have said that behind sorrow there is always sorrow. It were wiser still to say that behind sorrow there is always a soul. And to mock at a soul in pain is a dreadful thing. In the strangely simple economy of the world people only get what they give, and to those who have not enough imagination to penetrate the mere outward of things, and feel pity, what pity can be given save that of scorn?
I write this account of the mode of my being transferred here simply that it should be realised how hard it has been for me to get anything out of my punishment but bitterness and despair. I have, however, to do it, and now and then I have moments of submission and acceptance. All the spring may be hidden in the single bud, and the low ground nest of the lark may hold the joy that is to herald the feet of many rose-red dawns. So perhaps whatever beauty of life still remains to me is contained in some moment of surrender, abasement, and humiliation. I can, at any rate, merely proceed on the lines of my own development, and, accepting all that has happened to me, make myself worthy of it.
People used to say of me that I was too individualistic. I must be far more of an individualist than ever I was. I must get far more out of myself than ever I got, and ask far less of the world than ever I asked. Indeed, my ruin came not from too great individualism of life, but from too little. The one disgraceful, unpardonable, and to all time contemptible action of my life was to allow myself to appeal to society for help and protection. To have made such an appeal would have been from the individualist point of view bad enough, but what excuse can there ever be put forward for having made it? Of course once I had put into motion the forces of society, society turned on me and said, 'Have you been living all this time in defiance of my laws, and do you now appeal to those laws for protection? You shall have those laws exercised to the full. You shall abide by what you have appealed to.' The result is I am in gaol. Certainly no man ever fell so ignobly, and by such ignoble instruments, as I did.
The Philistine element in life is not the failure to understand art. Charming people, such as fishermen, shepherds, ploughboys, peasants and the like, know nothing about art, and are the very salt of the earth. He is the Philistine who upholds and aids the heavy, cumbrous, blind, mechanical forces of society, and who does not recognise dynamic force when he meets it either in a man or a movement.
People thought it dreadful of me to have entertained at dinner the evil things of life, and to have found pleasure in their company. But then, from the point of view through which I, as an artist in life, approach them they were delightfully suggestive and stimulating. The danger was half the excitement. . . . My business as an artist was with Ariel. I set myself to wrestle with Caliban. . . .
A great friend of mine--a friend of ten years' standing--came to see me some time ago, and told me that he did not believe a single word of what was said against me, and wished me to know that he considered me quite innocent, and the victim of a hideous plot. I burst into tears at what he said, and told him that while there was much amongst the definite charges that was quite untrue and transferred to me by revolting malice, still that my life had been full of perverse pleasures, and that unless he accepted that as a fact about me and realised it to the full I could not possibly be friends with him any more, or ever be in his company. It was a terrible shock to him, but we are friends, and I have not got his friendship on false pretences.
Emotional forces, as I say somewhere in _Intentions_, are as limited in extent and duration as the forces of physical energy. The little cup that is made to hold so much can hold so much and no more, though all the purple vats of Burgundy be filled with wine to the brim, and the treaders stand knee-deep in the gathered grapes of the stony vineyards of Spain. There is no error more common than that of thinking that those who are the causes or occasions of great tragedies share in the feelings suitable to the tragic mood: no error more fatal than expecting it of them. The martyr in his 'shirt of flame' may be looking on the face of God, but to him who is piling the faggots or loosening the logs for the blast the whole scene is no more than the slaying of an ox is to the butcher, or the felling of a tree to the charcoal burner in the forest, or the fall of a flower to one who is mowing down the grass with a scythe. Great passions are for the great of soul, and great events can be seen only by those who are on a level with them.
* * * * *
I know of nothing in all drama more incomparable from the point of view of art, nothing more suggestive in its subtlety of observation, than Shakespeare's drawing of Rosencrantz and Guildenstern. They are Hamlet's college friends. They have been his companions. They bring with them memories of pleasant days together. At the moment when they come across him in the play he is staggering under the weight of a burden intolerable to one of his temperament. The dead have come armed out of the grave to impose on him a mission at once too great and too mean for him. He is a dreamer, and he is called upon to act. He has the nature of the poet, and he is asked to grapple with the common complexity of cause and effect, with life in its practical realisation, of which he knows nothing, not with life in its ideal essence, of which he knows so much. He has no conception of what to do, and his folly is to feign folly. Brutus used madness as a cloak to conceal the sword of his purpose, the dagger of his will, but the Hamlet madness is a mere mask for the hiding of weakness. In the making of fancies and jests he sees a chance of delay. He keeps playing with action as an artist plays with a theory. He makes himself the spy of his proper actions, and listening to his own words knows them to be but 'words, words, words.' Instead of trying to be the hero of his own history, he seeks to be the spectator of his own tragedy. He disbelieves in everything, including himself, and yet his doubt helps him not, as it comes not from scepticism but from a divided will.
Of all this Guildenstern and Rosencrantz realise nothing. They bow and smirk and smile, and what the one says the other echoes with sickliest intonation. When, at last, by means of the play within the play, and the puppets in their dalliance, Hamlet 'catches the conscience' of the King, and drives the wretched man in terror from his throne, Guildenstern and Rosencrantz see no more in his conduct than a rather painful breach of Court etiquette. That is as far as they can attain to in 'the contemplation of the spectacle of life with appropriate emotions.' They are close to his very secret and know nothing of it. Nor would there be any use in telling them. They are the little cups that can hold so much and no more. Towards the close it is suggested that, caught in a cunning spring set for another, they have met, or may meet, with a violent and sudden death. But a tragic ending of this kind, though touched by Hamlet's humour with something of the surprise and justice of comedy, is really not for such as they. They never die. Horatio, who in order to 'report Hamlet and his cause aright to the unsatisfied,'
'Absents him from felicity a while, And in this harsh world draws his breath in pain,'
dies, but Guildenstern and Rosencrantz are as immortal as Angelo and Tartuffe, and should rank with them. They are what modern life has contributed to the antique ideal of friendship. He who writes a new _De Amicitia_ must find a niche for them, and praise them in Tusculan prose. They are types fixed for all time. To censure them would show 'a lack of appreciation.' They are merely out of their sphere: that is all. In sublimity of soul there is no contagion. High thoughts and high emotions are by their very existence isolated.
* * * * *
I am to be released, if all goes well with me, towards the end of May, and hope to go at once to some little sea-side village abroad with R--- and M---.
The sea, as Euripides says in one of his plays about Iphigeneia, washes away the stains and wounds of the world.
I hope to be at least a month with my friends, and to gain peace and balance, and a less troubled heart, and a sweeter mood. I have a strange longing for the great simple primeval things, such as the sea, to me no less of a mother than the Earth. It seems to me that we all look at Nature too much, and live with her too little. I discern great sanity in the Greek attitude. They never chattered about sunsets, or discussed whether the shadows on the grass were really mauve or not. But they saw that the sea was for the swimmer, and the sand for the feet of the runner. They loved the trees for the shadow that they cast, and the forest for its silence at noon. The vineyard-dresser wreathed his hair with ivy that he might keep off the rays of the sun as he stooped over the young shoots, and for the artist and the athlete, the two types that Greece gave us, they plaited with garlands the leaves of the bitter laurel and of the wild parsley, which else had been of no service to men.
We call ours a utilitarian age, and we do not know the uses of any single thing. We have forgotten that water can cleanse, and fire purify, and that the Earth is mother to us all. As a consequence our art is of the moon and plays with shadows, while Greek art is of the sun and deals directly with things. I feel sure that in elemental forces there is purification, and I want to go back to them and live in their presence.
Of course to one so modern as I am, 'Enfant de mon siecle,' merely to look at the world will be always lovely. I tremble with pleasure when I think that on the very day of my leaving prison both the laburnum and the lilac will be blooming in the gardens, and that I shall see the wind stir into restless beauty the swaying gold of the one, and make the other toss the pale purple of its plumes, so that all the air shall be Arabia for me. Linnaeus fell on his knees and wept for joy when he saw for the first time the long heath of some English upland made yellow with the tawny aromatic brooms of the common furze; and I know that for me, to whom flowers are part of desire, there are tears waiting in the petals of some rose. It has always been so with me from my boyhood. There is not a single colour hidden away in the chalice of a flower, or the curve of a shell, to which, by some subtle sympathy with the very soul of things, my nature does not answer. Like Gautier, I have always been one of those 'pour qui le monde visible existe.'
Still, I am conscious now that behind all this beauty, satisfying though it may be, there is some spirit hidden of which the painted forms and shapes are but modes of manifestation, and it is with this spirit that I desire to become in harmony. I have grown tired of the articulate utterances of men and things. The Mystical in Art, the Mystical in Life, the Mystical in Nature this is what I am looking for. It is absolutely necessary for me to find it somewhere.
All trials are trials for one's life, just as all sentences are sentences of death; and three times have I been tried. The first time I left the box to be arrested, the second time to be led back to the house of detention, the third time to pass into a prison for two years. Society, as we have constituted it, will have no place for me, has none to offer; but Nature, whose sweet rains fall on unjust and just alike, will have clefts in the rocks where I may hide, and secret valleys in whose silence I may weep undisturbed. She will hang the night with stars so that I may walk abroad in the darkness without stumbling, and send the wind over my footprints so that none may track me to my hurt: she will cleanse me in great waters, and with bitter herbs make me whole.
. . . Suffering is one very long moment. We cannot divide it by seasons. We can only record its moods, and chronicle their return. With us time itself does not progress. It revolves. It seems to circle round one centre of pain. The paralysing immobility of a life every circumstance of which is regulated after an unchangeable pattern, so that we eat and drink and lie down and pray, or kneel at least for prayer, according to the inflexible laws of an iron formula: this immobile quality, that makes each dreadful day in the very minutest detail like its brother, seems to communicate itself to those external forces the very essence of whose existence is ceaseless change. Of seed-time or harvest, of the reapers bending over the corn, or the grape gatherers threading through the vines, of the grass in the orchard made white with broken blossoms or strewn with fallen fruit: of these we know nothing and can know nothing.
For us there is only one season, the season of sorrow. The very sun and moon seem taken from us. Outside, the day may be blue and gold, but the light that creeps down through the thickly-muffled glass of the small iron-barred window beneath which one sits is grey and niggard. It is always twilight in one's cell, as it is always twilight in one's heart. And in the sphere of thought, no less than in the sphere of time, motion is no more. The thing that you personally have long ago forgotten, or can easily forget, is happening to me now, and will happen to me again to- morrow. Remember this, and you will be able to understand a little of why I am writing, and in this manner writing. . . .
A week later, I am transferred here. Three more months go over and my mother dies. No one knew how deeply I loved and honoured her. Her death was terrible to me; but I, once a lord of language, have no words in which to express my anguish and my shame. She and my father had bequeathed me a name they had made noble and honoured, not merely in literature, art, archaeology, and science, but in the public history of my own country, in its evolution as a nation. I had disgraced that name eternally. I had made it a low by-word among low people. I had dragged it through the very mire. I had given it to brutes that they might make it brutal, and to fools that they might turn it into a synonym for folly. What I suffered then, and still suffer, is not for pen to write or paper to record. My wife, always kind and gentle to me, rather than that I should hear the news from indifferent lips, travelled, ill as she was, all the way from Genoa to England to break to me herself the tidings of so irreparable, so irremediable, a loss. Messages of sympathy reached me from all who had still affection for me. Even people who had not known me personally, hearing that a new sorrow had broken into my life, wrote to ask that some expression of their condolence should be conveyed to me. . . .
Three months go over. The calendar of my daily conduct and labour that hangs on the outside of my cell door, with my name and sentence written upon it, tells me that it is May. . . .
Prosperity, pleasure and success, may be rough of grain and common in fibre, but sorrow is the most sensitive of all created things. There is nothing that stirs in the whole world of thought to which sorrow does not vibrate in terrible and exquisite pulsation. The thin beaten-out leaf of tremulous gold that chronicles the direction of forces the eye cannot see is in comparison coarse. It is a wound that bleeds when any hand but that of love touches it, and even then must bleed again, though not in pain.
Where there is sorrow there is holy ground. Some day people will realise what that means. They will know nothing of life till they do,--and natures like his can realise it. When I was brought down from my prison to the Court of Bankruptcy, between two policemen,--waited in the long dreary corridor that, before the whole crowd, whom an action so sweet and simple hushed into silence, he might gravely raise his hat to me, as, handcuffed and with bowed head, I passed him by. Men have gone to heaven for smaller things than that. It was in this spirit, and with this mode of love, that the saints knelt down to wash the feet of the poor, or stooped to kiss the leper on the cheek. I have never said one single word to him about what he did. I do not know to the present moment whether he is aware that I was even conscious of his action. It is not a thing for which one can render formal thanks in formal words. I store it in the treasure-house of my heart. I keep it there as a secret debt that I am glad to think I can never possibly repay. It is embalmed and kept sweet by the myrrh and cassia of many tears. When wisdom has been profitless to me, philosophy barren, and the proverbs and phrases of those who have sought to give me consolation as dust and ashes in my mouth, the memory of that little, lovely, silent act of love has unsealed for me all the wells of pity: made the desert blossom like a rose, and brought me out of the bitterness of lonely exile into harmony with the wounded, broken, and great heart of the world. When people are able to understand, not merely how beautiful ---'s action was, but why it meant so much to me, and always will mean so much, then, perhaps, they will realise how and in what spirit they should approach me. . . .
The poor are wise, more charitable, more kind, more sensitive than we are. In their eyes prison is a tragedy in a man's life, a misfortune, a casuality, something that calls for sympathy in others. They speak of one who is in prison as of one who is 'in trouble' simply. It is the phrase they always use, and the expression has the perfect wisdom of love in it. With people of our own rank it is different. With us, prison makes a man a pariah. I, and such as I am, have hardly any right to air and sun. Our presence taints the pleasures of others. We are unwelcome when we reappear. To revisit the glimpses of the moon is not for us. Our very children are taken away. Those lovely links with humanity are broken. We are doomed to be solitary, while our sons still live. We are denied the one thing that might heal us and keep us, that might bring balm to the bruised heart, and peace to the soul in pain. . . .
I must say to myself that I ruined myself, and that nobody great or small can be ruined except by his own hand. I am quite ready to say so. I am trying to say so, though they may not think it at the present moment. This pitiless indictment I bring without pity against myself. Terrible as was what the world did to me, what I did to myself was far more terrible still.
I was a man who stood in symbolic relations to the art and culture of my age. I had realised this for myself at the very dawn of my manhood, and had forced my age to realise it afterwards. Few men hold such a position in their own lifetime, and have it so acknowledged. It is usually discerned, if discerned at all, by the historian, or the critic, long after both the man and his age have passed away. With me it was different. I felt it myself, and made others feel it. Byron was a symbolic figure, but his relations were to the passion of his age and its weariness of passion. Mine were to something more noble, more permanent, of more vital issue, of larger scope.
The gods had given me almost everything. But I let myself be lured into long spells of senseless and sensual ease. I amused myself with being a _flaneur_, a dandy, a man of fashion. I surrounded myself with the smaller natures and the meaner minds. I became the spendthrift of my own genius, and to waste an eternal youth gave me a curious joy. Tired of being on the heights, I deliberately went to the depths in the search for new sensation. What the paradox was to me in the sphere of thought, perversity became to me in the sphere of passion. Desire, at the end, was a malady, or a madness, or both. I grew careless of the lives of others. I took pleasure where it pleased me, and passed on. I forgot that every little action of the common day makes or unmakes character, and that therefore what one has done in the secret chamber one has some day to cry aloud on the housetop. I ceased to be lord over myself. I was no longer the captain of my soul, and did not know it. I allowed pleasure to dominate me. I ended in horrible disgrace. There is only one thing for me now, absolute humility.
I have lain in prison for nearly two years. Out of my nature has come wild despair; an abandonment to grief that was piteous even to look at; terrible and impotent rage; bitterness and scorn; anguish that wept aloud; misery that could find no voice; sorrow that was dumb. I have passed through every possible mood of suffering. Better than Wordsworth himself I know what Wordsworth meant when he said--
'Suffering is permanent, obscure, and dark And has the nature of infinity.'
But while there were times when I rejoiced in the idea that my sufferings were to be endless, I could not bear them to be without meaning. Now I find hidden somewhere away in my nature something that tells me that nothing in the whole world is meaningless, and suffering least of all. That something hidden away in my nature, like a treasure in a field, is Humility.
It is the last thing left in me, and the best: the ultimate discovery at which I have arrived, the starting-point for a fresh development. It has come to me right out of myself, so I know that it has come at the proper time. It could not have come before, nor later. Had any one told me of it, I would have rejected it. Had it been brought to me, I would have refused it. As I found it, I want to keep it. I must do so. It is the one thing that has in it the elements of life, of a new life, _Vita Nuova_ for me. Of all things it is the strangest. One cannot acquire it, except by surrendering everything that one has. It is only when one has lost all things, that one knows that one possesses it.
Now I have realised that it is in me, I see quite clearly what I ought to do; in fact, must do. And when I use such a phrase as that, I need not say that I am not alluding to any external sanction or command. I admit none. I am far more of an individualist than I ever was. Nothing seems to me of the smallest value except what one gets out of oneself. My nature is seeking a fresh mode of self-realisation. That is all I am concerned with. And the first thing that I have got to do is to free myself from any possible bitterness of feeling against the world.
I am completely penniless, and absolutely homeless. Yet there are worse things in the world than that. I am quite candid when I say that rather than go out from this prison with bitterness in my heart against the world, I would gladly and readily beg my bread from door to door. If I got nothing from the house of the rich I would get something at the house of the poor. Those who have much are often greedy; those who have little always share. I would not a bit mind sleeping in the cool grass in summer, and when winter came on sheltering myself by the warm close-thatched rick, or under the penthouse of a great barn, provided I had love in my heart. The external things of life seem to me now of no importance at all. You can see to what intensity of individualism I have arrived--or am arriving rather, for the journey is long, and 'where I walk there are thorns.'
Of course I know that to ask alms on the highway is not to be my lot, and that if ever I lie in the cool grass at night-time it will be to write sonnets to the moon. When I go out of prison, R--- will be waiting for me on the other side of the big iron-studded gate, and he is the symbol, not merely of his own affection, but of the affection of many others besides. I believe I am to have enough to live on for about eighteen months at any rate, so that if I may not write beautiful books, I may at least read beautiful books; and what joy can be greater? After that, I hope to be able to recreate my creative faculty.
But were things different: had I not a friend left in the world; were there not a single house open to me in pity; had I to accept the wallet and ragged cloak of sheer penury: as long as I am free from all resentment, hardness and scorn, I would be able to face the life with much more calm and confidence than I would were my body in purple and fine linen, and the soul within me sick with hate.
And I really shall have no difficulty. When you really want love you will find it waiting for you.
I need not say that my task does not end there. It would be comparatively easy if it did. There is much more before me. I have hills far steeper to climb, valleys much darker to pass through. And I have to get it all out of myself. Neither religion, morality, nor reason can help me at all.
Morality does not help me. I am a born antinomian. I am one of those who are made for exceptions, not for laws. But while I see that there is nothing wrong in what one does, I see that there is something wrong in what one becomes. It is well to have learned that.
Religion does not help me. The faith that others give to what is unseen, I give to what one can touch, and look at. My gods dwell in temples made with hands; and within the circle of actual experience is my creed made perfect and complete: too complete, it may be, for like many or all of those who have placed their heaven in this earth, I have found in it not merely the beauty of heaven, but the horror of hell also. When I think about religion at all, I feel as if I would like to found an order for those who _cannot_ believe: the Confraternity of the Faithless, one might call it, where on an altar, on which no taper burned, a priest, in whose heart peace had no dwelling, might celebrate with unblessed bread and a chalice empty of wine. Every thing to be true must become a religion. And agnosticism should have its ritual no less than faith. It has sown its martyrs, it should reap its saints, and praise God daily for having hidden Himself from man. But whether it be faith or agnosticism, it must be nothing external to me. Its symbols must be of my own creating. Only that is spiritual which makes its own form. If I may not find its secret within myself, I shall never find it: if I have not got it already, it will never come to me.
Reason does not help me. It tells me that the laws under which I am convicted are wrong and unjust laws, and the system under which I have suffered a wrong and unjust system. But, somehow, I have got to make both of these things just and right to me. And exactly as in Art one is only concerned with what a particular thing is at a particular moment to oneself, so it is also in the ethical evolution of one's character. I have got to make everything that has happened to me good for me. The plank bed, the loathsome food, the hard ropes shredded into oakum till one's finger-tips grow dull with pain, the menial offices with which each day begins and finishes, the harsh orders that routine seems to necessitate, the dreadful dress that makes sorrow grotesque to look at, the silence, the solitude, the shame--each and all of these things I have to transform into a spiritual experience. There is not a single degradation of the body which I must not try and make into a spiritualising of the soul.
I want to get to the point when I shall be able to say quite simply, and without affectation that the two great turning-points in my life were when my father sent me to Oxford, and when society sent me to prison. I will not say that prison is the best thing that could have happened to me: for that phrase would savour of too great bitterness towards myself. I would sooner say, or hear it said of me, that I was so typical a child of my age, that in my perversity, and for that perversity's sake, I turned the good things of my life to evil, and the evil things of my life to good.
What is said, however, by myself or by others, matters little. The important thing, the thing that lies before me, the thing that I have to do, if the brief remainder of my days is not to be maimed, marred, and incomplete, is to absorb into my nature all that has been done to me, to make it part of me, to accept it without complaint, fear, or reluctance. The supreme vice is shallowness. Whatever is realised is right.
When first I was put into prison some people advised me to try and forget who I was. It was ruinous advice. It is only by realising what I am that I have found comfort of any kind. Now I am advised by others to try on my release to forget that I have ever been in a prison at all. I know that would be equally fatal. It would mean that I would always be haunted by an intolerable sense of disgrace, and that those things that are meant for me as much as for anybody else--the beauty of the sun and moon, the pageant of the seasons, the music of daybreak and the silence of great nights, the rain falling through the leaves, or the dew creeping over the grass and making it silver--would all be tainted for me, and lose their healing power, and their power of communicating joy. To regret one's own experiences is to arrest one's own development. To deny one's own experiences is to put a lie into the lips of one's own life. It is no less than a denial of the soul.
For just as the body absorbs things of all kinds, things common and unclean no less than those that the priest or a vision has cleansed, and converts them into swiftness or strength, into the play of beautiful muscles and the moulding of fair flesh, into the curves and colours of the hair, the lips, the eye; so the soul in its turn has its nutritive functions also, and can transform into noble moods of thought and passions of high import what in itself is base, cruel and degrading; nay, more, may find in these its most august modes of assertion, and can often reveal itself most perfectly through what was intended to desecrate or destroy.
The fact of my having been the common prisoner of a common gaol I must frankly accept, and, curious as it may seem, one of the things I shall have to teach myself is not to be ashamed of it. I must accept it as a punishment, and if one is ashamed of having been punished, one might just as well never have been punished at all. Of course there are many things of which I was convicted that I had not done, but then there are many things of which I was convicted that I had done, and a still greater number of things in my life for which I was never indicted at all. And as the gods are strange, and punish us for what is good and humane in us as much as for what is evil and perverse, I must accept the fact that one is punished for the good as well as for the evil that one does. I have no doubt that it is quite right one should be. It helps one, or should help one, to realise both, and not to be too conceited about either. And if I then am not ashamed of my punishment, as I hope not to be, I shall be able to think, and walk, and live with freedom.
Many men on their release carry their prison about with them into the air, and hide it as a secret disgrace in their hearts, and at length, like poor poisoned things, creep into some hole and die. It is wretched that they should have to do so, and it is wrong, terribly wrong, of society that it should force them to do so. Society takes upon itself the right to inflict appalling punishment on the individual, but it also has the supreme vice of shallowness, and fails to realise what it has done. When the man's punishment is over, it leaves him to himself; that is to say, it abandons him at the very moment when its highest duty towards him begins. It is really ashamed of its own actions, and shuns those whom it has punished, as people shun a creditor whose debt they cannot pay, or one on whom they have inflicted an irreparable, an irremediable wrong. I can claim on my side that if I realise what I have suffered, society should realise what it has inflicted on me; and that there should be no bitterness or hate on either side.
Of course I know that from one point of view things will be made different for me than for others; must indeed, by the very nature of the case, be made so. The poor thieves and outcasts who are imprisoned here with me are in many respects more fortunate than I am. The little way in grey city or green field that saw their sin is small; to find those who know nothing of what they have done they need go no further than a bird might fly between the twilight and the dawn; but for me the world is shrivelled to a handsbreadth, and everywhere I turn my name is written on the rocks in lead. For I have come, not from obscurity into the momentary notoriety of crime, but from a sort of eternity of fame to a sort of eternity of infamy, and sometimes seem to myself to have shown, if indeed it required showing, that between the famous and the infamous there is but one step, if as much as one.
Still, in the very fact that people will recognise me wherever I go, and know all about my life, as far as its follies go, I can discern something good for me. It will force on me the necessity of again asserting myself as an artist, and as soon as I possibly can. If I can produce only one beautiful work of art I shall be able to rob malice of its venom, and cowardice of its sneer, and to pluck out the tongue of scorn by the roots.
And if life be, as it surely is, a problem to me, I am no less a problem to life. People must adopt some attitude towards me, and so pass judgment, both on themselves and me. I need not say I am not talking of particular individuals. The only people I would care to be with now are artists and people who have suffered: those who know what beauty is, and those who know what sorrow is: nobody else interests me. Nor am I making any demands on life. In all that I have said I am simply concerned with my own mental attitude towards life as a whole; and I feel that not to be ashamed of having been punished is one of the first points I must attain to, for the sake of my own perfection, and because I am so imperfect.
Then I must learn how to be happy. Once I knew it, or thought I knew it, by instinct. It was always springtime once in my heart. My temperament was akin to joy. I filled my life to the very brim with pleasure, as one might fill a cup to the very brim with wine. Now I am approaching life from a completely new standpoint, and even to conceive happiness is often extremely difficult for me. I remember during my first term at Oxford reading in Pater's _Renaissance_--that book which has had such strange influence over my life--how Dante places low in the Inferno those who wilfully live in sadness; and going to the college library and turning to the passage in the _Divine Comedy_ where beneath the dreary marsh lie those who were 'sullen in the sweet air,' saying for ever and ever through their sighs--
'Tristi fummo Nell aer dolce che dal sol s'allegra.'
I knew the church condemned _accidia_, but the whole idea seemed to me quite fantastic, just the sort of sin, I fancied, a priest who knew nothing about real life would invent. Nor could I understand how Dante, who says that 'sorrow remarries us to God,' could have been so harsh to those who were enamoured of melancholy, if any such there really were. I had no idea that some day this would become to me one of the greatest temptations of my life.
While I was in Wandsworth prison I longed to die. It was my one desire. When after two months in the infirmary I was transferred here, and found myself growing gradually better in physical health, I was filled with rage. I determined to commit suicide on the very day on which I left prison. After a time that evil mood passed away, and I made up my mind to live, but to wear gloom as a king wears purple: never to smile again: to turn whatever house I entered into a house of mourning: to make my friends walk slowly in sadness with me: to teach them that melancholy is the true secret of life: to maim them with an alien sorrow: to mar them with my own pain. Now I feel quite differently. I see it would be both ungrateful and unkind of me to pull so long a face that when my friends came to see me they would have to make their faces still longer in order to show their sympathy; or, if I desired to entertain them, to invite them to sit down silently to bitter herbs and funeral baked meats. I must learn how to be cheerful and happy.
The last two occasions on which I was allowed to see my friends here, I tried to be as cheerful as possible, and to show my cheerfulness, in order to make them some slight return for their trouble in coming all the way from town to see me. It is only a slight return, I know, but it is the one, I feel certain, that pleases them most. I saw R--- for an hour on Saturday week, and I tried to give the fullest possible expression of the delight I really felt at our meeting. And that, in the views and ideas I am here shaping for myself, I am quite right is shown to me by the fact that now for the first time since my imprisonment I have a real desire for life.
There is before me so much to do, that I would regard it as a terrible tragedy if I died before I was allowed to complete at any rate a little of it. I see new developments in art and life, each one of which is a fresh mode of perfection. I long to live so that I can explore what is no less than a new world to me. Do you want to know what this new world is? I think you can guess what it is. It is the world in which I have been living. Sorrow, then, and all that it teaches one, is my new world.
I used to live entirely for pleasure. I shunned suffering and sorrow of every kind. I hated both. I resolved to ignore them as far as possible: to treat them, that is to say, as modes of imperfection. They were not part of my scheme of life. They had no place in my philosophy. My mother, who knew life as a whole, used often to quote to me Goethe's lines--written by Carlyle in a book he had given her years ago, and translated by him, I fancy, also:--
'Who never ate his bread in sorrow, Who never spent the midnight hours Weeping and waiting for the morrow,-- He knows you not, ye heavenly powers.'
They were the lines which that noble Queen of Prussia, whom Napoleon treated with such coarse brutality, used to quote in her humiliation and exile; they were the lines my mother often quoted in the troubles of her later life. I absolutely declined to accept or admit the enormous truth hidden in them. I could not understand it. I remember quite well how I used to tell her that I did not want to eat my bread in sorrow, or to pass any night weeping and watching for a more bitter dawn.
I had no idea that it was one of the special things that the Fates had in store for me: that for a whole year of my life, indeed, I was to do little else. But so has my portion been meted out to me; and during the last few months I have, after terrible difficulties and struggles, been able to comprehend some of the lessons hidden in the heart of pain. Clergymen and people who use phrases without wisdom sometimes talk of suffering as a mystery. It is really a revelation. One discerns things one never discerned before. One approaches the whole of history from a different standpoint. What one had felt dimly, through instinct, about art, is intellectually and emotionally realised with perfect clearness of vision and absolute intensity of apprehension.
I now see that sorrow, being the supreme emotion of which man is capable, is at once the type and test of all great art. What the artist is always looking for is the mode of existence in which soul and body are one and indivisible: in which the outward is expressive of the inward: in which form reveals. Of such modes of existence there are not a few: youth and the arts preoccupied with youth may serve as a model for us at one moment: at another we may like to think that, in its subtlety and sensitiveness of impression, its suggestion of a spirit dwelling in external things and making its raiment of earth and air, of mist and city alike, and in its morbid sympathy of its moods, and tones, and colours, modern landscape art is realising for us pictorially what was realised in such plastic perfection by the Greeks. Music, in which all subject is absorbed in expression and cannot be separated from it, is a complex example, and a flower or a child a simple example, of what I mean; but sorrow is the ultimate type both in life and art.
Behind joy and laughter there may be a temperament, coarse, hard and callous. But behind sorrow there is always sorrow. Pain, unlike pleasure, wears no mask. Truth in art is not any correspondence between the essential idea and the accidental existence; it is not the resemblance of shape to shadow, or of the form mirrored in the crystal to the form itself; it is no echo coming from a hollow hill, any more than it is a silver well of water in the valley that shows the moon to the moon and Narcissus to Narcissus. Truth in art is the unity of a thing with itself: the outward rendered expressive of the inward: the soul made incarnate: the body instinct with spirit. For this reason there is no truth comparable to sorrow. There are times when sorrow seems to me to be the only truth. Other things may be illusions of the eye or the appetite, made to blind the one and cloy the other, but out of sorrow have the worlds been built, and at the birth of a child or a star there is pain.
More than this, there is about sorrow an intense, an extraordinary reality. I have said of myself that I was one who stood in symbolic relations to the art and culture of my age. There is not a single wretched man in this wretched place along with me who does not stand in symbolic relation to the very secret of life. For the secret of life is suffering. It is what is hidden behind everything. When we begin to live, what is sweet is so sweet to us, and what is bitter so bitter, that we inevitably direct all our desires towards pleasures, and seek not merely for a 'month or twain to feed on honeycomb,' but for all our years to taste no other food, ignorant all the while that we may really be starving the soul.
I remember talking once on this subject to one of the most beautiful personalities I have ever known: a woman, whose sympathy and noble kindness to me, both before and since the tragedy of my imprisonment, have been beyond power and description; one who has really assisted me, though she does not know it, to bear the burden of my troubles more than any one else in the whole world has, and all through the mere fact of her existence, through her being what she is--partly an ideal and partly an influence: a suggestion of what one might become as well as a real help towards becoming it; a soul that renders the common air sweet, and makes what is spiritual seem as simple and natural as sunlight or the sea: one for whom beauty and sorrow walk hand in hand, and have the same message. On the occasion of which I am thinking I recall distinctly how I said to her that there was enough suffering in one narrow London lane to show that God did not love man, and that wherever there was any sorrow, though but that of a child, in some little garden weeping over a fault that it had or had not committed, the whole face of creation was completely marred. I was entirely wrong. She told me so, but I could not believe her. I was not in the sphere in which such belief was to be attained to. Now it seems to me that love of some kind is the only possible explanation of the extraordinary amount of suffering that there is in the world. I cannot conceive of any other explanation. I am convinced that there is no other, and that if the world has indeed, as I have said, been built of sorrow, it has been built by the hands of love, because in no other way could the soul of man, for whom the world was made, reach the full stature of its perfection. Pleasure for the beautiful body, but pain for the beautiful soul.
When I say that I am convinced of these things I speak with too much pride. Far off, like a perfect pearl, one can see the city of God. It is so wonderful that it seems as if a child could reach it in a summer's day. And so a child could. But with me and such as me it is different. One can realise a thing in a single moment, but one loses it in the long hours that follow with leaden feet. It is so difficult to keep 'heights that the soul is competent to gain.' We think in eternity, but we move slowly through time; and how slowly time goes with us who lie in prison I need not tell again, nor of the weariness and despair that creep back into one's cell, and into the cell of one's heart, with such strange insistence that one has, as it were, to garnish and sweep one's house for their coming, as for an unwelcome guest, or a bitter master, or a slave whose slave it is one's chance or choice to be.
And, though at present my friends may find it a hard thing to believe, it is true none the less, that for them living in freedom and idleness and comfort it is more easy to learn the lessons of humility than it is for me, who begin the day by going down on my knees and washing the floor of my cell. For prison life with its endless privations and restrictions makes one rebellious. The most terrible thing about it is not that it breaks one's heart--hearts are made to be broken--but that it turns one's heart to stone. One sometimes feels that it is only with a front of brass and a lip of scorn that one can get through the day at all. And he who is in a state of rebellion cannot receive grace, to use the phrase of which the Church is so fond--so rightly fond, I dare say--for in life as in art the mood of rebellion closes up the channels of the soul, and shuts out the airs of heaven. Yet I must learn these lessons here, if I am to learn them anywhere, and must be filled with joy if my feet are on the right road and my face set towards 'the gate which is called beautiful,' though I may fall many times in the mire and often in the mist go astray.
This New Life, as through my love of Dante I like sometimes to call it, is of course no new life at all, but simply the continuance, by means of development, and evolution, of my former life. I remember when I was at Oxford saying to one of my friends as we were strolling round Magdalen's narrow bird-haunted walks one morning in the year before I took my degree, that I wanted to eat of the fruit of all the trees in the garden of the world, and that I was going out into the world with that passion in my soul. And so, indeed, I went out, and so I lived. My only mistake was that I confined myself so exclusively to the trees of what seemed to me the sun-lit side of the garden, and shunned the other side for its shadow and its gloom. Failure, disgrace, poverty, sorrow, despair, suffering, tears even, the broken words that come from lips in pain, remorse that makes one walk on thorns, conscience that condemns, self- abasement that punishes, the misery that puts ashes on its head, the anguish that chooses sack-cloth for its raiment and into its own drink puts gall:--all these were things of which I was afraid. And as I had determined to know nothing of them, I was forced to taste each of them in turn, to feed on them, to have for a season, indeed, no other food at all.
I don't regret for a single moment having lived for pleasure. I did it to the full, as one should do everything that one does. There was no pleasure I did not experience. I threw the pearl of my soul into a cup of wine. I went down the primrose path to the sound of flutes. I lived on honeycomb. But to have continued the same life would have been wrong because it would have been limiting. I had to pass on. The other half of the garden had its secrets for me also. Of course all this is foreshadowed and prefigured in my books. Some of it is in _The Happy Prince_, some of it in _The Young King_, notably in the passage where the bishop says to the kneeling boy, 'Is not He who made misery wiser than thou art'? a phrase which when I wrote it seemed to me little more than a phrase; a great deal of it is hidden away in the note of doom that like a purple thread runs through the texture of _Dorian Gray_; in _The Critic as Artist_ it is set forth in many colours; in _The Soul of Man_ it is written down, and in letters too easy to read; it is one of the refrains whose recurring _motifs_ make _Salome_ so like a piece of music and bind it together as a ballad; in the prose poem of the man who from the bronze of the image of the 'Pleasure that liveth for a moment' has to make the image of the 'Sorrow that abideth for ever' it is incarnate. It could not have been otherwise. At every single moment of one's life one is what one is going to be no less than what one has been. Art is a symbol, because man is a symbol.
It is, if I can fully attain to it, the ultimate realisation of the artistic life. For the artistic life is simply self-development. Humility in the artist is his frank acceptance of all experiences, just as love in the artist is simply the sense of beauty that reveals to the world its body and its soul. In _Marius the Epicurean_ Pater seeks to reconcile the artistic life with the life of religion, in the deep, sweet, and austere sense of the word. But Marius is little more than a spectator: an ideal spectator indeed, and one to whom it is given 'to contemplate the spectacle of life with appropriate emotions,' which Wordsworth defines as the poet's true aim; yet a spectator merely, and perhaps a little too much occupied with the comeliness of the benches of the sanctuary to notice that it is the sanctuary of sorrow that he is gazing at.
I see a far more intimate and immediate connection between the true life of Christ and the true life of the artist; and I take a keen pleasure in the reflection that long before sorrow had made my days her own and bound me to her wheel I had written in _The Soul of Man_ that he who would lead a Christ-like life must be entirely and absolutely himself, and had taken as my types not merely the shepherd on the hillside and the prisoner in his cell, but also the painter to whom the world is a pageant and the poet for whom the world is a song. I remember saying once to Andre Gide, as we sat together in some Paris _cafe_, that while meta-physics had but little real interest for me, and morality absolutely none, there was nothing that either Plato or Christ had said that could not be transferred immediately into the sphere of Art and there find its complete fulfilment.
Nor is it merely that we can discern in Christ that close union of personality with perfection which forms the real distinction between the classical and romantic movement in life, but the very basis of his nature was the same as that of the nature of the artist--an intense and flamelike imagination. He realised in the entire sphere of human relations that imaginative sympathy which in the sphere of Art is the sole secret of creation. He understood the leprosy of the leper, the darkness of the blind, the fierce misery of those who live for pleasure, the strange poverty of the rich. Some one wrote to me in trouble, 'When you are not on your pedestal you are not interesting.' How remote was the writer from what Matthew Arnold calls 'the Secret of Jesus.' Either would have taught him that whatever happens to another happens to oneself, and if you want an inscription to read at dawn and at night-time, and for pleasure or for pain, write up on the walls of your house in letters for the sun to gild and the moon to silver, 'Whatever happens to oneself happens to another.'
Christ's place indeed is with the poets. His whole conception of Humanity sprang right out of the imagination and can only be realised by it. What God was to the pantheist, man was to Him. He was the first to conceive the divided races as a unity. Before his time there had been gods and men, and, feeling through the mysticism of sympathy that in himself each had been made incarnate, he calls himself the Son of the one or the Son of the other, according to his mood. More than any one else in history he wakes in us that temper of wonder to which romance always appeals. There is still something to me almost incredible in the idea of a young Galilean peasant imagining that he could bear on his own shoulders the burden of the entire world; all that had already been done and suffered, and all that was yet to be done and suffered: the sins of Nero, of Caesar Borgia, of Alexander VI., and of him who was Emperor of Rome and Priest of the Sun: the sufferings of those whose names are legion and whose dwelling is among the tombs: oppressed nationalities, factory children, thieves, people in prison, outcasts, those who are dumb under oppression and whose silence is heard only of God; and not merely imagining this but actually achieving it, so that at the present moment all who come in contact with his personality, even though they may neither bow to his altar nor kneel before his priest, in some way find that the ugliness of their sin is taken away and the beauty of their sorrow revealed to them.
I had said of Christ that he ranks with the poets. That is true. Shelley and Sophocles are of his company. But his entire life also is the most wonderful of poems. For 'pity and terror' there is nothing in the entire cycle of Greek tragedy to touch it. The absolute purity of the protagonist raises the entire scheme to a height of romantic art from which the sufferings of Thebes and Pelops' line are by their very horror excluded, and shows how wrong Aristotle was when he said in his treatise on the drama that it would be impossible to bear the spectacle of one blameless in pain. Nor in AEschylus nor Dante, those stern masters of tenderness, in Shakespeare, the most purely human of all the great artists, in the whole of Celtic myth and legend, where the loveliness of the world is shown through a mist of tears, and the life of a man is no more than the life of a flower, is there anything that, for sheer simplicity of pathos wedded and made one with sublimity of tragic effect, can be said to equal or even approach the last act of Christ's passion. The little supper with his companions, one of whom has already sold him for a price; the anguish in the quiet moon-lit garden; the false friend coming close to him so as to betray him with a kiss; the friend who still believed in him, and on whom as on a rock he had hoped to build a house of refuge for Man, denying him as the bird cried to the dawn; his own utter loneliness, his submission, his acceptance of everything; and along with it all such scenes as the high priest of orthodoxy rending his raiment in wrath, and the magistrate of civil justice calling for water in the vain hope of cleansing himself of that stain of innocent blood that makes him the scarlet figure of history; the coronation ceremony of sorrow, one of the most wonderful things in the whole of recorded time; the crucifixion of the Innocent One before the eyes of his mother and of the disciple whom he loved; the soldiers gambling and throwing dice for his clothes; the terrible death by which he gave the world its most eternal symbol; and his final burial in the tomb of the rich man, his body swathed in Egyptian linen with costly spices and perfumes as though he had been a king's son. When one contemplates all this from the point of view of art alone one cannot but be grateful that the supreme office of the Church should be the playing of the tragedy without the shedding of blood: the mystical presentation, by means of dialogue and costume and gesture even, of the Passion of her Lord; and it is always a source of pleasure and awe to me to remember that the ultimate survival of the Greek chorus, lost elsewhere to art, is to be found in the servitor answering the priest at Mass.
Yet the whole life of Christ--so entirely may sorrow and beauty be made one in their meaning and manifestation--is really an idyll, though it ends with the veil of the temple being rent, and the darkness coming over the face of the earth, and the stone rolled to the door of the sepulchre. One always thinks of him as a young bridegroom with his companions, as indeed he somewhere describes himself; as a shepherd straying through a valley with his sheep in search of green meadow or cool stream; as a singer trying to build out of the music the walls of the City of God; or as a lover for whose love the whole world was too small. His miracles seem to me to be as exquisite as the coming of spring, and quite as natural. I see no difficulty at all in believing that such was the charm of his personality that his mere presence could bring peace to souls in anguish, and that those who touched his garments or his hands forgot their pain; or that as he passed by on the highway of life people who had seen nothing of life's mystery, saw it clearly, and others who had been deaf to every voice but that of pleasure heard for the first time the voice of love and found it as 'musical as Apollo's lute'; or that evil passions fled at his approach, and men whose dull unimaginative lives had been but a mode of death rose as it were from the grave when he called them; or that when he taught on the hillside the multitude forgot their hunger and thirst and the cares of this world, and that to his friends who listened to him as he sat at meat the coarse food seemed delicate, and the water had the taste of good wine, and the whole house became full of the odour and sweetness of nard.
Renan in his _Vie de Jesus_--that gracious fifth gospel, the gospel according to St. Thomas, one might call it--says somewhere that Christ's great achievement was that he made himself as much loved after his death as he had been during his lifetime. And certainly, if his place is among the poets, he is the leader of all the lovers. He saw that love was the first secret of the world for which the wise men had been looking, and that it was only through love that one could approach either the heart of the leper or the feet of God.
And above all, Christ is the most supreme of individualists. Humility, like the artistic, acceptance of all experiences, is merely a mode of manifestation. It is man's soul that Christ is always looking for. He calls it 'God's Kingdom,' and finds it in every one. He compares it to little things, to a tiny seed, to a handful of leaven, to a pearl. That is because one realises one's soul only by getting rid of all alien passions, all acquired culture, and all external possessions, be they good or evil.
I bore up against everything with some stubbornness of will and much rebellion of nature, till I had absolutely nothing left in the world but one thing. I had lost my name, my position, my happiness, my freedom, my wealth. I was a prisoner and a pauper. But I still had my children left. Suddenly they were taken away from me by the law. It was a blow so appalling that I did not know what to do, so I flung myself on my knees, and bowed my head, and wept, and said, 'The body of a child is as the body of the Lord: I am not worthy of either.' That moment seemed to save me. I saw then that the only thing for me was to accept everything. Since then--curious as it will no doubt sound--I have been happier. It was of course my soul in its ultimate essence that I had reached. In many ways I had been its enemy, but I found it waiting for me as a friend. When one comes in contact with the soul it makes one simple as a child, as Christ said one should be.
It is tragic how few people ever 'possess their souls' before they die. 'Nothing is more rare in any man,' says Emerson, 'than an act of his own.' It is quite true. Most people are other people. Their thoughts are some one else's opinions, their lives a mimicry, their passions a quotation. Christ was not merely the supreme individualist, but he was the first individualist in history. People have tried to make him out an ordinary philanthropist, or ranked him as an altruist with the scientific and sentimental. But he was really neither one nor the other. Pity he has, of course, for the poor, for those who are shut up in prisons, for the lowly, for the wretched; but he has far more pity for the rich, for the hard hedonists, for those who waste their freedom in becoming slaves to things, for those who wear soft raiment and live in kings' houses. Riches and pleasure seemed to him to be really greater tragedies than poverty or sorrow. And as for altruism, who knew better than he that it is vocation not volition that determines us, and that one cannot gather grapes of thorns or figs from thistles?
To live for others as a definite self-conscious aim was not his creed. It was not the basis of his creed. When he says, 'Forgive your enemies,' it is not for the sake of the enemy, but for one's own sake that he says so, and because love is more beautiful than hate. In his own entreaty to the young man, 'Sell all that thou hast and give to the poor,' it is not of the state of the poor that he is thinking but of the soul of the young man, the soul that wealth was marring. In his view of life he is one with the artist who knows that by the inevitable law of self-perfection, the poet must sing, and the sculptor think in bronze, and the painter make the world a mirror for his moods, as surely and as certainly as the hawthorn must blossom in spring, and the corn turn to gold at harvest- time, and the moon in her ordered wanderings change from shield to sickle, and from sickle to shield.
But while Christ did not say to men, 'Live for others,' he pointed out that there was no difference at all between the lives of others and one's own life. By this means he gave to man an extended, a Titan personality. Since his coming the history of each separate individual is, or can be made, the history of the world. Of course, culture has intensified the personality of man. Art has made us myriad-minded. Those who have the artistic temperament go into exile with Dante and learn how salt is the bread of others, and how steep their stairs; they catch for a moment the serenity and calm of Goethe, and yet know but too well that Baudelaire cried to God--
'O Seigneur, donnez moi la force et le courage De contempler mon corps et mon coeur sans degout.'
Out of Shakespeare's sonnets they draw, to their own hurt it may be, the secret of his love and make it their own; they look with new eyes on modern life, because they have listened to one of Chopin's nocturnes, or handled Greek things, or read the story of the passion of some dead man for some dead woman whose hair was like threads of fine gold, and whose mouth was as a pomegranate. But the sympathy of the artistic temperament is necessarily with what has found expression. In words or in colours, in music or in marble, behind the painted masks of an AEschylean play, or through some Sicilian shepherds' pierced and jointed reeds, the man and his message must have been revealed.
To the artist, expression is the only mode under which he can conceive life at all. To him what is dumb is dead. But to Christ it was not so. With a width and wonder of imagination that fills one almost with awe, he took the entire world of the inarticulate, the voiceless world of pain, as his kingdom, and made of himself its eternal mouthpiece. Those of whom I have spoken, who are dumb under oppression, and 'whose silence is heard only of God,' he chose as his brothers. He sought to become eyes to the blind, ears to the deaf, and a cry in the lips of those whose tongues had been tied. His desire was to be to the myriads who had found no utterance a very trumpet through which they might call to heaven. And feeling, with the artistic nature of one to whom suffering and sorrow were modes through which he could realise his conception of the beautiful, that an idea is of no value till it becomes incarnate and is made an image, he made of himself the image of the Man of Sorrows, and as such has fascinated and dominated art as no Greek god ever succeeded in doing.
For the Greek gods, in spite of the white and red of their fair fleet limbs, were not really what they appeared to be. The curved brow of Apollo was like the sun's disc crescent over a hill at dawn, and his feet were as the wings of the morning, but he himself had been cruel to Marsyas and had made Niobe childless. In the steel shields of Athena's eyes there had been no pity for Arachne; the pomp and peacocks of Hera were all that was really noble about her; and the Father of the Gods himself had been too fond of the daughters of men. The two most deeply suggestive figures of Greek Mythology were, for religion, Demeter, an Earth Goddess, not one of the Olympians, and for art, Dionysus, the son of a mortal woman to whom the moment of his birth had proved also the moment of her death.
But Life itself from its lowliest and most humble sphere produced one far more marvellous than the mother of Proserpina or the son of Semele. Out of the Carpenter's shop at Nazareth had come a personality infinitely greater than any made by myth and legend, and one, strangely enough, destined to reveal to the world the mystical meaning of wine and the real beauties of the lilies of the field as none, either on Cithaeron or at Enna, had ever done.
The song of Isaiah, 'He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief: and we hid as it were our faces from him,' had seemed to him to prefigure himself, and in him the prophecy was fulfilled. We must not be afraid of such a phrase. Every single work of art is the fulfilment of a prophecy: for every work of art is the conversion of an idea into an image. Every single human being should be the fulfilment of a prophecy: for every human being should be the realisation of some ideal, either in the mind of God or in the mind of man. Christ found the type and fixed it, and the dream of a Virgilian poet, either at Jerusalem or at Babylon, became in the long progress of the centuries incarnate in him for whom the world was waiting.
To me one of the things in history the most to be regretted is that the Christ's own renaissance, which has produced the Cathedral at Chartres, the Arthurian cycle of legends, the life of St. Francis of Assisi, the art of Giotto, and Dante's _Divine Comedy_, was not allowed to develop on its own lines, but was interrupted and spoiled by the dreary classical Renaissance that gave us Petrarch, and Raphael's frescoes, and Palladian architecture, and formal French tragedy, and St. Paul's Cathedral, and Pope's poetry, and everything that is made from without and by dead rules, and does not spring from within through some spirit informing it. But wherever there is a romantic movement in art there somehow, and under some form, is Christ, or the soul of Christ. He is in _Romeo and Juliet_, in the _Winter's Tale_, in Provencal poetry, in the _Ancient Mariner_, in _La Belle Dame sans merci_, and in Chatterton's _Ballad of Charity_.
We owe to him the most diverse things and people. Hugo's _Les Miserables_, Baudelaire's _Fleurs du Mal_, the note of pity in Russian novels, Verlaine and Verlaine's poems, the stained glass and tapestries and the quattro-cento work of Burne-Jones and Morris, belong to him no less than the tower of Giotto, Lancelot and Guinevere, Tannhauser, the troubled romantic marbles of Michael Angelo, pointed architecture, and the love of children and flowers--for both of which, indeed, in classical art there was but little place, hardly enough for them to grow or play in, but which, from the twelfth century down to our own day, have been continually making their appearances in art, under various modes and at various times, coming fitfully and wilfully, as children, as flowers, are apt to do: spring always seeming to one as if the flowers had been in hiding, and only came out into the sun because they were afraid that grown up people would grow tired of looking for them and give up the search; and the life of a child being no more than an April day on which there is both rain and sun for the narcissus.
It is the imaginative quality of Christ's own nature that makes him this palpitating centre of romance. The strange figures of poetic drama and ballad are made by the imagination of others, but out of his own imagination entirely did Jesus of Nazareth create himself. The cry of Isaiah had really no more to do with his coming than the song of the nightingale has to do with the rising of the moon--no more, though perhaps no less. He was the denial as well as the affirmation of prophecy. For every expectation that he fulfilled there was another that he destroyed. 'In all beauty,' says Bacon, 'there is some strangeness of proportion,' and of those who are born of the spirit--of those, that is to say, who like himself are dynamic forces--Christ says that they are like the wind that 'bloweth where it listeth, and no man can tell whence it cometh and whither it goeth.' That is why he is so fascinating to artists. He has all the colour elements of life: mystery, strangeness, pathos, suggestion, ecstasy, love. He appeals to the temper of wonder, and creates that mood in which alone he can be understood.
And to me it is a joy to remember that if he is 'of imagination all compact,' the world itself is of the same substance. I said in _Dorian Gray_ that the great sins of the world take place in the brain: but it is in the brain that everything takes place. We know now that we do not see with the eyes or hear with the ears. They are really channels for the transmission, adequate or inadequate, of sense impressions. It is in the brain that the poppy is red, that the apple is odorous, that the skylark sings.
Of late I have been studying with diligence the four prose poems about Christ. At Christmas I managed to get hold of a Greek Testament, and every morning, after I had cleaned my cell and polished my tins, I read a little of the Gospels, a dozen verses taken by chance anywhere. It is a delightful way of opening the day. Every one, even in a turbulent, ill- disciplined life, should do the same. Endless repetition, in and out of season, has spoiled for us the freshness, the naivete, the simple romantic charm of the Gospels. We hear them read far too often and far too badly, and all repetition is anti-spiritual. When one returns to the Greek; it is like going into a garden of lilies out of some, narrow and dark house.
And to me, the pleasure is doubled by the reflection that it is extremely probable that we have the actual terms, the _ipsissima verba_, used by Christ. It was always supposed that Christ talked in Aramaic. Even Renan thought so. But now we know that the Galilean peasants, like the Irish peasants of our own day, were bilingual, and that Greek was the ordinary language of intercourse all over Palestine, as indeed all over the Eastern world. I never liked the idea that we knew of Christ's own words only through a translation of a translation. It is a delight to me to think that as far as his conversation was concerned, Charmides might have listened to him, and Socrates reasoned with him, and Plato understood him: that he really said [Greek text], that when he thought of the lilies of the field and how they neither toil nor spin, his absolute expression was [Greek text], and that his last word when he cried out 'my life has been completed, has reached its fulfilment, has been perfected,' was exactly as St. John tells us it was: [Greek text]--no more.
While in reading the Gospels--particularly that of St. John himself, or whatever early Gnostic took his name and mantle--I see the continual assertion of the imagination as the basis of all spiritual and material life, I see also that to Christ imagination was simply a form of love, and that to him love was lord in the fullest meaning of the phrase. Some six weeks ago I was allowed by the doctor to have white bread to eat instead of the coarse black or brown bread of ordinary prison fare. It is a great delicacy. It will sound strange that dry bread could possibly be a delicacy to any one. To me it is so much so that at the close of each meal I carefully eat whatever crumbs may be left on my tin plate, or have fallen on the rough towel that one uses as a cloth so as not to soil one's table; and I do so not from hunger--I get now quite sufficient food--but simply in order that nothing should be wasted of what is given to me. So one should look on love.
Christ, like all fascinating personalities, had the power of not merely saying beautiful things himself, but of making other people say beautiful things to him; and I love the story St. Mark tells us about the Greek woman, who, when as a trial of her faith he said to her that he could not give her the bread of the children of Israel, answered him that the little dogs--([Greek text], 'little dogs' it should be rendered)--who are under the table eat of the crumbs that the children let fall. Most people live for love and admiration. But it is by love and admiration that we should live. If any love is shown us we should recognise that we are quite unworthy of it. Nobody is worthy to be loved. The fact that God loves man shows us that in the divine order of ideal things it is written that eternal love is to be given to what is eternally unworthy. Or if that phrase seems to be a bitter one to bear, let us say that every one is worthy of love, except him who thinks that he is. Love is a sacrament that should be taken kneeling, and _Domine, non sum dignus_ should be on the lips and in the hearts of those who receive it.
If ever I write again, in the sense of producing artistic work, there are just two subjects on which and through which I desire to express myself: one is 'Christ as the precursor of the romantic movement in life': the other is 'The artistic life considered in its relation to conduct.' The first is, of course, intensely fascinating, for I see in Christ not merely the essentials of the supreme romantic type, but all the accidents, the wilfulnesses even, of the romantic temperament also. He was the first person who ever said to people that they should live 'flower-like lives.' He fixed the phrase. He took children as the type of what people should try to become. He held them up as examples to their elders, which I myself have always thought the chief use of children, if what is perfect should have a use. Dante describes the soul of a man as coming from the hand of God 'weeping and laughing like a little child,' and Christ also saw that the soul of each one should be _a guisa di fanciulla che piangendo e ridendo pargoleggia_. He felt that life was changeful, fluid, active, and that to allow it to be stereotyped into any form was death. He saw that people should not be too serious over material, common interests: that to be unpractical was to be a great thing: that one should not bother too much over affairs. The birds didn't, why should man? He is charming when he says, 'Take no thought for the morrow; is not the soul more than meat? is not the body more than raiment?' A Greek might have used the latter phrase. It is full of Greek feeling. But only Christ could have said both, and so summed up life perfectly for us.
His morality is all sympathy, just what morality should be. If the only thing that he ever said had been, 'Her sins are forgiven her because she loved much,' it would have been worth while dying to have said it. His justice is all poetical justice, exactly what justice should be. The beggar goes to heaven because he has been unhappy. I cannot conceive a better reason for his being sent there. The people who work for an hour in the vineyard in the cool of the evening receive just as much reward as those who have toiled there all day long in the hot sun. Why shouldn't they? Probably no one deserved anything. Or perhaps they were a different kind of people. Christ had no patience with the dull lifeless mechanical systems that treat people as if they were things, and so treat everybody alike: for him there were no laws: there were exceptions merely, as if anybody, or anything, for that matter, was like aught else in the world!
That which is the very keynote of romantic art was to him the proper basis of natural life. He saw no other basis. And when they brought him one, taken in the very act of sin and showed him her sentence written in the law, and asked him what was to be done, he wrote with his finger on the ground as though he did not hear them, and finally, when they pressed him again, looked up and said, 'Let him of you who has never sinned be the first to throw the stone at her.' It was worth while living to have said that.
Like all poetical natures he loved ignorant people. He knew that in the soul of one who is ignorant there is always room for a great idea. But he could not stand stupid people, especially those who are made stupid by education: people who are full of opinions not one of which they even understand, a peculiarly modern type, summed up by Christ when he describes it as the type of one who has the key of knowledge, cannot use it himself, and does not allow other people to use it, though it may be made to open the gate of God's Kingdom. His chief war was against the Philistines. That is the war every child of light has to wage. Philistinism was the note of the age and community in which he lived. In their heavy inaccessibility to ideas, their dull respectability, their tedious orthodoxy, their worship of vulgar success, their entire preoccupation with the gross materialistic side of life, and their ridiculous estimate of themselves and their importance, the Jews of Jerusalem in Christ's day were the exact counterpart of the British Philistine of our own. Christ mocked at the 'whited sepulchre' of respectability, and fixed that phrase for ever. He treated worldly success as a thing absolutely to be despised. He saw nothing in it at all. He looked on wealth as an encumbrance to a man. He would not hear of life being sacrificed to any system of thought or morals. He pointed out that forms and ceremonies were made for man, not man for forms and ceremonies. He took sabbatarianism as a type of the things that should be set at nought. The cold philanthropies, the ostentatious public charities, the tedious formalisms so dear to the middle-class mind, he exposed with utter and relentless scorn. To us, what is termed orthodoxy is merely a facile unintelligent acquiescence; but to them, and in their hands, it was a terrible and paralysing tyranny. Christ swept it aside. He showed that the spirit alone was of value. He took a keen pleasure in pointing out to them that though they were always reading the law and the prophets, they had not really the smallest idea of what either of them meant. In opposition to their tithing of each separate day into the fixed routine of prescribed duties, as they tithe mint and rue, he preached the enormous importance of living completely for the moment.
Those whom he saved from their sins are saved simply for beautiful moments in their lives. Mary Magdalen, when she sees Christ, breaks the rich vase of alabaster that one of her seven lovers had given her, and spills the odorous spices over his tired dusty feet, and for that one moment's sake sits for ever with Ruth and Beatrice in the tresses of the snow-white rose of Paradise. All that Christ says to us by the way of a little warning is that every moment should be beautiful, that the soul should always be ready for the coming of the bridegroom, always waiting for the voice of the lover, Philistinism being simply that side of man's nature that is not illumined by the imagination. He sees all the lovely influences of life as modes of light: the imagination itself is the world of light. The world is made by it, and yet the world cannot understand it: that is because the imagination is simply a manifestation of love, and it is love and the capacity for it that distinguishes one human being from another.
But it is when he deals with a sinner that Christ is most romantic, in the sense of most real. The world had always loved the saint as being the nearest possible approach to the perfection of God. Christ, through some divine instinct in him, seems to have always loved the sinner as being the nearest possible approach to the perfection of man. His primary desire was not to reform people, any more than his primary desire was to a relieve suffering. To turn an interesting thief into a tedious honest man was not his aim. He would have thought little of the Prisoners' Aid Society and other modern movements of the kind. The conversion of a publican into a Pharisee would not have seemed to him a great achievement. But in a manner not yet understood of the world he regarded sin and suffering as being in themselves beautiful holy things and modes of perfection.
It seems a very dangerous idea. It is--all great ideas are dangerous. That it was Christ's creed admits of no doubt. That it is the true creed I don't doubt myself.
Of course the sinner must repent. But why? Simply because otherwise he would be unable to realise what he had done. The moment of repentance is the moment of initiation. More than that: it is the means by which one alters one's past. The Greeks thought that impossible. They often say in their Gnomic aphorisms, 'Even the Gods cannot alter the past.' Christ showed that the commonest sinner could do it, that it was the one thing he could do. Christ, had he been asked, would have said--I feel quite certain about it--that the moment the prodigal son fell on his knees and wept, he made his having wasted his substance with harlots, his swine- herding and hungering for the husks they ate, beautiful and holy moments in his life. It is difficult for most people to grasp the idea. I dare say one has to go to prison to understand it. If so, it may be worth while going to prison.
There is something so unique about Christ. Of course just as there are false dawns before the dawn itself, and winter days so full of sudden sunlight that they will cheat the wise crocus into squandering its gold before its time, and make some foolish bird call to its mate to build on barren boughs, so there were Christians before Christ. For that we should be grateful. The unfortunate thing is that there have been none since. I make one exception, St. Francis of Assisi. But then God had given him at his birth the soul of a poet, as he himself when quite young had in mystical marriage taken poverty as his bride: and with the soul of a poet and the body of a beggar he found the way to perfection not difficult. He understood Christ, and so he became like him. We do not require the Liber Conformitatum to teach us that the life of St. Francis was the true _Imitatio Christi_, a poem compared to which the book of that name is merely prose.
Indeed, that is the charm about Christ, when all is said: he is just like a work of art. He does not really teach one anything, but by being brought into his presence one becomes something. And everybody is predestined to his presence. Once at least in his life each man walks with Christ to Emmaus.
As regards the other subject, the Relation of the Artistic Life to Conduct, it will no doubt seem strange to you that I should select it. People point to Reading Gaol and say, 'That is where the artistic life leads a man.' Well, it might lead to worse places. The more mechanical people to whom life is a shrewd speculation depending on a careful calculation of ways and means, always know where they are going, and go there. They start with the ideal desire of being the parish beadle, and in whatever sphere they are placed they succeed in being the parish beadle and no more. A man whose desire is to be something separate from himself, to be a member of Parliament, or a successful grocer, or a prominent solicitor, or a judge, or something equally tedious, invariably succeeds in being what he wants to be. That is his punishment. Those who want a mask have to wear it.
But with the dynamic forces of life, and those in whom those dynamic forces become incarnate, it is different. People whose desire is solely for self-realisation never know where they are going. They can't know. In one sense of the word it is of course necessary, as the Greek oracle said, to know oneself: that is the first achievement of knowledge. But to recognise that the soul of a man is unknowable, is the ultimate achievement of wisdom. The final mystery is oneself. When one has weighed the sun in the balance, and measured the steps of the moon, and mapped out the seven heavens star by star, there still remains oneself. Who can calculate the orbit of his own soul? When the son went out to look for his father's asses, he did not know that a man of God was waiting for him with the very chrism of coronation, and that his own soul was already the soul of a king.
I hope to live long enough and to produce work of such a character that I shall be able at the end of my days to say, 'Yes! this is just where the artistic life leads a man!' Two of the most perfect lives I have come across in my own experience are the lives of Verlaine and of Prince Kropotkin: both of them men who have passed years in prison: the first, the one Christian poet since Dante; the other, a man with a soul of that beautiful white Christ which seems coming out of Russia. And for the last seven or eight months, in spite of a succession of great troubles reaching me from the outside world almost without intermission, I have been placed in direct contact with a new spirit working in this prison through man and things, that has helped me beyond any possibility of expression in words: so that while for the first year of my imprisonment I did nothing else, and can remember doing nothing else, but wring my hands in impotent despair, and say, 'What an ending, what an appalling ending!' now I try to say to myself, and sometimes when I am not torturing myself do really and sincerely say, 'What a beginning, what a wonderful beginning!' It may really be so. It may become so. If it does I shall owe much to this new personality that has altered every man's life in this place.
You may realise it when I say that had I been released last May, as I tried to be, I would have left this place loathing it and every official in it with a bitterness of hatred that would have poisoned my life. I have had a year longer of imprisonment, but humanity has been in the prison along with us all, and now when I go out I shall always remember great kindnesses that I have received here from almost everybody, and on the day of my release I shall give many thanks to many people, and ask to be remembered by them in turn.
The prison style is absolutely and entirely wrong. I would give anything to be able to alter it when I go out. I intend to try. But there is nothing in the world so wrong but that the spirit of humanity, which is the spirit of love, the spirit of the Christ who is not in churches, may make it, if not right, at least possible to be borne without too much bitterness of heart.
I know also that much is waiting for me outside that is very delightful, from what St. Francis of Assisi calls 'my brother the wind, and my sister the rain,' lovely things both of them, down to the shop-windows and sunsets of great cities. If I made a list of all that still remains to me, I don't know where I should stop: for, indeed, God made the world just as much for me as for any one else. Perhaps I may go out with something that I had not got before. I need not tell you that to me reformations in morals are as meaningless and vulgar as Reformations in theology. But while to propose to be a better man is a piece of unscientific cant, to have become a deeper man is the privilege of those who have suffered. And such I think I have become.
If after I am free a friend of mine gave a feast, and did not invite me to it, I should not mind a bit. I can be perfectly happy by myself. With freedom, flowers, books, and the moon, who could not be perfectly happy? Besides, feasts are not for me any more. I have given too many to care about them. That side of life is over for me, very fortunately, I dare say. But if after I am free a friend of mine had a sorrow and refused to allow me to share it, I should feel it most bitterly. If he shut the doors of the house of mourning against me, I would come back again and again and beg to be admitted, so that I might share in what I was entitled to share in. If he thought me unworthy, unfit to weep with him, I should feel it as the most poignant humiliation, as the most terrible mode in which disgrace could be inflicted on me. But that could not be. I have a right to share in sorrow, and he who can look at the loveliness of the world and share its sorrow, and realise something of the wonder of both, is in immediate contact with divine things, and has got as near to God's secret as any one can get.
Perhaps there may come into my art also, no less than into my life, a still deeper note, one of greater unity of passion, and directness of impulse. Not width but intensity is the true aim of modern art. We are no longer in art concerned with the type. It is with the exception that we have to do. I cannot put my sufferings into any form they took, I need hardly say. Art only begins where Imitation ends, but something must come into my work, of fuller memory of words perhaps, of richer cadences, of more curious effects, of simpler architectural order, of some aesthetic quality at any rate.
When Marsyas was 'torn from the scabbard of his limbs'--_della vagina della membre sue_, to use one of Dante's most terrible Tacitean phrases--he had no more song, the Greek said. Apollo had been victor. The lyre had vanquished the reed. But perhaps the Greeks were mistaken. I hear in much modern Art the cry of Marsyas. It is bitter in Baudelaire, sweet and plaintive in Lamartine, mystic in Verlaine. It is in the deferred resolutions of Chopin's music. It is in the discontent that haunts Burne-Jones's women. Even Matthew Arnold, whose song of Callicles tells of 'the triumph of the sweet persuasive lyre,' and the 'famous final victory,' in such a clear note of lyrical beauty, has not a little of it; in the troubled undertone of doubt and distress that haunts his verses, neither Goethe nor Wordsworth could help him, though he followed each in turn, and when he seeks to mourn for _Thyrsis_ or to sing of the _Scholar Gipsy_, it is the reed that he has to take for the rendering of his strain. But whether or not the Phrygian Faun was silent, I cannot be. Expression is as necessary to me as leaf and blossoms are to the black branches of the trees that show themselves above the prison walls and are so restless in the wind. Between my art and the world there is now a wide gulf, but between art and myself there is none. I hope at least that there is none.
To each of us different fates are meted out. My lot has been one of public infamy, of long imprisonment, of misery, of ruin, of disgrace, but I am not worthy of it--not yet, at any rate. I remember that I used to say that I thought I could bear a real tragedy if it came to me with purple pall and a mask of noble sorrow, but that the dreadful thing about modernity was that it put tragedy into the raiment of comedy, so that the great realities seemed commonplace or grotesque or lacking in style. It is quite true about modernity. It has probably always been true about actual life. It is said that all martyrdoms seemed mean to the looker on. The nineteenth century is no exception to the rule.
Everything about my tragedy has been hideous, mean, repellent, lacking in style; our very dress makes us grotesque. We are the zanies of sorrow. We are clowns whose hearts are broken. We are specially designed to appeal to the sense of humour. On November 13th, 1895, I was brought down here from London. From two o'clock till half-past two on that day I had to stand on the centre platform of Clapham Junction in convict dress, and handcuffed, for the world to look at. I had been taken out of the hospital ward without a moment's notice being given to me. Of all possible objects I was the most grotesque. When people saw me they laughed. Each train as it came up swelled the audience. Nothing could exceed their amusement. That was, of course, before they knew who I was. As soon as they had been informed they laughed still more. For half an hour I stood there in the grey November rain surrounded by a jeering mob.
For a year after that was done to me I wept every day at the same hour and for the same space of time. That is not such a tragic thing as possibly it sounds to you. To those who are in prison tears are a part of every day's experience. A day in prison on which one does not weep is a day on which one's heart is hard, not a day on which one's heart is happy.
Well, now I am really beginning to feel more regret for the people who laughed than for myself. Of course when they saw me I was not on my pedestal, I was in the pillory. But it is a very unimaginative nature that only cares for people on their pedestals. A pedestal may be a very unreal thing. A pillory is a terrific reality. They should have known also how to interpret sorrow better. I have said that behind sorrow there is always sorrow. It were wiser still to say that behind sorrow there is always a soul. And to mock at a soul in pain is a dreadful thing. In the strangely simple economy of the world people only get what they give, and to those who have not enough imagination to penetrate the mere outward of things, and feel pity, what pity can be given save that of scorn?
I write this account of the mode of my being transferred here simply that it should be realised how hard it has been for me to get anything out of my punishment but bitterness and despair. I have, however, to do it, and now and then I have moments of submission and acceptance. All the spring may be hidden in the single bud, and the low ground nest of the lark may hold the joy that is to herald the feet of many rose-red dawns. So perhaps whatever beauty of life still remains to me is contained in some moment of surrender, abasement, and humiliation. I can, at any rate, merely proceed on the lines of my own development, and, accepting all that has happened to me, make myself worthy of it.
People used to say of me that I was too individualistic. I must be far more of an individualist than ever I was. I must get far more out of myself than ever I got, and ask far less of the world than ever I asked. Indeed, my ruin came not from too great individualism of life, but from too little. The one disgraceful, unpardonable, and to all time contemptible action of my life was to allow myself to appeal to society for help and protection. To have made such an appeal would have been from the individualist point of view bad enough, but what excuse can there ever be put forward for having made it? Of course once I had put into motion the forces of society, society turned on me and said, 'Have you been living all this time in defiance of my laws, and do you now appeal to those laws for protection? You shall have those laws exercised to the full. You shall abide by what you have appealed to.' The result is I am in gaol. Certainly no man ever fell so ignobly, and by such ignoble instruments, as I did.
The Philistine element in life is not the failure to understand art. Charming people, such as fishermen, shepherds, ploughboys, peasants and the like, know nothing about art, and are the very salt of the earth. He is the Philistine who upholds and aids the heavy, cumbrous, blind, mechanical forces of society, and who does not recognise dynamic force when he meets it either in a man or a movement.
People thought it dreadful of me to have entertained at dinner the evil things of life, and to have found pleasure in their company. But then, from the point of view through which I, as an artist in life, approach them they were delightfully suggestive and stimulating. The danger was half the excitement. . . . My business as an artist was with Ariel. I set myself to wrestle with Caliban. . . .
A great friend of mine--a friend of ten years' standing--came to see me some time ago, and told me that he did not believe a single word of what was said against me, and wished me to know that he considered me quite innocent, and the victim of a hideous plot. I burst into tears at what he said, and told him that while there was much amongst the definite charges that was quite untrue and transferred to me by revolting malice, still that my life had been full of perverse pleasures, and that unless he accepted that as a fact about me and realised it to the full I could not possibly be friends with him any more, or ever be in his company. It was a terrible shock to him, but we are friends, and I have not got his friendship on false pretences.
Emotional forces, as I say somewhere in _Intentions_, are as limited in extent and duration as the forces of physical energy. The little cup that is made to hold so much can hold so much and no more, though all the purple vats of Burgundy be filled with wine to the brim, and the treaders stand knee-deep in the gathered grapes of the stony vineyards of Spain. There is no error more common than that of thinking that those who are the causes or occasions of great tragedies share in the feelings suitable to the tragic mood: no error more fatal than expecting it of them. The martyr in his 'shirt of flame' may be looking on the face of God, but to him who is piling the faggots or loosening the logs for the blast the whole scene is no more than the slaying of an ox is to the butcher, or the felling of a tree to the charcoal burner in the forest, or the fall of a flower to one who is mowing down the grass with a scythe. Great passions are for the great of soul, and great events can be seen only by those who are on a level with them.
* * * * *
I know of nothing in all drama more incomparable from the point of view of art, nothing more suggestive in its subtlety of observation, than Shakespeare's drawing of Rosencrantz and Guildenstern. They are Hamlet's college friends. They have been his companions. They bring with them memories of pleasant days together. At the moment when they come across him in the play he is staggering under the weight of a burden intolerable to one of his temperament. The dead have come armed out of the grave to impose on him a mission at once too great and too mean for him. He is a dreamer, and he is called upon to act. He has the nature of the poet, and he is asked to grapple with the common complexity of cause and effect, with life in its practical realisation, of which he knows nothing, not with life in its ideal essence, of which he knows so much. He has no conception of what to do, and his folly is to feign folly. Brutus used madness as a cloak to conceal the sword of his purpose, the dagger of his will, but the Hamlet madness is a mere mask for the hiding of weakness. In the making of fancies and jests he sees a chance of delay. He keeps playing with action as an artist plays with a theory. He makes himself the spy of his proper actions, and listening to his own words knows them to be but 'words, words, words.' Instead of trying to be the hero of his own history, he seeks to be the spectator of his own tragedy. He disbelieves in everything, including himself, and yet his doubt helps him not, as it comes not from scepticism but from a divided will.
Of all this Guildenstern and Rosencrantz realise nothing. They bow and smirk and smile, and what the one says the other echoes with sickliest intonation. When, at last, by means of the play within the play, and the puppets in their dalliance, Hamlet 'catches the conscience' of the King, and drives the wretched man in terror from his throne, Guildenstern and Rosencrantz see no more in his conduct than a rather painful breach of Court etiquette. That is as far as they can attain to in 'the contemplation of the spectacle of life with appropriate emotions.' They are close to his very secret and know nothing of it. Nor would there be any use in telling them. They are the little cups that can hold so much and no more. Towards the close it is suggested that, caught in a cunning spring set for another, they have met, or may meet, with a violent and sudden death. But a tragic ending of this kind, though touched by Hamlet's humour with something of the surprise and justice of comedy, is really not for such as they. They never die. Horatio, who in order to 'report Hamlet and his cause aright to the unsatisfied,'
'Absents him from felicity a while, And in this harsh world draws his breath in pain,'
dies, but Guildenstern and Rosencrantz are as immortal as Angelo and Tartuffe, and should rank with them. They are what modern life has contributed to the antique ideal of friendship. He who writes a new _De Amicitia_ must find a niche for them, and praise them in Tusculan prose. They are types fixed for all time. To censure them would show 'a lack of appreciation.' They are merely out of their sphere: that is all. In sublimity of soul there is no contagion. High thoughts and high emotions are by their very existence isolated.
* * * * *
I am to be released, if all goes well with me, towards the end of May, and hope to go at once to some little sea-side village abroad with R--- and M---.
The sea, as Euripides says in one of his plays about Iphigeneia, washes away the stains and wounds of the world.
I hope to be at least a month with my friends, and to gain peace and balance, and a less troubled heart, and a sweeter mood. I have a strange longing for the great simple primeval things, such as the sea, to me no less of a mother than the Earth. It seems to me that we all look at Nature too much, and live with her too little. I discern great sanity in the Greek attitude. They never chattered about sunsets, or discussed whether the shadows on the grass were really mauve or not. But they saw that the sea was for the swimmer, and the sand for the feet of the runner. They loved the trees for the shadow that they cast, and the forest for its silence at noon. The vineyard-dresser wreathed his hair with ivy that he might keep off the rays of the sun as he stooped over the young shoots, and for the artist and the athlete, the two types that Greece gave us, they plaited with garlands the leaves of the bitter laurel and of the wild parsley, which else had been of no service to men.
We call ours a utilitarian age, and we do not know the uses of any single thing. We have forgotten that water can cleanse, and fire purify, and that the Earth is mother to us all. As a consequence our art is of the moon and plays with shadows, while Greek art is of the sun and deals directly with things. I feel sure that in elemental forces there is purification, and I want to go back to them and live in their presence.
Of course to one so modern as I am, 'Enfant de mon siecle,' merely to look at the world will be always lovely. I tremble with pleasure when I think that on the very day of my leaving prison both the laburnum and the lilac will be blooming in the gardens, and that I shall see the wind stir into restless beauty the swaying gold of the one, and make the other toss the pale purple of its plumes, so that all the air shall be Arabia for me. Linnaeus fell on his knees and wept for joy when he saw for the first time the long heath of some English upland made yellow with the tawny aromatic brooms of the common furze; and I know that for me, to whom flowers are part of desire, there are tears waiting in the petals of some rose. It has always been so with me from my boyhood. There is not a single colour hidden away in the chalice of a flower, or the curve of a shell, to which, by some subtle sympathy with the very soul of things, my nature does not answer. Like Gautier, I have always been one of those 'pour qui le monde visible existe.'
Still, I am conscious now that behind all this beauty, satisfying though it may be, there is some spirit hidden of which the painted forms and shapes are but modes of manifestation, and it is with this spirit that I desire to become in harmony. I have grown tired of the articulate utterances of men and things. The Mystical in Art, the Mystical in Life, the Mystical in Nature this is what I am looking for. It is absolutely necessary for me to find it somewhere.
All trials are trials for one's life, just as all sentences are sentences of death; and three times have I been tried. The first time I left the box to be arrested, the second time to be led back to the house of detention, the third time to pass into a prison for two years. Society, as we have constituted it, will have no place for me, has none to offer; but Nature, whose sweet rains fall on unjust and just alike, will have clefts in the rocks where I may hide, and secret valleys in whose silence I may weep undisturbed. She will hang the night with stars so that I may walk abroad in the darkness without stumbling, and send the wind over my footprints so that none may track me to my hurt: she will cleanse me in great waters, and with bitter herbs make me whole.
envoyé par dq82 - 22/2/2015 - 15:41
Langue: italien
Traduzione italiana a cura di Adelina Manzotti Bignone da liberliber.it
...Un assai lungo momento è il soffrire.
Noi non possiamo dividerlo per stagioni, ma soltanto renderci conto de' suoi modi e calcolarne i ritorni. Per noi, il tempo stesso non cammina; e sembra piuttosto descrivere un circolo intorno ad un centro di dolore. La paralizzatrice immobilità di un'esistenza in cui ogni particolare è regolato da un immutevole dèspota (in modo che noi mangiamo, beviamo, dormiamo e preghiamo – o, almeno, c'inginocchiamo per pregare – secondo le leggi di una formula ferrea); questo carattere statico che rende, fino nei più piccoli atti, ogni giornata uguale alla precedente, pare che si comunichi a tutte quelle forze esterne delle quali l'essenza consiste appunto in un mutamento continuo.
Noi non sappiamo nulla del periodo della semina o del raccolto, dei mietitori proni in mezzo alle spighe, o dei vendemmiatori sparsi tra i vigneti; nulla sappiamo dei prati verdi che gli alberi di primavera nevicano di petali e che gli alberi del verziere, in autunno, cospargono di frutti maturi – e nulla mai ne possiamo sapere.
Per noi non c'è che una stagione: quella del dolore. Sembra che ci abbiano anche defraudato del sole e della luna. Fuori il cielo può essere d'azzurro e d'oro, ma la grossa vetrata del piccolo abbaino dalle sbarre di ferro sotto cui ci si accuccia non lascia filtrare appena che una povera luce sporca. Dentro le celle c'è sempre la semichiarìa del crepuscolo; e il crepuscolo invade pure ogni cuore. Nell'orbita del pensiero, come in quella del tempo, il moto non esiste più. La cosa stessa che da gran pezzo voi, personalmente, avete dimenticato o che potete dimenticare con facilità, la medesima cosa mi succede ancora in questo stesso momento e mi accadrà nuovamente domani. Tenete presente tutto ciò e vi sarà possibile comprendere il perchè io scrivo in questo tono...
Una settimana dopo mi trasferiscono qui.. Passano ancora tre mesi e mia madre muore. Nessuno seppe quanto profondamente io l'amassi e la venerassi.
La sua morte fu per me una cosa terribile; ma io, già un tempo principe dello stile, non trovo nemmeno una parola per esprimere la mia angoscia e la mia vergogna. Essa e mio padre mi avevano lasciato in retaggio un nome glorioso d'onore e di nobiltà, non solo nei campi della letteratura, dell'arte, dell'archeologia e della scienza, ma anche nella storia del mio paese d'origine e nella sua evoluzione nazionale. Ebbene, io ho macchiato questo nome d'un obbrobrio eterno. Io ne ho creato un epiteto ignobile per il volgo. Io l'ho trascinato nel fango. Io l'ho dato in balìa dei bruti, affinchè lo rendano brutale ed ai nemici perchè ne facciano un sinonimo di follia. Quel che ho sofferto allora e lo strazio che ancor oggi io provo, no! nessuna penna lo potrà scrivere, nessun foglio di carta lo potrà rivelare. Mia moglie, sempre buona e nobile verso di me, temendo che la notizia della sciagura mi giungesse per mezzo di estranei, quantunque tanto malata, si mise in viaggio da Genova per l'Inghilterra per venire essa stessa ad annunciarmi questa perdita irreparabile. Le lettere di simpatia mi arrivarono da tutti coloro che avevano ancora serbato dell'affetto verso di me. E perfino delle persone che io non avevo mai conosciuto direttamente, quando seppero che una nuova disgrazia era venuta ad abbattersi sulla mia vita, scrissero, pregando di comunicarmi ch'essi m'erano accanto nel grande dolore...
Tre mesi passano. La tabella-calendario della mia condotta e del mio lavoro giornaliero, appesa esternamente sull'uscio della mia cella, con scrittovi sopra il mio nome e la mia condanna, m'informa che siamo giunti al mese di maggio...
La prosperità, il piacere e il successo possono essere volgari e refrattari, ma il dolore è la più sensibile di tutte le cose create. Nulla succede nel mondo del pensiero cui il dolore non faccia eco con delle vibrazioni infinitamente vive e terribili. In suo confronto, la sensibilissima foglia d'oro battuto, che indica la direzione delle forze che l'occhio non riesce ad afferrare, è grossolana.
Il dolore è una ferita che sanguina quando una mano la tocca, tranne quella dell'amore, ed anche premuta da una carezza buona essa fa sangue, quantunque non la strazi più la sofferenza.
Dovunque c'è il dolore ivi santa è la terra. Un giorno si capirà ciò che questo significa. Nulla si saprà prima di questo. *** e delle indoli come la sua, sì, possono comprendere. Quando, costretto fra due gendarmi, io fui condotto dalla mia prigione alla Corte dei Fallimenti, *** attese nel lungo e tragico corridoio per potersi togliere con atto grave il suo cappello davanti a me, in cospetto della folla che fu ridotta al silenzio da un gesto così semplice e così dolce, mentre io passavo innanzi a lui colle manette ai polsi e colla testa china.
Molti uomini si sono guadagnati il regno dei Cieli con delle opere assai meno meritevoli di questa. Non è con tale spirito, forse, e animati da simile amore che i Santi si inginocchiavano per lavare i piedi dei poveri o si curvavano per baciare sulle guancie i lebbrosi? Io non gli ho mai detto una parola di ciò ch'egli fece quel giorno. Non so nemmeno, in questo momento, s'egli pensa ch'io abbia potuto intravedere il suo atto.
Oh, non è una cosa per la quale si rivolgono dei ringraziamenti formali con delle parole formali! Io l'ho racchiusa nel tesoro del mio cuore. Ivi la serbo come un debito segreto che sono felice di pensare che non potrò assolvere mai. La imbalsamo e la rinfresco con la mirra e gli aromi d'infinite lagrime.
Guardate: la saggezza non mi riuscì di nessun profitto e la filosofia rimase infeconda e gli adagi e le frasi di coloro che tentarono di consolarmi furono come della polvere e della cenere nella mia bocca, ma il ricordo di quel piccolo gesto d'amore, adorabile e silenzioso, ha riaperto per me tutte le fonti della pietà, ha fatto fiorire il deserto come una rosa, m'ha strappato dalla disperazione solitaria dell'esilio per mettermi in armonia col grande cuore ferito e spezzato del mondo. Quando gli uomini saranno capaci di comprendere non solo quanto quel gesto fu bello, ma pure quale intimo significato ebbe per me e quale valore avrà per me sempre, allora forse essi sapranno in che modo e in quale stato d'animo mi devono avvicinare.
I poveri sono saggi e più caritatevoli e più propensi alla bontà di noialtri. Per loro la prigionia è una tragedia nella vita di un uomo, una sciagura, una disgrazia, qualche cosa, insomma, che merita la simpatia altrui. Essi parlano di colui che è in carcere come di uno che «passa un guaio», semplicemente. È l'espressione che adoperano sempre ed essa contiene la perfetta saggezza dell'amore. Invece, con le persone del nostro ceto è diverso. Per noi, la prigione trasforma un uomo in un paria. Io, e alcuni altri nel mio stesso caso, non abbiamo diritto nè all'aria, nè al sole. La nostra presenza turba la gioia degli altri.
Siamo ricevuti come degli intrusi, quando ritorniamo nel mondo. Non ci si vorrebbe lasciar godere nemmeno il chiaro di luna. E i nostri figliuoli non ce li portano via? Così ci si spezzano questi dolcissimi vincoli che ci ricollegano all'umanità. Siamo dannati alla solitudine, mentre i nostri figli sono pur vivi. Ci rifiutano l'unico mezzo che potrebbe guarirci e farci rinascere, l'unica dolcezza che sarebbe in grado di spandere un balsamo sul cuore angosciato e di mettere un po' di pace nell'anima in pena...
Bisogna, sì, ch'io mi dica che da me stesso io mi sono distrutto e che nessuno, piccolo o grande, non si può rovinare che con le sue proprie mani. Io sono pronto a dirlo; mi sforzo di confessarlo, quantunque, forse, in questo momento, non lo si creda. Senza alcuna compassione io sostengo contro di me l'implacabile accusa.
Per quanto terribile sia stato ciò che il mondo mi ha fatto di male, quel che io feci a me stesso fu più tremendo ancora.
Ero in simbolica comunione con l'arte e con la cultura del mio tempo. Sul principio della mia virilità lo avevo compreso e avevo, in seguito, forzato i miei contemporanei a comprenderlo. Pochi uomini, durante la loro vita, hanno occupato un posto simile al mio col pieno riconoscimento altrui. La posizione ideale di un artista è messa in luce, di solito (se pure lo è), dallo storico o dal critico, molto tempo dopo che l'artista e la sua età sono scomparsi. Invece, per me, la cosa accadde diversamente. Io ne ebbi la coscienza e la diedi anche agli altri.
Byron fu una figura simbolica, ma relativamente alla passione e alla stanchezza passionale della sua opera.
Il mio rapporto col mio tempo fu più nobile, più costante, d'una importanza e d'un valore più grandi.
Gli dèi m'avevano quasi tutto donato. Ma io mi lasciai poltrire e mi concessi dei lunghi periodi di tregua insensata e sensuale. Mi divertii a fare l'ozioso, il dandy, l'uomo alla moda. Mi circondai di poveri caratteri e di spiriti miserevoli. Divenni prodigo del mio proprio genio e provai una gioia bizzarra nello sperperare una giovinezza eterna. Stanco di vivere sulle cime, discesi volontariamente in fondo agli abissi per cercarvi delle sensazioni nuove. La perversità fu nell'orbita della passione quel che il paradosso era stato per me nella sfera del pensiero.
Infine il desiderio si cangiò in una malattia, o in una follìa, o in entrambe le cose. Divenni noncurante della vita altrui. Colsi il mio bene dove mi piacque e passai oltre. Dimenticai che ogni più piccola azione quotidiana forma o deforma il carattere e che, per conseguenza, ciò che si è compiuto nel segreto della propria intimità si sarà poi costretti a proclamarlo al mondo intero. Così, non fui più padrone di me stesso. Non riuscii più a dominare la mia anima e la ignorai. Permisi al piacere di governarmi e finii coll'essere abbattuto da una sventura orrenda. Adesso non mi rimane più che una cosa: l'assoluta umiltà.
Ecco quasi due anni, tra poco, che io sono in prigione! Da principio una selvaggia disperazione cominciò ad impossessarsi di me; mi abbandonavo a una pena tale ch'era disprezzabile anche a vedersi, a un'ira terribile ed impotente, all'angoscia e all'indignazione, alla tortura che mi strappava i più acuti singhiozzi, a una miseria che non aveva nessuna voce per esprimersi, a un dolore muto. Sono passato attraverso tutte le forme possibili della sofferenza. Meglio ancora di Wordsworth, io ben so ciò ch'egli intese di dire in quel suo distico
La sofferenza è costante e oscura e misteriosa,
e ha la natura dell'Infinito.
Ma quando, talvolta, io mi rallegro all'idea che le mie sarebbero interminabili, non potevo, però, sopportare ch'esse fossero prive di significato. Ora, io trovo riposta in un oscuro angolo della mia natura qualcosa che mi dice: nulla c'è al mondo che sia vuoto di senso ed il soffrire meno di qualunque altra cosa. Questo quid, nascosto nel più profondo del mio «io», come un tesoro in un campo, è l'Umiltà.
È l'ultima cosa che mi resta, e la migliore; è l'estrema scoperta alla quale io sono arrivato, è il punto di partenza di tutto uno sviluppo nuovo. È una verità che si è formata nel mio intimo essere e così pure io so ch'essa è venuta in un momento favorevole. Se alcuno me ne avesse parlato, l'avrei respinta; ma siccome l'ho trovata io stesso, ci tengo a serbarla. Bisogna ch'io la conservi! È l'unica cosa che ha in sè i germi della vita, di una nuova esistenza, una Vita Nuova per me. Tra tutte le cose, essa è la più strana; non si può acquistarla che a patto di rinunciare a tutto ciò che si possiede. E, solamente quando si è tutto perduto, ci si accorge di averla guadagnata.
Ora che ho capito ch'essa è in me, io vedo assai chiaramente ciò che in realtà occorre che io faccia. E allorchè adopero una frase come questa, non ho bisogno di aggiungere che non alludo a nessuna sanzione, a nessun ordine imperativo dal di fuori. Io non ne ammetto. Sono molto più individualista di quanto lo sia mai stato. Niente mi sembra che abbia il minimo valore, tranne ciò che si estrae dalla propria intimità. La mia indole è in traccia d'un nuovo mezzo di realizzazione: ecco tutto ciò di cui io devo preoccuparmi. E la prima cosa che mi occorre è questa: liberarmi di qualsiasi risentimento amaro contro il mondo.
Io sono completamente senza denaro, assolutamente senza focolare. Eppure c'è qualcosa di peggio, sulla terra. Sono del tutto sincero quando affermo che, piuttosto che lasciare questo carcere conservando nel mio cuore dell'amarezza contro il mondo, preferirei di mendicare con gioia il mio tozzo di pane di porta in porta. Se non ottengo nulla dal ricco, riceverò pur qualche cosa dal povero. Coloro che molto posseggono sono di solito avari; ma quelli che hanno ben poco lo dividono volentieri. Non mi farebbe nessun caso il dormire sulla fresca erba in estate e, al sopraggiungere dell'inverno, ripararmi al caldo in un mucchio di fieno o sotto la tettoia di una capanna, purchè avessi sempre dell'amore dentro il mio cuore. Le cose esterne della vita mi pare ora che non abbiano più alcun valore. Voi vedete, dunque, a quale intensità di individualismo io sono arrivato, o, piuttosto, io vado accostandomi, poichè il viaggio è ancor lungo e «sulla strada per la quale io cammino ci sono delle spine».
Certo, so bene che andare elemosinando per la via non sarà il fatto mio e che, se io mi stendessi la sera sull'erba fresca vi comporrei dei sonetti alla luna. Quando uscirò di prigione, R... mi aspetterà al di là dell'enorme portone ferrato ed egli è il simbolo non solo del suo proprio affetto, ma anche di quello di molti altri. Credo, ad ogni modo, che avrò da vivere per circa diciotto mesi e, se non potrò pel momento scrivere de' bei libri, almeno potrò leggerne; e quale felicità sarà più grande? In seguito spero d'essere capace di riacquistare le mie facoltà creatrici.
Ma se accadesse altrimenti, se non mi restasse più un amico al mondo, se nessuna casa mi fosse più aperta, neanche per pietà, se dovessi prendere la bisaccia e il tabarro logoro della miseria assoluta fino a quando io fossi libero da ogni risentimento, da ogni rancore, da ogni indignazione, potrei sempre affrontare la vita con molta più calma e fiducia che se il mio corpo fosse coperto di porpora e di lino prezioso e la mia anima scoppiasse di odio.
Nè avrò, veramente, nessuna difficoltà. Quando si desidera con fede l'amore, lo si trova là, che ci attende.
Inutile dire che il mio compito non termina qui. Se così fosse; sarebbe troppo facile. C'è ben altro davanti a me. Devo scalare delle montagne assai più irte; ho da attraversare delle valli infinitamente più cupe. E mi bisogna trarmi d'impaccio colle mie sole mani. Nè la religione, nè la morale, nè la ragione mi possono dare alcun giovamento.
No, la morale non mi aiuta. Io sono un antinomista nato. Sono di quelli che son fatti per le eccezioni e non per le regole. Ma mentre io vedo che non c'è niente di male in ciò che si compie, mi accorgo però che c'è qualcosa di cattivo in ciò che si diventa. È bene anche aver imparato questo.
La religione non mi aiuta. La fede che altri nutrono per ciò che è invisibile io la dedico a quel che si può toccare e osservare. I miei dèi abitano nei templi costruiti dalla mano dell'uomo ed è solo nell'ambito dell'esperienza reale che la mia fede si definisce e si completa; essa è troppo integra, forse, perchè, come molti di coloro o tutti coloro che hanno collocato il loro cielo sopra la terra, io vi ho scoperto non pure la bellezza del paradiso, ma anche dell'inferno. Quando penso alla religione, sento che mi piacerebbe fondare un ordine monastico per coloro che non possono credere: si dovrebbe chiamare la Congrega degli Infelici e nei suoi riti, davanti a un altare, privo di qualsiasi fiamma di ceri, un prete senza pace nel cuore, celebrerebbe l'officio con del pane profano o un calice vuoto. Ogni cosa, per essere vera, deve diventare una religione, e l'agnosticismo, come una qualunque altra religione, dovrebbe avere le sue cerimonie. Non ha esso seminato dei martiri? Ebbene, dovrebbe mietere i suoi santi e lodare ogni giorno il Signore d'essersi nascosto agli occhi degli uomini. Ma, sia la fede o l'agnosticismo, nè l'una nè l'altro mi devono rimanere due fatti esterni. Bisogna che i loro simboli siano una mia creazione stessa.
Spirituale è soltanto ciò che foggia la sua propria forma. Se non posso riuscire a trovarne il segreto nel mio intimo «io», non lo scoprirò giammai: se non lo reco con me, non mi si rivelerà mai più.
La ragione non mi aiuta. Essa mi dice che le leggi secondo le quali mi hanno condannato sono ingiuste e crudeli e che il sistema sociale per cui ho sofferto è ingiusto e malvagio. Ma, tuttavia, occorre ch'io le creda giuste e rette. E, precisamente come nel campo dell'arte non ci si occupa se non del valore che un fatto particolare ha di per se stesso in un particolare momento, così succede nell'evoluzione etica del carattere.
Occorre ch'io ritenga come un bene per me tutto ciò che mi è accaduto. Il letto di tavole, il cibo nauseabondo, le due funi che si devono sfilacciare in istoppa sino a che le dita indolenzite divengono insensibili, le vili «corvées» con le quali cominciano e finiscono le giornate, gli aspri comandi che sembrano una necessità dell'ordine, l'orribile casacca che rende persino grottesco il dolore, il silenzio, la solitudine, la vergogna – tutto questo bisogna ch'io lo trasformi in esperienza spirituale. Non c'è neppure una degradazione del corpo che non contribuisca a spiritualizzare l'anima.
Voglio arrivare ad un punto tale che mi sia possibile dire semplicemente e senza ostentazione di sorta che le due grandi date della mia vita corrispondono ai giorni in cui mio padre mi mandò ad Oxford e in cui entrai in galera. Io non dirò che la prigione sia la miglior cosa che mi sia capitata, perchè questa frase avrebbe un sapore di eccessiva amarezza verso di me. Preferirei dire o sentir dire di me stesso ch'io sono stato una natura così tipica del mio tempo che, nella mia perversità e per l'amore di questa perversità, ho mutato le buone cose della mia vita in male e le cattive in bene.
Tuttavia, ciò che gli altri dicono o che io dico interessa poco. La cosa importante che mi si offre e che devo fare – se il breve periodo dei miei giorni a venire non sarà sciupato, nè perduto, nè troncato – consiste nell'assorbire in me tutto ciò che mi è stato fatto e d'incorporarmelo e di accettarlo senza rimpianto, senza paura, senza ripugnanza. Il male supremo è la superficialità. Tutto ciò di cui ci si rende conto è bene.
Nei primi tempi della mia prigionia, alcuni mi consigliarono di dimenticare chi io ero. Disastroso consiglio! Invece, soltanto rendendomi ragione di quel che sono ho potuto trovare un po' di conforto. Adesso, altri mi esortano a dimenticare, quando sarò libero, d'essere mai stato in carcere. So bene che sarà fatale ugualmente. Ciò significa che io sarei senza tregua torturato da un sentimento intollerabile di sventura e che tutte le cose create per me come per gli altri: la bellezza del sole e della luna, il corteo delle stagioni, la musica dell'aurora e il silenzio della notte fonda, la pioggia che scroscia tra le foglie o la rugiada che inargenta i prati, tutte queste meraviglie diventerebbero opache per me, perderebbero il loro potere di guarire e di comunicare la gioia. Rammaricarsi delle esperienze fatte, vuol dire arrestare il proprio sviluppo; negarle equivale a mettere una menzogna sulle labbra della nostra vita. Sarebbe come rinnegare l'anima.
Perchè, come il corpo assorbe sostanze di ogni sorta, cose volgari ed impure, ed anche quelle che un sacerdote o una visione hanno purificato, e le converte in forza e in agilità, in gioco armonico di muscoli, in carni delicate, in capelli ricciuti e multicolori, in labbra, in occhi ridenti, così l'anima a sua volta ha le proprie funzioni nutritive e può trasformare in nobiltà di pensieri e in passioni di gran valore ciò che per sè stesso è vile, crudele e degradante; e a maggior ragione essa può trovarvi i suoi più efficaci mezzi di affermazione e rivelarsi più perfettamente mediante ciò che era destinato alla profanazione e alla distruzione.
Mi occorre sottomettermi francamente al fatto d'essere stato il carcerato ordinario di una ordinaria prigione e, quantunque ciò sembri curioso, bisognerà ch'io impari a non provarne vergogna. È necessario accettare la cosa come un castigo, e, se uno è vergognoso della pena sofferta, tanto valeva non averla mai nemmeno patita.
Certamente, ci sono molte colpe di cui mi hanno accusato e che io non ho mai commesso; ma ce n'è gran numero che mi hanno rimproverato e che in realtà ho compiuto e un numero più grande ancora di quelle che ho commesso e delle quali non sono mai stato accusato. E poichè gli dei sono strani e ci puniscono tanto per ciò che è umano e buono in noi quanto per ciò che è cattivo e perverso, io devo sottomettermi alla legge che fa pagare il fio sì per il bene che per il male compiuto.
Non ho nessun dubbio sulla perfetta giustizia di ciò. Questo giova o dovrebbe giovare a comprendere due cose e a non provare nessuna vanità nè per l'una nè per l'altra. Se, dunque, io non ho alcuna vergogna del mio castigo (come spero), sarò capace di pensare, di camminare e di vivere libero.
Non pochi uomini, dopo la loro liberazione, portano con sè la prigione nell'aria che li circonda, e, alla fine, come delle povere creature avvelenate, si cacciano in qualche buco per morirvi. È ben triste ch'essi siano ridotti a questo e la società che ve li costringe è ingiusta, tremendamente ingiusta. La società s'arroga il diritto d'infliggere all'individuo dei castighi spaventevoli, ma essa ha anche il difetto supremo d'essere superficiale e di non giungere a comprendere ciò che fa.
Quando il castigo è subìto, la società abbandona l'uomo a se stesso, vale a dire proprio nel momento nel quale dovrebbe cominciare il suo più alto dovere verso di lui. Essa ha paura delle azioni e rifugge da coloro che ha punito come si evita un creditore del quale non ci si può liberare, o l'uomo a cui si è imposta una irreparabile sorte. Da parte mia io esigo che, se mi rendo ragione di quanto ho sofferto, la società deve capire ciò che mi ha inflitto, e, per conseguenza, non c'è amarezza nè odio da una parte nè dall'altra.
Oh, lo riconosco che, da un certo angolo visuale, le cose saranno per me molto diverse da quel che sono per gli altri; ed è necessario, per la natura stessa del mio caso, ch'esse siano così. I poveri ladri e gli ammoniti, incarcerati qui con me, sono, sotto molti rispetti, assai più felici ch'io non sia. Il cantuccio di città oscura o di campo verdeggiante che assistette alla loro colpa è piccolo. Per trovare gente che ignori il loro delitto essi non hanno da superare una distanza maggiore di quella che un uccello percorre dal crepuscolo all'alba. Ma, per me, il mondo è ridotto ad un palmo e, da qualsiasi lato io mi volga, il mio nome è vergato con lettere di piombo sulla roccia. Poichè io non sono entrato dall'oscurità nella sfera di luce effimera del delitto, ma bensì da una specie di eternità di gloria in una specie di eternità d'infamia, e mi sembra talvolta d'aver dimostrato – se pure occorre questa prova – che tra l'uomo famoso e l'infame non c'è che un passo e forse anche meno d'un passo.
Pertanto, nel fatto che gli uomini mi riconosceranno dovunque io vada e che conosceranno la mia vita, almeno nelle sue ore di follia, io vedo un bene per me; ciò mi costringerà ad affermarmi nuovamente come artista e al più presto possibile. Se riuscirò a creare una sola e bella opera d'arte, mi sarà possibile di trovare un antidoto al veleno della malizia, di smontare i sarcasmi dei vili e di sradicare la lingua del disprezzo.
Se la vita, com'essa è sicuramente, deve anche per me essere un problema, io non sono un quesito di minor valore per la vita stessa. Gli uomini dovranno assumere qualche attitudine a mio riguardo, attraverso un giudizio su di sè medesimi e su di me. Non faccio nessuna allusione personale. I soli con i quali mi piacerebbe di trovarmi in compagnia, ora, sono gli artisti e coloro che hanno sofferto: coloro che sanno cos'è la bellezza e che sanno cos'è il dolore; tranne costoro, nessun altro m'interessa. E non domando più niente alla vita. In tutto ciò che ho affermato fin qui, io non mi preoccupo che della mia attitudine mentale verso la vita considerata nel suo insieme. Presento che uno dei primi punti che devo toccare per la mia propria perfezione e perchè io sono così imperfetto, si è di non vergognarmi d'essere stato punito.
In seguito bisognerà imparare ad essere felice. Un tempo conoscevo la felicità per istinto o almeno, credevo di conoscerla. C'era sempre la primavera, nel mio cuore, una volta! Mi occorreva la gioia ed ero nato per essa. Sino all'estremo limite io riempivo la mia vita di piacere, come si colma sino all'orlo una coppa di vino. Adesso è da un punto di partenza del tutto nuovo che mi accosto alla vita, ed anche il concepire la felicità mi riesce, spesso, difficile. Mi ricordo, durante il mio primo semestre a Oxford, di aver letto nel Rinascimento di Walter Pater – un libro che ebbe sulla mia vita una così strana influenza! – che Dante pone nel profondo Inferno coloro che vivono spontaneamente nella tristezza. Andai subito in biblioteca e cercai quel passo della Divina Commedia, là dove è detto che al disotto della sinistra palude giacciono quelli che furono «tristi nella dolcezza dell'aria» ripetendo
Tristi fummo
Nell'aer dolce che dal sol s'allegra.
Sapevo che la chiesa condannava l'accidia, ma questa idea mi parve assolutamente fantastica, come un genere di peccato inventato da un sacerdote ignorante della vita reale. Non potevo neppure capire come Dante, il quale dice che «il dolore ci unisce a Dio», fosse così aspro verso gli innamorati della melanconia, dato che davvero ne esistessero. Non sospettavo allora che questa diverrebbe un giorno una delle più grande tentazioni della mia vita.
Durante la mia permanenza nel carcere di Wandsworth, io ero malato d'un languore di morte. Era il mio unico desiderio morire.
Poi, quando fui trasferito qui, dopo due mesi d'infermeria, e m'accorsi che la mia salute andava migliorando a poco a poco, fui preso dall'ira. Decisi di suicidarmi il giorno stesso in cui sarei uscito di prigione. Dopo qualche tempo, questo furioso accesso si calmò e stabilii, invece, di vivere, ma di fasciarmi tutto di tristezza come un re si panneggia nella sua porpora, di mutare in un luogo di pianto ogni casa della quale avessi varcato la soglia, di imporre a' miei amici la sottile tortura della mia ipocondria, d'insegnar loro che la tristezza è il vero segreto della vita, di tormentarli con un dolore che fosse loro estraneo, di soffocarli con la mia pena. Ora ho i sentimenti molto diversi. Capisco che sarebbe una ingratitudine ed una crudeltà da parte mia atteggiarmi in modo che, quando i miei amici m'incontrassero, fossero costretti a mostrarsi ancora più melanconici di me per testimoniarmi la loro simpatia; oppure – per riceverli e offrir loro un degno trattamento – invitarli a sedersi silenziosamente davanti a delle erbe amare o a dei cibi funerari. No; bisogna ch'io impari ad essere gaio e felice.
Le due ultime volte che io ebbi il permesso di vedere qui i miei amici, provai d'essere allegro per quanto possibile e di mostrare la mia gaiezza per compensarli, un poco, del disturbo che essi s'erano presi, venendo sin qua dalla capitale. Non fu che un compenso molto, molto lieve, lo so, ma son certo che a loro piacque. Son passati otto giorni sabato da che ho visto R... per un'ora e mi sforzavo di mostrare nel modo più espressivo possibile la gioia che provavo in quell'incontro.
Il fatto che ora, per la prima volta in tutta la mia prigionia, io sento un reale desiderio di vivere, mi prova che ho ragione nelle idee e nelle opinioni che formulo qui per me stesso.
Tanto lavoro ho davanti a me che mi parrebbe una terribile tragedia il morire prima di averne potuto compiere almeno una parte! Scorgo nell'arte e nella vita degli sviluppi imprevisti di cui ciascuno è un nuovo mezzo di perfezione.
Bramo di vivere per esplorare questo mondo nuovo per me. Volete dunque sapere in che consiste questo nuovo mondo? Credo che lo possiate anche indovinare. È il mondo nel quale ho vissuto. Il dolore, infine, e tutto ciò che il dolore insegna: ecco il mio nuovo mondo.
Vivevo, un tempo, esclusivamente per il piacere. Allontanavo da me i patimenti e il dolore in ogni loro aspetto; li odiavo; avevo risoluto d'ignorarli sino a quando mi fosse stato possibile – vale a dire di considerarli come delle forme d'imperfezione. Sofferenza e dolore non sarebbero entrati nell'orbita della mia vita. Non avevano nemmeno un posto nella mia filosofia. Mia madre, che conosceva la vita intera, mi citava spesso i versi di Goethe scritti da Carlyle sur una pagina d'un libro ch'egli le aveva donato una volta e tradotti così da lui stesso:
Colui che non ha mai mangiato il
suo pane nel dolore,
Che non ha mai passate le ore della
notte ad attendere piangendo il mattino
che tarda,
Colui non vi conosce, o potenze del
Cielo! –
Erano i versi che quella nobile regina di Prussia – trattata da Napoleone con tanta grossolana brutalità – recitava nella sua umiliazione e nel suo esilio; erano i versi che mia madre mi ripeteva spesso nel tormento della sua vita, prossima a spegnersi. Io rifiutai, allora, assolutamente, di riconoscere o d'ammettere l'enorme verità che essi contenevano. Mi rammento molto bene ch'io le ripetevo di non aver nessun desiderio di mangiare il mio pane nel dolore e di trascorrere le notti aspettando in pianto un'alba d'amarezza.
Non avevo nessuna idea che proprio là eravi nascosta una delle singolari sorprese tenute in serbo dal destino per me e che, veramente, non altro io farei se non mangiare il mio pane nel dolore per un anno intero. Ma è così che anch'io ho avuto la mia parte; e che, durante questi ultimi mesi, ho potuto comprendere, mercè ostacoli e lotte senza pari, qualcuno degli insegnamenti che si celano nell'intimo del dolore. Preti e gente che adoperano frasi senza misura parlano, alle volte, della sofferenza come d'un mistero. Invece essa è una rivelazione. Fa distinguere delle cose che non si erano mai vedute prima e permette di considerare l'insieme della storia da un punto di vista tutt'affatto diverso. Quel che intorno all'arte, ad esempio, si era sentito in modo vago e per istinto, ora lo si afferra intellettualmente ed emozionalmente con una chiarezza perfetta di visione e con una intensità assoluta, comprensiva.
Oramai io sono persuaso che, poichè il dolore è la suprema emozione di cui è suscettibile l'uomo, esso è ad un tempo il tipo e il modello di ogni grande arte. Ciò che l'arte ricerca continuamente è quella certa maniera d'essere nella quale anima e corpo divengono uni e indivisibili; nella quale l'esteriore è l'espressione dell'intimità, in cui la forma stessa è una rivelazione. Tali maniere d'essere non sono numerose; in un dato momento ci possono servire di modello la giovinezza e l'arte che si preoccupa della giovinezza; in un altro noi possiamo credere invece che, per la sua finezza e sensibilità d'espressione, per l'idea che suggerisce d'uno spirito diffuso negli oggetti esterni e che si riveste a volta a volta d'aria e di terra, di nebbia e di volumi e per la morbidezza de' suoi atteggiamenti, de' suoi toni, de' suoi colori – l'arte del paesaggio moderno realizza per noi pittoricamente ciò che i Greci ottennero con tanta perfezione plastica. La musica, nella quale ogni soggetto è assorbito dall'espressione e non può separarsene, è un esempio complesso di quel che io voglio dire, così come un fiore o un fanciullo sono degli esempi semplici; ma il dolore è il tipo più alto nella vita e nell'arte.
Dietro la gioia e il sorriso ci può essere un temperamento ruvido, aspro e scaltro. Ma dietro il dolore non c'è che il dolore. L'angoscia, contrariamente al piacere, non si maschera mai. La verità, in arte, non consiste in una corrispondenza tra l'idea madre e l'esistenza accidentale; essa non è la identità della forma con l'ombra o della forma riflessa dal cristallo con la forma stessa; non è l'eco rinviata dall'anfratto d'una collina – così come non è, nella valle, una sorgente d'acqua argentata che mostra la luna alla luna e Narciso a Narciso. La verità in arte è l'unità d'una cosa con sè stessa, è l'esteriore come diretta emanazione dell'interiore; è l'anima connaturata con la carne e il corpo con lo spirito. Per questa ragione non esiste nessuna verità che sia comparabile al dolore. Ci sono alcuni momenti in cui il dolore sembra divenire la Verità Unica. Le altre cose possono essere delle illusioni dell'occhio o del desiderio, create per accecare l'uno e soddisfare l'altro, ma è solo col dolore che si sono creati i mondi e alla nascita di un fanciullo o di una stella presiede il dolore.
Ma – di più: v'è nel dolore una realtà intensa, straordinaria. Ho detto di me stesso ch'ero in comunione simbolica coll'arte e colla cultura della mia età. Ebbene: non c'è un solo infelice, chiuso con me in questa galera miserabile, che non si trovi in comunione simbolica col segreto stesso della vita. Perchè il segreto della vita è di soffrire. È questo che si nasconde in tutte le cose. Quando cominciamo a vivere, quel che è dolce a noi sembra tanto dolce e quel che è amaro ci sembra tanto amaro che noi rivolgiamo inevitabilmente tutti i nostri sforzi verso il piacere e non cerchiamo soltanto di «nutrirci di miele per un mese o due», ma non vogliamo altro alimento, in tutta la nostra vita, ignorando così che corriamo rischio d'affamare la nostra anima.
Mi sovviene d'essere entrato una volta in questo argomento con una delle più belle figure che abbia mai conosciuto, una donna di cui è indicibile la simpatia, la nobile bontà verso di me, prima e dopo la tragedia della mia prigionia; essa mi ha realmente aiutato, quantunque ella lo ignori, a portare il fardello delle mie pene più di qualsiasi altra creatura al mondo; e tutto ciò con il solo fatto della sua esistenza, perchè essa è quello che è: un ideale e una forza influente ad un tempo, una suggestione di ciò che si potrebbe divenire quanto un aiuto effettivo per divenirlo, un'anima che comunica la sua dolcezza all'aria che si respira e fa sembrare il mondo dello spirito semplice e naturale come la limpidità del sole e del mare; per lei la bellezza e il dolore camminano dandosi la mano e recano la stessa novella. Nell'occasione di cui parlavo mi ricordo d'averle detto che c'era in una sola strada-budello di Londra abbastanza sofferenza per mostrare che Dio non ama l'uomo e che, in qualunque luogo il dolore si rivelasse, (fosse pure quello d'un fanciullo piangente in un piccolo giardino per una colpa non commessa) la faccia intera della creazione ne era completamente sfigurata.
Ebbene, avevo del tutto torto. Ella me lo disse, ma io non le credetti. Non ero nell'ordine d'idee nel quale si arriva a una simile scoperta. Adesso constato che l'amore è la sola spiegazione possibile della somma straordinaria di dolore che esiste nel mondo. Non posso concepire nessun'altra spiegazione. Sono convinto che non ce n'è una diversa, e se veramente il mondo è stato costruito col dolore, le mani che lo hanno edificato son quelle dell'amore, perchè l'anima dell'uomo, per cui il mondo fu creato, non poteva altrimenti raggiungere il limite della sua perfezione. Il piacere per un bel corpo, ma il dolore per una bella anima.
Ma quando dico che sono convinto di queste cose, io parlo con troppo orgoglio. Di lontano, simile a una perla perfetta, si scorge la città di Dio. La vista ne è così meravigliosa che sembra che un fanciullo possa raggiungerla in un giorno d'estate. Ma per me e per coloro che sono simili a me, è differente. Si può, sì, assimilarsi una cosa in un solo istante; ma poi la si perde nelle lunghe ore che seguono interminabili, con piedi di piombo. È troppo difficile rimanere sulle «cime su cui l'anima sa d'innalzarsi». Noi pensiamo sotto la specie dell'eterno, ma pure noi procediamo lentamente col tempo e il tempo come lentamente cammina, per noi che siamo in prigione! Non occorre ch'io ne parli ancora e nemmeno della stanchezza e dello scoraggiamento che s'insinuano dentro le celle o nella cella del nostro cuore con una così strana insistenza che bisogna (per così dire) lustrare e adornare la casa, affinchè essi entrino come ospiti volgari o padroni crudeli dei quali si è, per caso o per elezione, lo schiavo.
Benchè ora i miei amici non lo credano, è pur vero che per essi (che vivono liberi, nell'ozio e nelle comodità) è più facile imparare lezioni d'umiltà che per me, per me che comincio la mia giornata mettendomi in ginocchio a lavare il pavimento della mia cella. Perchè la vita della prigione, colle sue privazioni e i suoi sacrifici innumerevoli, spinge alla rivolta. E il più terribile non è già che essa spezzi il cuore – i cuori non sono fatti per essere infranti? – ma che lo trasformi in una pietra. Tali volte, si sente che solo con una fronte di bronzo e delle labbra sprezzanti si può arrivare alla fine della giornata. Ma colui che si trova in istato di ribellione non può ricevere il dono della grazia, (per usare la frase che la Chiesa ama, con tanta ragione, oserei dire), perchè, nella vita come nell'arte, lo stato di rivolta preclude le vie dell'anima e non lascia passare i soffi del cielo. Tuttavia, se pur devo impararle in qualche luogo, è qui che mi eserciterò nelle lezioni d'umiltà e devo essere pieno di gioia, se i miei piedi sono sulla buona via e il mio volto guarda verso la «porta che è chiamata bella», sebbene io debba cadere ancora tante volte nel fango e spesso disorientarmi in mezzo alla bruma.
Questa Vita Nuova, come la chiamo sovente pel mio amore di Dante, non è a rigore una vita nuova, ma semplicemente, la continuazione, per via di sviluppi e di evoluzioni, della mia prima vita. Quando ero ad Oxford, l'ultimo anno, una mattina in cui passeggiavamo per gli stretti viali gorgheggianti del Magdalen College, mi ricordo d'aver detto a un amico che io volevo gustare tutti i frutti del giardino del mondo e che stavo per metter piede nella vita con questo desiderio chiuso nel profonda della mia anima. È così, infatti, che vi entrai e così che io vissi.
Il mio solo errore fu di limitarmi esclusivamente agli alberi di quel che mi parve il lato luminoso del giardino e di fuggire l'altra parte, impaurito com'ero delle zone d'ombra e della sua oscurità. La non riuscita nel mondo, la sventura, la povertà, il dolore, la disperazione, la sofferenza, le lagrime stesse e le parole monche che sfuggono alle labbra in pena, il rimorso che costringe a camminare sui rovi, la coscienza che condanna, il volontario umiliarsi che avvilisce, la miseria che ricopre i suoi capelli di cenere, l'angoscia che si lacera con un cilicio e mescola il fiele nel calice della sua bevanda – di tutte queste cose insieme io ero spaventato. E siccome ero risoluto a non esperimentarne mai nessuna, fui poi costretto a gustarle ad una ad una, a nutrirmene e ad abbeverarmene, a non avere altro nutrimento durante una intera stagione.
Neppure per un istante io ho rimorso d'aver vissuto per il piacere. Pienamente mi abbandonai ad esso, come è necessario fare tutto quel che si fa. Non c'è voluttà che io non conoscessi. In una coppa di vino gettai la perla della mia anima. Discesi al suono dei flauti pel sentiero fiorito delle primavere. Mi cibai di miele. Ma non sarebbe stato buon consiglio continuare la medesima vita, perchè ciò sarebbe equivalso ad una limitazione. Occorreva procedere oltre. Anche l'altra metà del giardino aveva dei segreti per me. Certo, tutto ciò è detto e preveduto nei miei libri. Una parte nel Principe Felice; un'altra, nel Giovine Re, specialmente nel passo nel quale il vescovo dice al fanciullo inginocchiato: «Colui che ha creato il dolore non è più saggio di te?» È una frase che, quando la scrissi, mi parve veramente più di una semplice frase. Una gran parte di verità è dissimulata sotto l'accento fatale che, simile a un filo di porpora, serpeggia attraverso la trama di Dorian Gray. Nel Critico considerato come artista il presagio si rivela in molte maniere, nell'Anima dell'Uomo è manifesto in chiare lettere, anche troppo facili a leggersi; e non è, esso mònito, uno dei ritornelli che ripetuti motivi rendono Salome simile a uno squarcio musicale e le dànno l'unità organica d'una ballata? Inoltre è incarnato nel poema in prosa dell'uomo che, col bronzo della statua del «Piacere effimero» deve foggiare l'immagine del «Dolore Eterno». Non poteva essere diversamente. In ciascun momento della vita si è quel che si sta per essere, oltre a ciò che si è già stati. L'arte è simbolica, perchè tutto un simbolo è l'uomo.
Se potrò conquistarla completamente, questa Vita Nuova, essa sarà la definitiva realizzazione della vita artistica; in quanto la vita artistica è semplicemente lo sviluppo di sè stesso. L'umiltà per l'artista consiste nell'accettare con cuore franco tutte le esperienze, come l'amore per l'artista è il puro senso della bellezza che rivela al mondo il suo corpo e la sua anima.
In Mario l'Epicureo, Walter Pater cerca nel senso profondo, solenne e dolce della parola, di riconciliare la vita artistica con quella della religione. Ma Mario, quasi, non è che uno spettatore – uno spettatore ideale cui è concesso di «contemplare lo spettacolo della vita con delle emozioni adeguate», ciò che Wordsworth definisce lo scopo vero del poeta; tuttavia è uno spettatore un po' troppo preoccupato della delicata grazia del santuario del dolore che ha pur sotto gli occhi.
Io vedo un vincolo molto più intimo ed immediato tra la vera vita di Cristo e la vera vita dell'artista e provo un grande piacere pensando che, assai tempo prima d'essere dominato e legato al carro del dolore, io avevo scritto, nell'Anima dell'Uomo, che colui il quale volesse condurre una vita simile a quella di Cristo dovrebbe essere interamente e assolutamente sè stesso e avevo preso come esempi non solo il pastore sulla montagna e il prigioniero nella sua cella, ma sì anche il pittore per cui il mondo è una festa di colori e il poeta pel quale l'universo intero è un canto. Mi rammento, una volta che si discuteva in un caffè di Parigi, d'aver detto ad Andrea Gide: la metafisica ha poco interesse reale per me e la morale nessuno; ma tutto ciò che è uscito dalla bocca di Platone o di Cristo può essere trasportato immediatamente nella sfera dell'arte e trovarvi la propria espressione integrale.
Non solo noi possiamo notare in Cristo quel vincolo intimo della personalità con la perfezione in cui consiste la vera differenza tra il movimento classico e il romantico nella vita; ma è un fatto che la sua stessa natura era identica a quella dell'artista – una immaginazione intensa come una fiamma. Egli ebbe nel campo dei rapporti umani quella tale simpatia immaginativa che, nel dominio dell'arte, forma il segreto unico della creazione. Comprese la lebbra del lebbroso, la tenebra del cieco, la crudele miseria di coloro che vivono non cercando altro che il piacere, la strana povertà del ricco. Qualcuno mi ha scritto, durante il periodo più acuto delle mie angoscie «Caduto dal vostro piedestallo, non siete più interessante». Oh, quanto egli era lontano, dicendo questo, dal «segreto di Gesù»! – per adoperare una espressione di Matteo Arnold. L'uno e l'altro gli avrebbero potuto insegnare che ciò che succede ad un uomo succede ugualmente a voi. Se volete una massima da leggere dall'alba alla notte, nelle ore di gioia e nelle ore di tristezza, incidete sulle pareti della vostra casa queste lettere (che saranno dorate dal sole, inargentate dalla luna): «Tutto quel che capita a me stesso, capiterà anche ad altri».
Senza dubbio, Cristo va collocato assieme con i poeti. La sua concezione dell'Umanità era una risultante diretta della sola immaginazione – che può comprenderla. Egli considerò l'uomo come il panteista aveva considerato Dio. Fu il primo a concepire l'unità delle razze divise. Avanti ch'Egli apparisse, c'erano stati degli dèi e degli uomini, e Cristo sentendo per mezzo della sua mistica simpatia che ciascuno di essi era incarnato in sè, si denomina, a seconda, o il figlio di Dio o il figlio dell'Uomo. Più di qualsiasi altro nella storia Egli desta in noi quella facoltà del meraviglioso cui si rivolge sempre l'elemento romanzesco. C'è ancora in me qualcosa d'incredibile nell'idea di questo giovine artigiano galilèo che s'immagina di poter portare sulle sue spalle il peso del mondo intero: tutto quel ch'era già stato compiuto e sofferto, i delitti di Nerone, di Cesare Borgia, di Alessandro VI e di colui che fu Imperatore di Roma e sacerdote del sole, le torture di coloro i cui nomi sono legioni e che riposano nei cimiteri, le nazioni oppresse, i fanciulli martiri delle officine, i ladri, i carcerati, i proscritti, coloro che sono diventati muti nel servaggio e de' quali solamente Dio comprende il silenzio; e tutto questo non era una semplice immaginazione, ma un fatto vero, compiuto, in modo che ora tutti quelli che cercano di penetrare nella sua personalità – quantunque non si curvino davanti a' suoi altari, nè s'inginocchino innanzi a' suoi preti – s'avvedono, in qualche modo, che la macchia del loro peccato è lavata ed hanno la rivelazione della bellezza del loro soffrire.
Dicevo che Cristo va messo assieme con i poeti. È vero. Shelley e Sofocle l'accompagnano. Ma tutta la sua vita intera è il più meraviglioso dei poemi. Quanto a «pietà e terrore», non c'è niente di simile nel ciclo complessivo della tragedia ellènica. La purità del protagonista innalza tutto il piano della sua vita ad un'altezza d'arte romantica donde – a causa dell'orrore – sono eliminate le tribolazioni di Tebe e della schiatta dei Pelòpidi; ed essa mostra ancora quanto avesse torto Aristotile ad affermare, nel suo trattato sul dramma, che riuscirebbe impossibile sopportare lo spettacolo d'un personaggio irreprensibile nel dolore. Nè in Eschilo nè in Dante, questi genî austeri della più accorata poesia, nè in Shakespeare, il più umano di tutti i grandi artisti, e nemmeno nell'insieme dei miti e delle leggende celtiche (ne' quali la bellezza del mondo s'intravvede sotto un velo di lacrime e in cui la vita d'un uomo non è da più della vita di un fiore) si può trovare qualcosa che, per la semplice emozione unita alla sublimità dell'effetto tragico, stia alla pari o soltanto s'approssimi all'ultimo atto della passione di Cristo.
La cena con i suoi discepoli, da uno dei quali è già stato venduto per una somma di danaro; l'angosciosa agonia nell'orto tranquillo illuminato dalla luna; il falso amico che gli si avvicina per tradirlo con un bacio; l'amico – che credeva ancora in Lui e sul quale Egli, come su una roccia granitica, aveva sperato di poter costruire un rifugio per l'Uomo – che lo rinnega, invece, nell'ora in cui il gallo saluta l'aurora; il suo isolamento assoluto, la sua sottomissione, la sua rassegnazione; inoltre: le scene nelle quali il gran sacerdote dell'ortodossia gli lacera con furia le vesti, e il magistrato civile dell'impero chiede dell'acqua, sperando invano di lavarsi quella macchia di sangue che dovrà contrassegnarlo come la rossa figura della storia; la cerimonia dolorosa della corona di spine – una delle cose più meravigliose nella cronaca dei tempi; la crocefissione dell'innocente sotto gli occhi di sua madre e del discepolo che l'amava, i soldati che si giocano a dadi gli abiti del martire; la morte terribile con la quale egli ha dato al mondo il suo più eterno simbolo; e poi la sepoltura finale nella tomba dell'uomo ricco; il suo corpo fasciato di bende egiziane e profumato di aromi costosi, come se fosse stato il figlio di un re... Quando si considera tutto ciò unicamente dal punto di vista dell'arte, bisogna pure essere riconoscenti alla Chiesa del fatto che il supremo rito della Chiesa stessa consista nella rappresentazione della tragedia senza spargimento di sangue: mistica rappresentazione della Passione del Signore per mezzo di dialoghi, di costumi e di gesti. Ed è per me una ragione di piacere e di rispetto commosso il pensare che il coro greco, altrimenti perduto per l'arte, sia sopravvissuto infine nel chierico che risponde al prete celebratore della messa.
E però la vita di Cristo – a tal punto dolore e bellezza si possono fondere nella loro manifestazione piena di significato – è realmente un idillio, quantunque essa termini col velario del tempo che si lacera, colle tenebre che si addensano sulla faccia della terra e colla pietra trascinata fino all'ingresso della sepoltura. Si pensa sempre a Cristo come ad un fidanzato in mezzo a' suoi compagni e, d'altronde, è proprio così ch'egli si compiace di chiamarsi in alcuni luoghi; come ad un pastore che trascorra di valle in valle col suo gregge alla ricerca di verdi prati e di ruscelli d'argento; come a un cantore che provi colla sua musica di costruire le mura della città di Dio; o come a un amante le cui capacità d'amore sono troppo vaste per il nostro piccolo mondo. I suoi miracoli mi sembrano squisiti come il primo soffio della primavera ed altrettanto naturali. Non ho alcuna difficoltà a credere che il fascino della sua persona doveva essere tale da poter dare la pace alle anime tormentate con la sua sola presenza e che coloro i quali gli toccavano la tunica e le mani dimenticavano le proprie sofferenze; e che, quando egli passava sulla grande via della vita, uomini che non avevano mai visto nulla nel mistero di vivere, ad un tratto si sentivano aprire gli occhi ed altri, rimasti sempre sordi a tutte le voci, tranne che a quella della voluttà, udivano per la prima volta la voce dell'amore e la trovavano «così musicale come la lira d'Apollo»; nè ho difficoltà a credere che le malvagie passioni s'involavano al suo avvicinarsi e gli uomini, le esistenze dei quali erano sempre state meschine, simili alla morte, balzavano fuori della tomba – per così dire – appena egli li chiamava; oppure, quando egli predicava sulla montagna, la moltitudine obliava la fame, la sete e le cure del mondo; e quando egli conversava con gli amici e i discepoli durante la cena, il cibo grossolano sembrava delicato e l'acqua assumeva il gusto del vino e tutta la casa s'empiva del profumo dolce del nardo.
Nella Vita di Gesù – questo delizioso quinto evangelo, l'evangelo secondo San Tommaso, si potrebbe chiamarlo – Renan dice in qualche passo che il grande segreto di Cristo fu quello di farsi amare dopo la morte quanto era stato amato in vita.
Certamente, se il suo posto è tra i poeti, egli è il principe degli amanti. Egli vide che l'amore è il principio primordiale del mondo, il segreto che cercavano i saggi – ed è soltanto per mezzo dell'amore che ci si può accostare al lebbroso e al signore.
Ma, oltre a tutto ciò, Cristo è il supremo individualista. L'umiltà, in quanto accettazione artistica di ogni esperienza, è un semplice modo di manifestarsi. È l'anima dell'uomo che Cristo cerca di raggiungere senza tregua. Egli la chiama «regno di Dio» e la trova in ciascuno di noi. La còmpara a delle piccole cose, a una sottile semenza, a un pugno di lievito, ad una perla. E non si afferra la realtà della propria anima se non liberandosi di tutte le passioni estranee, di ogni coltura sovrapposta, di ogni possesso acquisito – sia esso buono o cattivo.
Io mi ostinai contro tutto, con tenacia e con ribellione, sino a che non restasse in me più che una sola cosa al mondo. Avevo perduto il mio nome, la mia posizione, la mia felicità, la mia libertà, la mia ricchezza. Ero povero e prigioniero. Ma mi rimanevano ancora i miei figli. Ad un tratto anch'essi mi furono tolti. Fu un colpo così tremendo che non seppi più cosa fare; mi gettai in ginocchio, curvai la testa e piansi, esclamando: «Il corpo del Signore è come quello d'un fanciullo; io non sono più degno nè dell'uno nè dell'altro». Ed ecco: in questo istante mi parve di salvarmi. Vidi allora che la sola cosa per me era di accettare tutto. Da quel momento in poi – per quanto ciò paia curioso – io fui più felice. Si è che io avevo toccato la mia anima nella sua essenza suprema. In molte maniere me l'ero inimicata, ma essa mi attendeva ancora come un amico. Quando si entra in comunione coll'anima, si diventa puri come fanciulli – Cristo l'ha detto.
È veramente tragico che così poche persone riescano a «possedere la loro anima» prima di morire. «Nulla è più raro in un uomo – dice Emerson – di un'azione che sia proprio sua». È assolutamente vero. La maggior parte degli esseri sono degli altri esseri. I loro pensieri sono l'opinione di qualcun altro, le loro esistenze una parodia, le loro passioni un'eco di riflesso. Cristo non fu soltanto il supremo individualista, ma anche il primo degli individualisti della storia. Si è tentato di considerarlo come uno dei tanti filantropi e l'hanno pure accomunato agli altruisti, come un'ignorante e un sentimentale.
Ma non fu, realmente, nè una cosa, nè l'altra. Certo, egli ha il senso della pietà per i poveri, per coloro che sono relegati nelle prigioni, per gli umili, per i miserabili, ma egli ha molta più compassione per i ricchi, per gli edonisti, per coloro che sacrificano la loro libertà e divengono gli schiavi delle cose, per quelli che portano abiti preziosi e abitano in palazzi regali.
Le ricchezze e le voluttà a lui sembrano invero delle tragedie più grandi che la penuria e il dolore. Quanto all'altruismo, poi, chi sapeva meglio di lui che non è la volontà, ma bensì la vocazione quella che ci spinge a compiere il bene e che non si potrebbero cogliere dei grappoli su dei roveti, nè dei fichi sui cardi?
Vivere per gli altri, come scopo cosciente e definito, non era già la sua fede. Non era la base della sua fede. Quando egli dice: «perdonate ai vostri nemici», non afferma questo per amor del nemico, ma per amor di sè stesso, perchè l'amore è più bello dell'odio. Consigliando al giovane ricco: «va e vendi tutto che possiedi e dònalo ai poveri» non è ai poveri che Cristo pensa, ma all'anima del giovane, l'anima che era rovinata dalla ricchezza. Nella visione della vita egli è d'accordo con l'artista il quale sa che, per l'inevitabile legge del perfetto sviluppo di sè stesso il poeta deve cantare, lo scultore pensare nel bronzo e il pittore fare del mondo lo specchio delle proprie emozioni; appunto come il biancospino deve sbocciare in primavera, il grano tingersi d'oro nel giugno e la luna, ne' suoi puntuali viaggi, deve cambiarsi di scudo in falce e di falce in iscudo.
Ma, mentre Cristo non ha mai detto agli uomini: «Vivete per gli altri» egli ha mostrato, però, che non c'è nessuna differenza tra la nostra e l'altrui vita. Con questo mezzo egli ha dato all'uomo una personalità estesissima e titanica. Dopo la sua apparizione, la storia di ogni individuo particolare si è trasformata o può trasformarsi nella storia stessa del mondo. Senza dubbio, anche la cultura ha intensificato la personalità dell'uomo. L'arte ci ha dato degli spiriti innumerevoli come miriadi. Coloro che hanno temperamento artistico seguono Dante nell'esilio e imparano «come sa di sale – lo pane altrui e com'è duro calle – lo scender e il salir per l'altrui scale»; essi acquistano per un momento la serenità e la calma di Goethe e tuttavia non ignorano quel che Baudelaire ha gridato a Dio:
O Signore, dammi la forza e il coraggio di contemplare il mio corpo e il mio cuore senza vergogna.
Con loro proprio svantaggio, forse, traggono dai sonetti di Shakespeare il segreto del suo amore e se ne impadroniscono; essi contemplano con occhi nuovi la vita moderna, perchè hanno ascoltato dei notturni di Chopin o perchè hanno maneggiato dei gioielli greci o hanno letto la storia della passione che un uomo ebbe un tempo lontano per una donna dalla capigliatura fine come l'oro e dalla bocca simile a una melagrana. Ma la simpatia del temperamento artistico si rivolge di necessità a ciò che ha trovato la sua propria espressione. Con delle parole o con dei colori, con la musica o col marmo, dietro la maschera dei personaggi d'Eschilo o con le fistule traforate d'un pastore siciliano, dovettero rivelarsi l'uomo e la sua intimità.
Per l'artista, l'espressione è il solo aspetto secondo il quale egli possa concepire la vita. Per lui ciò che è muto è morto. Ma per Cristo, invece, non era così. Con una immaginazione meravigliosa e vasta, che talvolta riempie di spavento, egli assunse per regno il mondo intero dell'immobilità, il mondo senza voce del dolore e ne divenne l'interprete. Scelse come suoi fratelli coloro che sono muti sotto il servaggio e «il silenzio dei quali non è inteso altro che da Dio». Egli volle divenire l'occhio dei ciechi, l'orecchio dei sordi e un grido sulle labbra di coloro che avevano la lingua recisa. Il suo desiderio era d'essere una tromba per le miriadi d'uomini che non avevano mai potuto esprimersi, una tromba con la quale egli lancerebbe il loro anelito verso il cielo. Con la natura artistica d'un essere pel quale sofferenza e dolore erano mezzi, attraverso cui giungere alla realtà della sua concezione del bello, egli sentì che un'idea non ha valore se non quando s'incarna, se non quando se ne forma un'immagine, e fece di sè stesso l'immagine dell'Uomo del Dolore; ed è appunto con questa figura che egli ha affascinato e dominato l'arte come nessuna divinità greca era riuscita a fare mai.
Poichè gli dei dell'Ellade, nonostante il bianco ed il roseo delle loro agili membra, non erano, in realtà, ciò che mostravano d'essere.
La fronte ben tornita d'Apollo era simile al disco del sole che sorge all'aurora dietro una collina e i suoi piedi erano come i soffi della brezza del mattino, ma egli era stato crudele contro Marsia e aveva rapito a Niobe i suoi figlioli; nell'egida d'acciaio degli occhi di Minerva non c'era mai stata pietà per Aracne; il fasto e i pavoni di Giunone erano tutto ciò che esisteva di veramente nobile in lei e il Padre degli Dei esso stesso mostrò troppa tenerezza per le figlie dei mortali. Le due figure più profondamente suggestive della mitologia greca furono, per la religione, Demetra, dea della Terra, che non era ammessa nell'Olimpo, e, per l'arte, Diònysos figlio di una donna effimera che morì nel darlo alla luce.
Eppure la vita stessa, nella sua più modesta e più umile sfera, produsse una meraviglia più ammirevole che la madre di Proserpina o il figlio di Semele. Dalla bottega del falegname di Nazareth sorse una personalità infinitamente più grande di tutte quelle create dalla leggenda e dal mito e destinata – cosa strana! – a rivelare al mondo il senso mistico del vino e delle reali bellezze del giglio nella valle, come nessuno aveva fatto ancora, nè sul Citerone, nè a Enna.
Il canto d'Isaia: «Egli è il disprezzato e l'ultimo degli uomini, un uomo di colore che conosce l'angoscia e noi gli abbiamo nascosta la nostra faccia» gli era parso una profezia e la profezia fu compiuta nella sua persona. Ogni opera d'arte che è creata è il compimento d'una profezia, perchè ciascuna opera d'arte è la conversione d'un'idea in una immagine. Così pure ogni creatura umana deve essere il compimento d'una profezia, perchè ciascuna creatura umana dovrebbe essere la realizzazione di qualche ideale, sia nello spirito di Dio che nello spirito dell'uomo. Cristo trovò il tipo e lo delineò; talchè il sogno di un poeta virgiliano, a Gerusalemme o a Babilonia, nel lungo cammino dei secoli, s'incarnò in colui che il mondo «attendeva».
Per me, una delle cose più dolorose della storia si è che la vera rinàscita di Cristo – che produsse la cattedrale di Chartres, il ciclo delle leggende d'Artù, la vita di San Francesco d'Assisi, l'arte di Giotto e la Divina Commedia di Dante – non abbia avuto la libertà di svilupparsi secondo le sue proprie linee interne, ma invece sia stata interrotta e violentata dalla fredda rinàscita classica che ci ha dato gli affreschi di Raffaello, l'architettura di Palladio, la tragedia francese convenzionale, la cattedrale di S. Paolo, la poesia di Pope e tutto ciò, insomma, che è creato dal di fuori, secondo regole morte, che non emana dall'intimo di un potente soffio inspiratore. Ma dovunque si verifica un movimento romantico in arte, là, in un modo o nell'altro, si trova Cristo o l'anima di Cristo. Egli è in Romeo e Giulietta, nel Racconto d'inverno, nella poesia provenzale, nella Ballata del Vecchio marinaio, nella Belle dame sans merci e nella Ballata della carità, di Chatterton.
Dobbiamo all'anima di Cristo le cose e i generi più diversi. I miserabili di Hugo, I fiori del male di Baudelaire, la nota pietosa dei romanzi russi, Verlaine e i suoi poemi; le vetrate, le tappezzerie e i lavori quattrocenteschi di Burne-Jones e di William Morris le appartengono non meno che il campanile di Giotto, Lancillotto e Ginevra, Thannhäuser e i marmi violenti di Michelangiolo, l'architettura gotica, l'amore per i fanciulli e l'amore per i fiori. A queste due ultime cose, veramente, l'arte classica non accorda che poco posto, appena quel tanto che basta per farli crescere e giuocare; eppure dal dodicesimo secolo ai nostri giorni essi non hanno mai cessato di comparire nell'arte in attitudini varie e in età diverse, a un tratto e capricciosamente sorgendo, appunto come i fanciulli ed i fiori: la primavera dà sempre l'idea che i fiori si siano nascosti e che ricompaiano al sole per la paura che gli uomini si stanchino di cercarli e vi rinuncino; e la vita d'un fanciullo non è altro che un giorno d'aprile con delle pioggie e delle zone di sole per i narcisi.
Ora è questo carattere immaginativo della natura di Cristo che lo rende il centro palpitante dello spirito romantico. Le strane figurazioni del poema drammatico e della ballata sono create dalla fantasia d'un altro, ma Gesù di Nazareth si è interamente creato per proprio conto. Il canto d'Isaïa, in vero, aveva da fare con la venuta di Cristo, tanto quanto il gorgheggio dell'usignuolo coll'alzarsi della luna – nulla di più e nulla di meno. Egli fu la negazione come pure l'affermazione della profezia. Per ogni speranza che realizzava, un'altra ne distruggeva. «In ogni bellezza – dice Bacone – c'è qualche stranezza di proporzione»; e di coloro che, come lui, sono delle forze dinàmiche – Cristo dice che sono come il vento che «soffia dove gli pare e nessuno può dire, nè donde venga, nè dove vada». Perciò il suo ascendente è così grande sugli artisti. Egli ha tutti i colori della vita: il mistero, la stranezza, il patetico, la suggestione, l'estasi e l'amore. Si rivolge allo spirito del miracolo e crea quel tale stato d'animo, solo nel quale può essere compreso.
E per me è una gioia, ora, il considerare che s'egli è «tutta immaginazione» il mondo stesso è di una identica sostanza. Ho detto, nel Dorian Gray, che i grandi delitti del mondo accadono nell'intimo del cervello. Ma non è pure nel cervello che tutto accade? Adesso sappiamo che noi non vediamo con gli occhi, nè udiamo con le orecchie. Essi non sono che dei canali per trasmettere con più o meno di esattezza le impressioni dei sensi. È dentro il cervello, che il papavero è rosso, e la mela odora e l'allodola canta.
Da qualche tempo io studio con cura i quattro poemi in prosa che riguardano la figura di Cristo. Per Natale sono riuscito a procurarmi un Testamento Greco ed ogni mattina, dopo aver spazzato la mia cella e forbito i miei utensili, leggo un passo dei Vangeli, una dozzina di versetti presi a caso, non importa dove. È una deliziosa maniera di cominciar la giornata. Ciascuno, anche vivendo una vita turbinosa e disordinata, dovrebbe fare così. Ripetizioni interminabili, ad ogni proposito e fuori scopo, ci hanno sciupato la freschezza, l'ingenuità, la grazia semplice e romantica dei Vangeli. Li sentiamo leggere e citare troppo spesso e troppo male, ed ogni insistenza di questo genere è anti-spirituale. Quando si torna al testo greco, pare di entrare in un'aiuola di gigli, uscendo da una casa angusta ed oscura.
Il piacere è raddoppiato per me dal pensiero che è assai probabile che noi adoperiamo le medesime frasi, ipsissima verba, usate da Cristo. Si ritenne per certo, a lungo, ch'egli si esprimesse in aràmico. Anche Renan lo credeva. Ma ora sappiano che gli abitanti della Galilea, come gli Irlandesi dei nostri giorni, erano bilingui e il greco era il linguaggio ordinario che serviva per le relazioni quotidiane da un capo all'altro della Palestina e, veramente, da un punto all'altro di tutto il mondo orientale. Ero spiacente di non poter conoscere le parole di Cristo, se non a traverso la traduzione di una traduzione. Sì, è per me una delizia pensare che, almeno per la semplice conversazione, Càrmide avrebbe potuto ascoltarlo e Socrate parlare con lui e Platone comprenderlo; ch'egli pronunciò esattamente: ἐγώ είμι ὄ ποιμἠν ὀ ϰαλὅς (io sono il buon pastore); che quando pensava ai gigli del campo, i quali non lavorano e non filano, egli s'espresse precisamente cosí: Κατα μὰϑετει τὰ ϰρίνα τοῦ πῶς αύξάνεί αγρού οῦ ϰοπιᾶ ούδὲ νηϑε e che la sua ultima parola, quando gridò: «Tutto è finito, la mia vita è terminata, ha toccato il vertice della sua perfezione», fu proprio quella che ci riporta San Giovanni: τετὲλεσται e nulla più.
Leggendo i Vangeli – specialmente il Quarto, quello di San Giovanni o del Gnostico, chiunque sia colui che assunse il suo nome e il suo abito – io vedo di continuo che l'immaginazione è messa innanzi come la base di ogni vita spirituale e materiale; e, inoltre, per Cristo l'immaginazione era una semplice forma dell'amore e l'amore era sovrano nel senso più esteso del termine. Circa sei settimane fa il medico mi accordò il permesso di mangiare del pane bianco invece del ruvido pane nero o bigio del regime ordinario. È una vera ghiottoneria. Parrà strano che del pane secco possa essere una ghiottoneria. Per me lo è a tal punto che, alla fine di ciascun pasto, io mangio accuratamente le briciole rimaste sul mio piatto di metallo o cadute sulla grossa salvietta che ci serve di tovaglia per non sporcare la tavola; e non lo faccio per fame – il vitto che mi dànno è sufficiente – ma solo per non perdere nulla di ciò che mi è dato. È in questo modo che bisogna considerare l'amore.
Cristo, come tutte le figure affascinanti, aveva il potere non soltanto di dire lui stesso delle cose belle, ma anche di farsi dire delle belle cose dagli altri. E a me piace la storia, che ci racconta San Marco, d'una donna greca la quale, dicendole Cristo (per mettere alla prova la sua fede) di non poterle dare il pane dei figli d'Israele, – replicò che i piccoli cani – Κυνάιρια – accucciati sotto la tavola, si nutrono delle briciole che i bimbi fanno cadere.
La maggior parte degli uomini vivono per l'amore e per l'ammirazione, ma invece è per mezzo dell'ammirazione e dell'amore che noi dovremmo vivere. Se alcuno ci mostra dell'amore, noi dovremmo riconoscere che ne siamo perfettamente indegni. Nessuno è degno d'essere amato. Il fatto che Dio ama l'uomo ci prova che, nell'ordine divino delle cose ideali, è stabilito che un eterno amore sarà dato a chi ne è eternamente indegno. Ovvero, se questa frase sembra troppo amara, diciamo che tutti gli uomini sono degni d'amore, tranne coloro che possono esserlo. L'amore è un sacramento che bisognerebbe accogliere in ginocchio e Domine, non sum dignus dovrebbe essere la frase di coloro che lo ricevono, sulle loro labbra e nel loro cuore.
Se io scriverò ancora nel senso di creare un'opera d'arte, due sono i soggetti, sopra tutto, sui quali e per mezzo dei quali voglio esprimermi; uno è «Cristo come precursore dell'atteggiamento romantico nella vita» l'altro: «La vita artistica considerata ne' suoi rapporti con la condotta umana». Il primo è, senza alcun dubbio, assai seducente, perchè io vedo in Cristo non solo il principio essenziale del supremo tipo romantico, ma anche tutte le contingenze e le stesse perversità del temperamento romantico. Egli fu il primo a dire agli uomini di vivere come i fiori e ha fissato sempre la frase. Cristo prese i fanciulli come tipo e modello per le aspirazioni umane. Li propose come esempio ai loro genitori – cosa che io ho sempre pensato, se è vero che si deve giovarsi di ciò che è perfetto.
Dante descrive l'anima dell'uomo come proveniente da Dio «che piangendo e ridendo pargoleggia» ed anche Cristo aveva veduto che l'anima di ciascuno di noi dovrebbe essere a guisa di fanciulla – che piangendo e ridendo pargoleggia. Sentì che la vita è mutevole, fluida, attiva e che permetterle di stereotiparsi in una forma qualsiasi, significa farla morire. Cristo disse che gli uomini non devono preoccuparsi eccessivamente dei loro interessi materiali e comuni; che solo il liberarsi dalle faccende pratiche è una cosa importante. Gli uccelli non si affannano per interesse di sorta. Perchè l'uomo, dunque, se ne cruccia? È delizioso, quando afferma: «Non curatevi del domani; l'anima non val più che la carne? E il corpo più della veste?» Un greco avrebbe potuto usare quest'ultima frase. Essa è piena di sentimento greco. Ma solo Cristo poteva enumerarle tutte e due e riassumere così perfettamente la vita.
La sua morale è tutta di simpatia, appunto come dev'essere la morale. Se non avesse mai detto altro che queste parole: «I suoi peccati le sono perdonati, perchè ha molto amato», metterebbe il conto di morire per averle dette. La sua giustizia è una giustizia tutta poetica, appunto come la giustizia dev'essere. Il malfattore andrà in paradiso, perchè è stato infelice; io non trovo una ragione migliore per mandarvelo. Gli artigiani che non hanno lavorato che un'ora sola nella vigna e durante la fresca brezza della sera, riscuotono lo stesso salario di coloro che hanno sudato tutto il giorno in mezzo ai tralci, sotto la sferza del sole. Probabilmente, nessuno meritava di essere pagato. O, forse, gli artigiani erano differenti? Cristo non aveva nessun trasporto per i sistemi meccanici, privi d'anima, che trattano gli uomini come se fossero degli oggetti e trattano tutto il mondo alla stessa stregua: per lui non esistevano leggi; c'erano semplicemente delle eccezioni; come se ogni uomo od ogni cosa non trovassero alcun simile.
Ciò che forma il tono stesso dell'arte romantica era per Cristo il vero fondamento della vita naturale. Non ne scorgeva altro. E quando gli fu condotta innanzi una donna sorpresa in flagrante adulterio e gli fu indicata la sentenza della legge e gli venne chiesto ciò che occorreva fare, egli continuò a scrivere col suo dito sulla sabbia come se non avesse udito, e quando lo si esortò a rispondere, alzò la testa e disse: «Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra». Mette conto di vivere per pronunciare una simile frase.
Come tutte le nature poetiche, egli amava gl'ignoranti. Ben egli sapeva che nell'anima d'un essere ignorante c'è sempre posto per una grande idea. Ma non poteva sopportare gli stupidi, specie coloro che sono resi tali dall'educazione: gli uomini pieni d'opinioni delle quali non ne capiscono neppur una – tipo particolarmente moderno, messo in luce da Cristo quando lo dipinge come il tipo di colui che possiede la chiave della conoscenza, ma che, incapace di servirsene per conto proprio, impedisce anche agli altri di usarla, quantunque essa possa aprire la porta del regno del Cielo. Contro i Filistei egli condusse la sua più fiera campagna. È la guerra che devono combattere tutti i figli della luce. Il Filisteo era la figura caratteristica dell'età e dell'ambiente nel quale Cristo viveva. Con la loro opaca rispettabilità, la loro noiosa ortodossia, con la loro esclusiva preoccupazione del lato volgarmente materialistico della vita e la loro prosopopea di se stessi e della propria importanza, i Giudei di Gerusalemme, al tempo di Cristo, erano l'immagine esatta del filisteismo britannico del nostro tempo. Cristo si beffò dei «sepolcri imbiancati» e la sua frase rimase eterna. Trattò il successo materiale come una cosa da disprezzarsi assolutamente. Non voleva vedere in esso nulla d'importante. Considerava la ricchezza come un ingombro per l'uomo. Non voleva affatto sentir parlare di sacrificio della vita a un qualunque «sistema» di pensiero o di morale. Mostrò che le forme e le cerimonie erano fatte per l'uomo e non già l'uomo per le forme, le convenzioni e le cerimonie. Prese l'idolatria del sabato a bersaglio delle sue sfide. Le filantropie a freddo, le ostentate carità pubbliche, i massacranti formalismi così cari allo spirito dei mediocri – tutto denunciò con uno sdegno implacabile. Per noi l'ortodossia è semplicemente un'acquiescenza facile e idiota, ma per essi e nelle loro mani era una tirannide terribile e paralizzatrice. Cristo la ripudiò. Sostenne e provò che soltanto lo spirito contiene un valore. Quasi con un maligno piacere dimostrava loro che, malgrado lo studio continuo della legge e dei profeti, essi non avevano, in realtà, la più piccola idea di quel che le une e gli altri significassero. Al contrario della loro suddivisione di ogni giornata in una serie fissa di pratiche prescritte, come un tritume di menta e di ruta, egli predicò l'enorme valore di vivere per l'ora presente.
Coloro ch'egli salvò dai peccati, furono salvi soltanto per merito di alcuni momenti belli nella loro vita. Nel veder Cristo, Maria Maddalena spezza il ricco vaso d'alabastro donàtole da uno de' suoi amanti e sparge gli aromi sui piedi stanchi e polverosi del Maestro; ed è appunto in forza di questo momento unico ch'ella è posta per sempre, con Ruth e Beatrice, in mezzo alle ghirlande di rose bianche del Paradiso. Tutto ciò che Cristo ci insegna con piccoli mòniti si è che ogni istante della nostra vita deve essere bello, che l'anima ha da essere pronta per l'arrivo dello sposo, sempre attenta alla voce dell'amante – poichè il Filisteismo è semplicemente quel lato dell'indole dell'uomo che non s'illumina alla fiamma dell'immaginazione. Cristo vede tutte le più splendide facoltà della vita come delle attitudini luminose: la stessa immaginazione è la luce del mondo. Il mondo è creato da lei e tuttavia non la comprende; il che si spiega, poichè l'immaginazione è un manifestarsi dell'amore ed è l'amore e la facoltà d'amare che distinguono tra loro gli esseri umani.
Senonchè, gli è nelle sue relazioni con i peccatori che Cristo è sopra tutto romantico, nel senso più reale della parola. Il mondo aveva sempre venerato i santi, perchè sono i più prossimi alla perfezione di Dio. Cristo, invece, guidato da un istinto divino, sembra che abbia sempre amato il peccatore come il più prossimo alla perfezione dell'uomo. Il suo desiderio originario non era già quello di redimere gli uomini – come non era di lenire il dolore. Trasformare un ladro interessante in un onest'uomo noioso – non era proprio il suo scopo. Egli avrebbe avuto una ben misera idea della Società per la Redenzione dei Carcerati e d'altre iniziative moderne del medesimo genere. La conversione d'un pubblicano in un fariseo non gli sarebbe parsa un atto molto degno di gloria. Ma egli considerava il peccato e la sofferenza in una maniera che il mondo non ha peranco compreso, come due cose belle e sante, come forme di perfezione.
Questa sembra un'idea pericolosa ed è pericolosa, di fatti, come tutte le grandi idee. Ma non c'è nessun dubbio ch'era veramente il credo di Cristo. Ed io non esito a ritenerla una verità straordinaria.
Certo, occorre che il peccatore si penta. Ma perchè? Per la semplice ragione che, altrimenti, non potrebbe rendersi conto di ciò che ha fatto. L'istante del pentimento è quello stesso dell'iniziazione. È anche più: è il mezzo col quale si muta il proprio passato. I Greci non reputavano possibile tutto ciò. Spesso affermano nei loro aforismi gnòmici: «Nemmeno gli Dei potrebbero mutare il loro passato». Ebbene – Cristo ha mostrato che il più comune dei peccatori può farlo e che anzi è l'unica cosa che può fare.
Se ne fosse stato richiesto, Cristo, ne sono sicuro, avrebbe risposto che nell'istante in cui il figlio prodigo cadde in ginocchio davanti al padre e ruppe in singhiozzi, egli trasformò le sue orgie, le sue umiliazioni e la sua degradazione in altrettanti momenti belli e santi della propria vita. È difficile, lo so, per la maggior parte degli uomini, l'afferrare una idea siffatta. Oso dire che bisogna andare in prigione per poterla comprendere. E se così è, vale veramente la pena di vivere in una galera.
C'è qualche cosa di così unico, in Cristo! Certo – come ci sono delle false aurore prima dell'aurora vera e dei giorni d'inverno incredibilmente dolci di sole che ingannano il croco e gli fanno sciupare l'oro anzi tempo o spingono il troppo ingenuo uccello al canto per invitare la sua compagna a costruire un nido su delle frasche ignude – così ci furono dei cristiani avanti Cristo. E siamone loro riconoscenti. Ma il male si è che non ce ne furono più dopo di lui. Faccio un'eccezione: San Francesco d'Assisi. Ma Dio gli aveva dato sin dalla nascita un'anima di poeta ed egli stesso, nella sua prima giovinezza, aveva tolto in mistiche nozze la sua sposa Povertà; con l'anima d'un poeta e il corpo d'un mendicante, San Francesco non percorre troppo difficilmente la via della perfezione. Egli comprese Cristo e così divenne simile a Lui. Non abbiamo bisogno del Liber conformitatum per apprendere che la vita di San Francesco è la vera Imitazione di Cristo; – poema che, comparato al Liber, non è che una prosa.
Sicuramente, il fascino di Cristo si è ch'egli è in tutto e per tutto simile ad un'opera d'arte. Non c'insegna nulla, in realtà; ma pel solo fatto d'essere condotti alla sua presenza si diventa qualcosa di più. E ciascuno di noi è predestinato a questa presenza. Almeno una volta nella sua vita, ogni uomo cammina con Cristo sino ad Emmaüs.
Ora – per ciò che riguarda l'altro soggetto, vale a dire il rapporto della Vita Artistica con la Condotta Umana, vi sembrerà certamente strano ch'io l'abbia scelto. La gente si mostra a dito il carcere di Reading e dice: «Ecco là a che cosa conduce una vita artistica!» Che monta? essa potrebbe menare anche a dei luoghi peggiori. Gli uomini meccanizzati pei quali la vita è una continua speculazione, dipendente da uno scrupoloso calcolo di mezzi e di sistemi, – essi lo sanno sempre dove vogliono arrivare e ci arrivano. Si mettono in cammino col desiderio ideale d'essere sagrestani della loro parrocchia e, qualunque sia la sfera in cui agiscono, finiscono sempre coll'essere sagrestani della loro parrocchia, e nulla più. Un individuo che brama di divenire qualcosa di diverso da sè stesso, cioè: d'essere membro del Parlamento o pizzicagnolo che s'arricchisce o avvocato famoso o giudice o qualche cos'altro di ugualmente noioso, riesce con ogni probabilità a divenire ciò che desidera. Ed è così che trova il suo castigo. Coloro che vogliono una maschera sono condannati a portarla per sempre.
Ma con le energie dinamiche della vita e con coloro ne' quali queste forze s'incàrnano, tutto è diverso. Quelli che desiderano soltanto di essere sè stessi non sanno mai dove vanno. Non possono saperlo. In un senso del termine, è necessario e naturale il conoscere sè stessi, – come disse l'oràcolo ellenico; questo è il primo passo della conoscenza. Ma riconoscere che l'anima d'un uomo è inconoscibile – ecco l'ultimo risultato della saggezza. Il mistero finale risiede in noi stessi. Dopo aver pesato il calore e la massa del sole, misurate le fasi della luna, disegnate le mappe dei sette cieli, stella per stella, – è ancora l'«io» in sè, che rimane. Chi può calcolare l'orbita della propria anima? Quando il figlio si pose in cammino per rintracciare gli asini di suo padre, egli non sapeva che l'uomo di Dio lo aspettava con la crèsima della consacrazione e che la sua anima era già quella di un re.
Spero di vivere abbastanza per produrre un'opera di tal carattere ch'io possa dire alla fine dei miei giorni: «Sì!; ecco a che cosa può condurre un uomo, una vita Artistica!» Due delle vite più perfette ch'io mi conosca sono quelle di Verlaine e del principe Kropotkine. Entrambi hanno passato degli anni in prigione; il primo è l'unico poeta cristiano dopo Dante; l'altro possiede una bella anima di Cristo candido, come ci si attende che debbano venirne dalla Russia. Durante gli ultimi sette od otto mesi, – nonostante una serie di crucci che mi son venuti dal mondo esterno (quasi senza interruzione) – mi sono messo in contatto immediato con uno spirito nuovo che agisce in questo carcere per mezzo degli uomini e delle cose e che mi ha soccorso in modo indicibile; cosicchè io, che per tutto il primo anno della mia reclusione non ho fatto che torcermi le mani, ben mi ricordo, e gridare con una impotente disperazione: «Quale tracollo! Quale spaventevole fine!», adesso invece tento di dirmi e, qualche volta, quando non mi torturo da me stesso, realmente e sinceramente mi dico: «Quale nuovo principio! Quale meraviglioso principio!» Può darsi che sia così, in realtà. Può darsi che la cosa divenga così. E allora quanto io dovrei a questa personalità nuova che trasforma l'esistenza di ognuno, anche qua dentro!
Vi sarà possibile comprenderlo, quando vi dirò che, se fossi stato liberato nel maggio scorso (come desideravo), avrei lasciato questo luogo con l'anima piena di amaro odio contro di esso e contro i carcerieri – ma questo sentimento cattivo avrebbe poi avvelenato la mia vita. Ho subìto un anno di reclusione di più, ma un senso vivo d'umanità è pur stato in carcere con tutti noi ed ora, quando me ne andrò, io mi rammenterò sempre le grandi premure che quasi tutti qui hanno avuto per me; e il giorno della mia liberazione rivolgerò un grazie a non pochi, e domanderò loro in ricambio che si ricordino qualche volta di me.
I sistemi della prigione sono assolutamente e interamente crudeli. Molto darei per poterli cangiare. Ho intenzione di fare questo tentativo. Ma quantunque un sistema sia così difettoso, lo spirito d'umanità – che è poi lo spirito d'amore (lo spirito di Cristo che non si trova dentro le chiese) – riesce almeno a farlo sopportare senza troppa amarezza, se non proprio a mutarlo radicalmente.
So anche che, fuori, mi aspettano innumerevoli e deliziose cose, da quelle che San Francesco chiama «frate vento e sorella piova» alle vetrine dei negozi e ai tramonti delle grandi città. Se facessi un elenco di tutto ciò che ancor mi rimane, non so dove mi fermerei, perchè veramente Dio ha creato il mondo, tanto per me quanto per gli altri. Forse io uscirò di qui in possesso di qualche cosa che prima non avevo. Non ho bisogno di dirvi che per me le riforme della morale sono insignificanti e volgari come quelle della teologia. Ma, mentre la risoluzione d'essere un uomo migliore è un atto sperimentale ed ipocrita – essere divenuto, invece, più profondamente uomo è il privilegio di coloro che hanno sofferto; – ed io credo d'esserlo divenuto.
Se, quando sarò libero, uno de' miei amici darà una festa senza invitarmi, io non troverò nulla a ridire. Posso essere perfettamente felice solo con me stesso. Con la libertà, i fiori, i libri e la luna, chi non sarebbe felice? D'altra parte, le feste non sono più fatte per me. Ne ho date troppe, perchè debba curarmene ancora. Questo lato della vita è finito per me – assai fortunatamente, oso dire. Ma se, quando sarò libero, uno de' miei amici avesse un dolore e m'impedisse di prendervi parte, ne risentirei un'amarezza infinita. S'egli mi sbarrasse le porte della casa in lutto, io ritornerei chissà quante volte a supplicarlo d'esservi ammesso, pur d'avere la mia parte di ciò cui ho diritto. S'egli mi reputasse incapace e indegno di piangere con lui, ne proverei l'umiliazione più sanguinosa; considererei la sua ripulsa come la maniera più terribile per avvilirmi. Ho un diritto di partecipare al dolore e colui che può contemplare la bellezza del mondo, sentendone anche la sofferenza, comprendendo entrambe le meraviglie, – colui è in contatto con le cose divine e s'è avvicinato al segreto di Dio per quanto è possibile.
Giova credere che nella mia arte, non meno che nella mia vita, vi sarà una nota più profonda ancora – una nota di più grande unità di passione e d'impulso. È l'intensità e non la latitudine lo scopo vero dell'arte moderna. Nell'arte non dobbiamo più occuparci del tipo, ma dell'eccezione. Io non posso dare alle mie sofferenze nessuna delle forme reali che assunsero. L'Arte comincia là dove l'Imitazione finisce; ma qualcosa penetrerà nella mia opera, una pienezza di memoria verbale, di cadenze più ricche, di effetti più curiosi, di un ordine architettonico più semplice – per lo meno di un'altra qualità estetica.
Quando Marsia fu «strappato dalla vagina delle sue membra» – dalla vagina delle membra sue, per usare la frase di Dante, d'una concisione terribile, addirittura tacitiana – egli non ebbe più nessun canto sulle sue labbra, dicono i Greci. Apollo aveva vinto. La lira aveva vinto la zampogna. Ma forse i Greci si sono ingannati. Io odo il grido di Marsia in una gran parte dell'arte moderna. È amaro in Baudelaire, dolce e lamentevole in Lamartine, mistico in Verlaine. Si ritrova nelle catharsi lente della musica di Chopin. E nelle donne di Burne-Jones. Anche Matteo Arnold ce lo fa udire, sebbene egli ci parli, nel suo canto di Callicle, del trionfo «della dolce e suadente lira» e «della famosa ultima vittoria», con una così bella, tersa nota di lirismo. Nel mormorio irrequieto di dubbio e di affanno che pervade i suoi versi, nè Goethe nè Wordsworth giovarono in alcun modo a Matteo Arnold, per quanto egli li abbia seguiti di volta in volta; e quando vuol dolersi del fato di Tirsi o celebrare lo scolaro Gypsy, gli occorre pur prendere la zampogna per esprimere il suo tormento. Ma, insomma, sia o non sia stato muto il fauno di Frigia – io non posso essere silenzioso. L'espressione mi è tanto necessaria quanto le foglie e i fiori lo sono per i rami neri degli alberi che s'intravvedono al di là delle mura della prigione e che senza posa si àgitano nel vento. Tra la mia arte e il mondo – c'è ora un vasto gorgo, ma tra l'arte e me stesso non ce n'è alcuno, almeno io lo spero.
A ciascuno di noi – la sua sorte. Il mio destino è stato di pubblica infamia, di lunga prigionia, di miseria, di rovina, di sventura, di fiele, ma io non ne sono degno – in ogni caso non ne sono ancor degno. Mi sovviene d'aver detto spesso che avrei potuto sopportare una tragedia reale, pur ch'ella mi si presentasse con un mantello di porpora e con la maschera d'un nobile dolore; ma ciò che v'è di orribile nella vita moderna si è ch'essa riveste la tragedia coi cenci della commedia, in modo che le più grandi realtà sembrano banali o grottesche o prive di stile. Questa è la perfetta verità intorno all'esistenza moderna. Si dice che tutti i martiri sembrano meschini a chi li osserva. Il secolo decimonono non fa eccezione alla regola.
Tutto, nella mia tragedia, è stato orrido, ripugnante, privo di stile: la nostra casacca stessa ci rende grotteschi. Noi siamo i buffoni del dolore; siamo i pagliacci dal cuore spezzato. Siamo designati in modo speciale per essere gli zimbelli dei belli-spiriti. Il 13 novembre 1895 fui condotto da Londra a qua. Quel giorno, dalle due alle due e mezza, fui costretto a restare sulla banchina centrale della stazione di Clapham Junction, in uniforme da prigioniero colle manette ai polsi – come uno spettacolo per la folla. Mi avevano fatto uscire dall'infermeria senza darmi un momento di riposo. Ero più grottesco di qualsiasi altro immaginabile oggetto. Nel vedermi, la gente si metteva a ridere. Ad ogni treno, il circolo dei curiosi si ingrossava. Nulla li avrebbe divertiti maggiormente. E tutto ciò, è naturale, fino a che non seppero chi io ero; ma appena ne furono informati, risero anche di più. Per una mezz'ora intera io rimasi là, sotto la pioggia sottile di novembre, in mezzo alla folla che mi scherniva!
E durante un anno da quel giorno, ad ogni volger di sole, alla medesima ora, io piangevo per uno stesso spazio di tempo. Oh, non è una cosa tanto tragica come sembra! Per i prigionieri, le lagrime fanno parte dell'esperienza quotidiana. Una giornata in carcere senza pianto è una giornata in cui il cuore è duro e non è una giornata in cui il cuore possa essere felice.
Adesso, però, comincio a provare più rimorso per coloro che risero di me, che per me stesso. Certo, quando essi mi videro, io non ero più sul mio piedestallo – ero alla gogna. Ma sono le nature assai poco fantasiose che si preoccupano solamente degli uomini eretti sur un piedestallo. Un piedestallo può essere una cosa del tutto irreale. Una gogna, invece, è una terribile realtà. Essi avrebbero dovuto saper meglio interpretare il dolore. Ho detto già che dietro il dolore c'è sempre il dolore. Sarebbe più esatto dire che dietro il dolore c'è sempre un'anima. Ora – beffarsi di un'anima in pena è cosa terribile. Nell'economia stranamente semplice del mondo non si riceve se non ciò che si dona e a coloro che non hanno abbastanza forza per penetrare l'aspetto esterno delle cose e sentire la pietà, quale pietà si può dare se non quella del disprezzo?
Riferisco queste cose semplicemente perchè si comprenda quanto mi è stato difficile trarre dal mio castigo ben altro che amarezza e disperazione. Eppure mi tocca estrarne una cosa diversa e, di quando in quando, ho dei periodi di sottomissione e di rassegnazione. La primavera intera può essere racchiusa nell'unica gèmmula d'una pianta e il nido dell'allodola a fior della terra può contenere la gioia che annuncerà la comparsa d'innumerevoli aurore color di rosa e di porpora. Così, forse, ciò che mi resta ancora di bellezza di vita è racchiuso in qualche àttimo d'abbandono, di diminuzione di me stesso e d'umiliazione. Tuttavia, io posso semplicemente continuare a perseguire il mio proprio sviluppo e, accogliendo tutto ciò che mi è accaduto, rendermene degno.
Alcuni avevano l'abitudine di dire ch'io ero troppo individualista. Ora, più che mai, mi occorre essere individualista. Devo cavar fuori da me stesso molto di più di quel ch'io ne abbia tratto sin qui ed esigere dal mondo assai meno di quanto gli abbia mai domandato. La mia rovina, in vero, deriva non da eccessivo individualismo, ma dal suo difetto. L'azione ignominiosa, imperdonabile ed eternamente disprezzabile della mia vita fu di avere accondisceso a rivolgermi alla società per ottenerne aiuto e protezione. Scendere a questo sarebbe stato un errore, dal punto di vista dell'individualismo, ma quale scusante invocare, dopo aver compiuto una cosa simile? Naturalmente una volta messe in moto le macchine della Società, essa si rivolse contro di me e disse: «Come! tu hai vissuto fino ad ora disprezzando le mie leggi, ed ora vieni a domandarmi aiuto per mezzo di queste leggi stesse? Bene: ti saranno applicate col massimo rigore. Sarai obbligato a sottometterti alle leggi che hai invocato». L'effetto è questo: ch'io sono in carcere. Certo, nessun uomo cadde così ignobilmente e con dei metodi tanto ignobili.
L'elemento filisteo della vita non consiste nell'incapacità di comprendere l'arte. Ci sono degli esseri piacevoli, come ad esempio i pescatori, i pastori, gli operai, i contadini ed altri che non s'intendono d'arte, e pure sono il vero sale della terra. Filisteo è quegli che sostiene ed aiuta le forze meccaniche, pesanti, ingombranti e cieche della società; e che non arriva ad ammettere un'energia dinàmica quando s'imbatte in essa, sia incarnata in un uomo o in un'azione qualunque.
Han giudicato spaventevole da parte mia il fatto d'aver invitato a pranzo dei cattivi soggetti e d'essermi compiaciuto in loro compagnia. Ma, dal punto di vista nel quale io mi ponevo come uomo d'arte, essi erano deliziosamente suggestivi ed eccitanti. Il pericolo formava la metà del piacere... In quanto artista, avrei dovuto interessarmi solo d'Ariele e non mettermi a lottare con Calibano...
Uno de' miei grandi amici – d'un'amicizia decennale – venne a trovarmi qualche tempo fa e disse che non credeva nemmeno a una parola di tutto ciò che si era macchinato contro di me e s'augurava ch'io mi persuadessi d'essere considerato da lui assolutamente innocente e vittima d'una vile congiura.
Non potei frenare le mie lagrime nell'ascoltarlo e gli risposi che, nonostante le accuse interamente false formulate contro di me e a malgrado delle colpe attribuitemi per malvagità imperdonabile, tuttavia la mia vita era stata piena di piaceri crudeli e che non m'era più possibile restare suo amico o trovarmi ancora in sua compagnia altro che a patto ch'egli accettasse la mia confessione e vi credesse pienamente. Fu per lui un grave colpo; ma noi siamo rimasti amici e almeno non ho ottenuto il dono della sua amicizia con l'ipocrisia.
Le forze dell'emozione, come ho detto in qualche passo delle Intenzioni, sono altrettanto limitate in latitudine ed in durata quanto le energie fisiche. La piccola coppa che è foggiata in modo da contenere una data misura di liquido non può contenerne una stilla di più, anche se le cantine della Borgogna traboccassero di vino e i vignaiuoli pestassero sino al ginocchio il raccolto dei sassosi vigneti di Spagna. Non c'è errore più diffuso del pensare che coloro i quali sono le cause o le occasioni d'una grande tragedia siano poi partecipi dei sentimenti che si convengono alla tragedia stessa; nessun errore è più fatale che aspettarsi questi sentimenti da parte loro. Il martire, nel suo «sudario di fiamma» può contemplare il volto del Signore, ma per colui che ammucchia le fascine o che attizza i ceppi affinchè ardano, lo spettacolo non è più impressionante della morte d'un bue per il macellaio, o della caduta d'un albero pel boscaiolo o d'un fiore per il falciatore dei prati. Le grandi passioni sono per coloro che hanno una grande anima e i grandi avvenimenti non possono essere veduti e compresi se non da quelli che sono al loro stesso livello.
In tutto il dramma, dall'angolo visuale artistico, io non conosco nulla che sia da paragonarsi alla creazione shakesperiana di Rosencrantz e Guildenstern, nulla che sia più suggestivo in quanto a finezza d'osservazione. Essi sono i camerati di Amleto. Ne furono già i compagni. Recan con sè il ricordo delle piacevoli giornate trascorse assieme. Nel momento in cui essi incontrano Amleto, nel dramma, egli vacilla sotto un peso insostenibile per chiunque abbia il suo temperamento. I morti sono balzati in armi dalla tomba per imporgli un compito al tempo stesso troppo grande e troppo angusto per lui. È un sognatore costretto alla azione. Amleto è un poeta e gli si comanda di misurarsi con la doppia complessione della causa e dell'effetto, con la vita nella sua contingenza pratica (della quale nulla conosce) e non con la vita nella sua essenza ideale ch'egli penetra tanto bene. Egli non ha nessuna idea di ciò che convenga fare e la sua follìa consiste nel simulare la follìa. Bruto si servì della demenza come d'un mantello per nascondervi sotto la spada, la daga della sua volontà, ma la pazzia d'Amleto è una semplice maschera per dissimulare la propria debolezza. Facendo dello spirito, abbandonandosi a degli scherzi, egli crede di ottenere una via di scampo. Si ostina a giocare coll'azione come un artista gioca con una teoria. Fa la spia a' suoi stessi atti e, sentendosi parlare, egli sa che non sono altro che «parole, parole, parole». Invece di tentare di essere l'eroe della sua storia, cerca d'essere lo spettatore della sua tragedia. Dubita di tutto, compreso sè stesso, e tuttavia il suo dubbio non l'aiuta, perchè non è effetto di uno scetticismo, ma di una volontà che si scinde.
Di tutto ciò Rosencrantz e Guildenstern non capiscono niente. Essi sorridono, si piegano, fanno i graziosi e quel che l'uno dice l'altro lo ripete, sempre sul medesimo tono. Quando, infine, per mezzo del dramma intercalato nel dramma e delle tenerezze che si scambiano gli attori, Amleto «sorprende la coscienza» del Re e lo caccia dal suo trono, miserabile e spaventato, Guildenstern e Rosencrantz non vedono nel suo gesto che una penosa infrazione alle regole dell'etichetta di corte. Sino a questo punto e non più oltre essi possono giungere «nella contemplazione dello spettacolo della vita con delle emozioni adeguate». Eglino sono i più vicini al suo segreto e non ne sanno nulla. E non gioverebbe a niente il rivelarlo loro. Essi sono la piccola coppa che contiene una determinata misura e basta. Verso la fine, com'è detto, essi hanno trovato o troveranno una morte improvvisa, caduti in un'insidia tesa per un altro. Ma una fine tragica di tal fatta, benchè lo spirito d'Amleto la sfiori un poco con la sorpresa e la giusta aria della commedia, non si conviene realmente a dei personaggi come loro. Essi non muoiono mai. Horazio, il quale, per «difendere dinnanzi ai malcontenti Amleto e la sua causa»,
Absents him from felicity a while
And in this harsh world draws his breath in pain,
muore, ma Guildenstern e Rosencrantz sono immortali come Angelo e Tartufo e devono essere collocati assieme a loro. Essi sono la metamorfosi che la vita moderna ha fatto dell'antico ideale dell'amicizia. Colui che scriverà un nuovo trattato de Amicitia dovrà serbar loro un cantuccio e tesserne l'elogio in prosa tuscolana. Sono tipi oramai fissati per tutti i tempi. Censurarli equivarrebbe a mostrare «una mancanza d'apprezzamento». Si trovano semplicemente fuori della loro sfera – ecco tutto. Quanto a sublimità d'anima, non c'è pericolo di contagio. Gli alti pensieri e le grandi emozioni sono isolati dal fatto stesso della loro esistenza.
Se tutto va bene, io sarò liberato verso la fine di maggio e spero di partir subito per qualche piccolo villaggio marittimo straniero, con R... e M...
Il mare, come dice Euripide in uno de' suoi poemi su Ifigenia, lava le macchie e le ferite del mondo.
Spero di vivere almeno un mese con i miei amici, di ritrovare la calma e l'equilibrio, un cuore meno torturato e delle aspirazioni più tranquille. Provo uno strano desiderio per le grandi cose semplici e primordiali, come il mare che è una madre per me al pari della terra. Mi sembra che tutti noialtri si contempli troppo la natura, e, viceversa, si viva troppo poco in comunione con essa: vedo una grande ragione nell'attitudine dei Greci. Essi non ragionavano mai intorno ai tramonti del sole e nemmeno disputavano per decidere se le ombre sui prati erano violacee o no. Ma vedevano che il mare è fatto per il nuotatore e la sabbia per il corridore. Amavano gli alberi per l'ombra che diffondono e la foresta per il suo raccolto silenzio nell'ora del meriggio. Il vignaiuolo intrecciava dell'edera ne' suoi capelli per difendersi dai raggi del sole, quando s'affaticava intorno ai tralci pur mo' nati; e l'artista e l'atleta, i due tipi che l'Ellade ci ha dato, intrecciavano in ghirlande le foglie d'alloro amaro e la cicuta che non sarebbero state altrimenti utili all'uomo.
Siam soliti denominare la nostra età utilitaria e non c'è una cosa sola di cui noi sappiamo esattamente gli usi. Abbiamo dimenticato che l'acqua può forbire, il fuoco purificare e che la terra è la madre di noi tutti. Per conseguenza – la nostra arte è priva di luce, come la luna, e si diverte con delle ombre, mentre l'arte dei Greci ha i lampeggiamenti del sole e interpreta direttamente le cose. Sono convinto che c'è una purificazione nelle forze elementari e voglio ritornare ad esse e con esse vivere.
Certo, per uno spirito moderno come me, «figlio del mio tempo» contemplare semplicemente il mondo sarà sempre una delizia. Tremo di piacere, pensando che il giorno in cui sarò libero il citiso ed i lillà fioriranno nei giardini ed io vedrò il vento agitare, con una rabbrividente bellezza, l'oro dell'uno e la pallida porpora dell'altro, in modo che la terra avrà per me tutti i profumi d'Arabia. Linneo cadde in ginocchio e pianse di felicità, quando vide per la prima volta le estese brughiere d'un altipiano inglese tutte gialle dei fiori agresti e aromatici dei giunchi, ed io so che per me, posseduto dallo stesso desiderio dei fiori, ci son delle lagrime che m'aspettano nei petali d'una rosa. È sempre stato così, sino dalla mia infanzia. Non c'è una sola sfumatura nascosta in fondo al calice d'un fiore, non c'è la curva e molle linea d'una conchiglia cui la mia anima – per una misteriosa e sottile simpatia con l'anima delle cose – non faccia eco. Come Teofilo Gauthier io son uno di quelli pei quali il mondo esterno esiste.
Pur tuttavia, ora ho coscienza che sotto tutta questa bellezza, per quanto soddisfacente essa sia, c'è qualche spirito nascosto le cui forme e i cui contorni dipinti non sono che pure manifestazioni ed è con questo spirito ch'io voglio mettermi in armonia. Sono stanco delle formule fisse degli uomini e delle cose. Il Mistico nell'Arte, il Mistico nella Vita, il Mistico nella Natura – ecco ciò che io cerco. Ho assolutamente bisogno di trovarlo in qualche luogo.
Ogni volta che si subisce un giudizio, tutta la vita vien giudicata – come tutte le sentenze sono delle sentenze di morte; ed io sono stato ben tre volte in giudizio! La prima volta, lasciai la sala per essere arrestato; la seconda, per essere ricondotto al carcere di detenzione; la terza, per venir cacciato in galera per due anni. La società, come noi l'abbiamo costituita, non avrà più alcun posto da offrirmi; ma la Natura le cui sottili pioggie cadono dolcemente sui giusti e sugli ingiusti avrà nelle sue roccie delle fessure dentro cui mi nasconderò e delle valli inesplorate nel silenzio delle quali potrò piangere senza essere distratto!
Essa appenderà delle stelle alle pareti della notte, affinchè io possa camminare senza inciampi in mezzo alle tenebre, e manderà il vento a soffiare sull'orma de' miei passi, in modo che nessuno mi dìa una caccia a morte; la natura mi laverà nelle sue grandi acque e mi risanerà con le sue erbe amare.
Noi non possiamo dividerlo per stagioni, ma soltanto renderci conto de' suoi modi e calcolarne i ritorni. Per noi, il tempo stesso non cammina; e sembra piuttosto descrivere un circolo intorno ad un centro di dolore. La paralizzatrice immobilità di un'esistenza in cui ogni particolare è regolato da un immutevole dèspota (in modo che noi mangiamo, beviamo, dormiamo e preghiamo – o, almeno, c'inginocchiamo per pregare – secondo le leggi di una formula ferrea); questo carattere statico che rende, fino nei più piccoli atti, ogni giornata uguale alla precedente, pare che si comunichi a tutte quelle forze esterne delle quali l'essenza consiste appunto in un mutamento continuo.
Noi non sappiamo nulla del periodo della semina o del raccolto, dei mietitori proni in mezzo alle spighe, o dei vendemmiatori sparsi tra i vigneti; nulla sappiamo dei prati verdi che gli alberi di primavera nevicano di petali e che gli alberi del verziere, in autunno, cospargono di frutti maturi – e nulla mai ne possiamo sapere.
Per noi non c'è che una stagione: quella del dolore. Sembra che ci abbiano anche defraudato del sole e della luna. Fuori il cielo può essere d'azzurro e d'oro, ma la grossa vetrata del piccolo abbaino dalle sbarre di ferro sotto cui ci si accuccia non lascia filtrare appena che una povera luce sporca. Dentro le celle c'è sempre la semichiarìa del crepuscolo; e il crepuscolo invade pure ogni cuore. Nell'orbita del pensiero, come in quella del tempo, il moto non esiste più. La cosa stessa che da gran pezzo voi, personalmente, avete dimenticato o che potete dimenticare con facilità, la medesima cosa mi succede ancora in questo stesso momento e mi accadrà nuovamente domani. Tenete presente tutto ciò e vi sarà possibile comprendere il perchè io scrivo in questo tono...
Una settimana dopo mi trasferiscono qui.. Passano ancora tre mesi e mia madre muore. Nessuno seppe quanto profondamente io l'amassi e la venerassi.
La sua morte fu per me una cosa terribile; ma io, già un tempo principe dello stile, non trovo nemmeno una parola per esprimere la mia angoscia e la mia vergogna. Essa e mio padre mi avevano lasciato in retaggio un nome glorioso d'onore e di nobiltà, non solo nei campi della letteratura, dell'arte, dell'archeologia e della scienza, ma anche nella storia del mio paese d'origine e nella sua evoluzione nazionale. Ebbene, io ho macchiato questo nome d'un obbrobrio eterno. Io ne ho creato un epiteto ignobile per il volgo. Io l'ho trascinato nel fango. Io l'ho dato in balìa dei bruti, affinchè lo rendano brutale ed ai nemici perchè ne facciano un sinonimo di follia. Quel che ho sofferto allora e lo strazio che ancor oggi io provo, no! nessuna penna lo potrà scrivere, nessun foglio di carta lo potrà rivelare. Mia moglie, sempre buona e nobile verso di me, temendo che la notizia della sciagura mi giungesse per mezzo di estranei, quantunque tanto malata, si mise in viaggio da Genova per l'Inghilterra per venire essa stessa ad annunciarmi questa perdita irreparabile. Le lettere di simpatia mi arrivarono da tutti coloro che avevano ancora serbato dell'affetto verso di me. E perfino delle persone che io non avevo mai conosciuto direttamente, quando seppero che una nuova disgrazia era venuta ad abbattersi sulla mia vita, scrissero, pregando di comunicarmi ch'essi m'erano accanto nel grande dolore...
Tre mesi passano. La tabella-calendario della mia condotta e del mio lavoro giornaliero, appesa esternamente sull'uscio della mia cella, con scrittovi sopra il mio nome e la mia condanna, m'informa che siamo giunti al mese di maggio...
La prosperità, il piacere e il successo possono essere volgari e refrattari, ma il dolore è la più sensibile di tutte le cose create. Nulla succede nel mondo del pensiero cui il dolore non faccia eco con delle vibrazioni infinitamente vive e terribili. In suo confronto, la sensibilissima foglia d'oro battuto, che indica la direzione delle forze che l'occhio non riesce ad afferrare, è grossolana.
Il dolore è una ferita che sanguina quando una mano la tocca, tranne quella dell'amore, ed anche premuta da una carezza buona essa fa sangue, quantunque non la strazi più la sofferenza.
Dovunque c'è il dolore ivi santa è la terra. Un giorno si capirà ciò che questo significa. Nulla si saprà prima di questo. *** e delle indoli come la sua, sì, possono comprendere. Quando, costretto fra due gendarmi, io fui condotto dalla mia prigione alla Corte dei Fallimenti, *** attese nel lungo e tragico corridoio per potersi togliere con atto grave il suo cappello davanti a me, in cospetto della folla che fu ridotta al silenzio da un gesto così semplice e così dolce, mentre io passavo innanzi a lui colle manette ai polsi e colla testa china.
Molti uomini si sono guadagnati il regno dei Cieli con delle opere assai meno meritevoli di questa. Non è con tale spirito, forse, e animati da simile amore che i Santi si inginocchiavano per lavare i piedi dei poveri o si curvavano per baciare sulle guancie i lebbrosi? Io non gli ho mai detto una parola di ciò ch'egli fece quel giorno. Non so nemmeno, in questo momento, s'egli pensa ch'io abbia potuto intravedere il suo atto.
Oh, non è una cosa per la quale si rivolgono dei ringraziamenti formali con delle parole formali! Io l'ho racchiusa nel tesoro del mio cuore. Ivi la serbo come un debito segreto che sono felice di pensare che non potrò assolvere mai. La imbalsamo e la rinfresco con la mirra e gli aromi d'infinite lagrime.
Guardate: la saggezza non mi riuscì di nessun profitto e la filosofia rimase infeconda e gli adagi e le frasi di coloro che tentarono di consolarmi furono come della polvere e della cenere nella mia bocca, ma il ricordo di quel piccolo gesto d'amore, adorabile e silenzioso, ha riaperto per me tutte le fonti della pietà, ha fatto fiorire il deserto come una rosa, m'ha strappato dalla disperazione solitaria dell'esilio per mettermi in armonia col grande cuore ferito e spezzato del mondo. Quando gli uomini saranno capaci di comprendere non solo quanto quel gesto fu bello, ma pure quale intimo significato ebbe per me e quale valore avrà per me sempre, allora forse essi sapranno in che modo e in quale stato d'animo mi devono avvicinare.
I poveri sono saggi e più caritatevoli e più propensi alla bontà di noialtri. Per loro la prigionia è una tragedia nella vita di un uomo, una sciagura, una disgrazia, qualche cosa, insomma, che merita la simpatia altrui. Essi parlano di colui che è in carcere come di uno che «passa un guaio», semplicemente. È l'espressione che adoperano sempre ed essa contiene la perfetta saggezza dell'amore. Invece, con le persone del nostro ceto è diverso. Per noi, la prigione trasforma un uomo in un paria. Io, e alcuni altri nel mio stesso caso, non abbiamo diritto nè all'aria, nè al sole. La nostra presenza turba la gioia degli altri.
Siamo ricevuti come degli intrusi, quando ritorniamo nel mondo. Non ci si vorrebbe lasciar godere nemmeno il chiaro di luna. E i nostri figliuoli non ce li portano via? Così ci si spezzano questi dolcissimi vincoli che ci ricollegano all'umanità. Siamo dannati alla solitudine, mentre i nostri figli sono pur vivi. Ci rifiutano l'unico mezzo che potrebbe guarirci e farci rinascere, l'unica dolcezza che sarebbe in grado di spandere un balsamo sul cuore angosciato e di mettere un po' di pace nell'anima in pena...
Bisogna, sì, ch'io mi dica che da me stesso io mi sono distrutto e che nessuno, piccolo o grande, non si può rovinare che con le sue proprie mani. Io sono pronto a dirlo; mi sforzo di confessarlo, quantunque, forse, in questo momento, non lo si creda. Senza alcuna compassione io sostengo contro di me l'implacabile accusa.
Per quanto terribile sia stato ciò che il mondo mi ha fatto di male, quel che io feci a me stesso fu più tremendo ancora.
Ero in simbolica comunione con l'arte e con la cultura del mio tempo. Sul principio della mia virilità lo avevo compreso e avevo, in seguito, forzato i miei contemporanei a comprenderlo. Pochi uomini, durante la loro vita, hanno occupato un posto simile al mio col pieno riconoscimento altrui. La posizione ideale di un artista è messa in luce, di solito (se pure lo è), dallo storico o dal critico, molto tempo dopo che l'artista e la sua età sono scomparsi. Invece, per me, la cosa accadde diversamente. Io ne ebbi la coscienza e la diedi anche agli altri.
Byron fu una figura simbolica, ma relativamente alla passione e alla stanchezza passionale della sua opera.
Il mio rapporto col mio tempo fu più nobile, più costante, d'una importanza e d'un valore più grandi.
Gli dèi m'avevano quasi tutto donato. Ma io mi lasciai poltrire e mi concessi dei lunghi periodi di tregua insensata e sensuale. Mi divertii a fare l'ozioso, il dandy, l'uomo alla moda. Mi circondai di poveri caratteri e di spiriti miserevoli. Divenni prodigo del mio proprio genio e provai una gioia bizzarra nello sperperare una giovinezza eterna. Stanco di vivere sulle cime, discesi volontariamente in fondo agli abissi per cercarvi delle sensazioni nuove. La perversità fu nell'orbita della passione quel che il paradosso era stato per me nella sfera del pensiero.
Infine il desiderio si cangiò in una malattia, o in una follìa, o in entrambe le cose. Divenni noncurante della vita altrui. Colsi il mio bene dove mi piacque e passai oltre. Dimenticai che ogni più piccola azione quotidiana forma o deforma il carattere e che, per conseguenza, ciò che si è compiuto nel segreto della propria intimità si sarà poi costretti a proclamarlo al mondo intero. Così, non fui più padrone di me stesso. Non riuscii più a dominare la mia anima e la ignorai. Permisi al piacere di governarmi e finii coll'essere abbattuto da una sventura orrenda. Adesso non mi rimane più che una cosa: l'assoluta umiltà.
Ecco quasi due anni, tra poco, che io sono in prigione! Da principio una selvaggia disperazione cominciò ad impossessarsi di me; mi abbandonavo a una pena tale ch'era disprezzabile anche a vedersi, a un'ira terribile ed impotente, all'angoscia e all'indignazione, alla tortura che mi strappava i più acuti singhiozzi, a una miseria che non aveva nessuna voce per esprimersi, a un dolore muto. Sono passato attraverso tutte le forme possibili della sofferenza. Meglio ancora di Wordsworth, io ben so ciò ch'egli intese di dire in quel suo distico
La sofferenza è costante e oscura e misteriosa,
e ha la natura dell'Infinito.
Ma quando, talvolta, io mi rallegro all'idea che le mie sarebbero interminabili, non potevo, però, sopportare ch'esse fossero prive di significato. Ora, io trovo riposta in un oscuro angolo della mia natura qualcosa che mi dice: nulla c'è al mondo che sia vuoto di senso ed il soffrire meno di qualunque altra cosa. Questo quid, nascosto nel più profondo del mio «io», come un tesoro in un campo, è l'Umiltà.
È l'ultima cosa che mi resta, e la migliore; è l'estrema scoperta alla quale io sono arrivato, è il punto di partenza di tutto uno sviluppo nuovo. È una verità che si è formata nel mio intimo essere e così pure io so ch'essa è venuta in un momento favorevole. Se alcuno me ne avesse parlato, l'avrei respinta; ma siccome l'ho trovata io stesso, ci tengo a serbarla. Bisogna ch'io la conservi! È l'unica cosa che ha in sè i germi della vita, di una nuova esistenza, una Vita Nuova per me. Tra tutte le cose, essa è la più strana; non si può acquistarla che a patto di rinunciare a tutto ciò che si possiede. E, solamente quando si è tutto perduto, ci si accorge di averla guadagnata.
Ora che ho capito ch'essa è in me, io vedo assai chiaramente ciò che in realtà occorre che io faccia. E allorchè adopero una frase come questa, non ho bisogno di aggiungere che non alludo a nessuna sanzione, a nessun ordine imperativo dal di fuori. Io non ne ammetto. Sono molto più individualista di quanto lo sia mai stato. Niente mi sembra che abbia il minimo valore, tranne ciò che si estrae dalla propria intimità. La mia indole è in traccia d'un nuovo mezzo di realizzazione: ecco tutto ciò di cui io devo preoccuparmi. E la prima cosa che mi occorre è questa: liberarmi di qualsiasi risentimento amaro contro il mondo.
Io sono completamente senza denaro, assolutamente senza focolare. Eppure c'è qualcosa di peggio, sulla terra. Sono del tutto sincero quando affermo che, piuttosto che lasciare questo carcere conservando nel mio cuore dell'amarezza contro il mondo, preferirei di mendicare con gioia il mio tozzo di pane di porta in porta. Se non ottengo nulla dal ricco, riceverò pur qualche cosa dal povero. Coloro che molto posseggono sono di solito avari; ma quelli che hanno ben poco lo dividono volentieri. Non mi farebbe nessun caso il dormire sulla fresca erba in estate e, al sopraggiungere dell'inverno, ripararmi al caldo in un mucchio di fieno o sotto la tettoia di una capanna, purchè avessi sempre dell'amore dentro il mio cuore. Le cose esterne della vita mi pare ora che non abbiano più alcun valore. Voi vedete, dunque, a quale intensità di individualismo io sono arrivato, o, piuttosto, io vado accostandomi, poichè il viaggio è ancor lungo e «sulla strada per la quale io cammino ci sono delle spine».
Certo, so bene che andare elemosinando per la via non sarà il fatto mio e che, se io mi stendessi la sera sull'erba fresca vi comporrei dei sonetti alla luna. Quando uscirò di prigione, R... mi aspetterà al di là dell'enorme portone ferrato ed egli è il simbolo non solo del suo proprio affetto, ma anche di quello di molti altri. Credo, ad ogni modo, che avrò da vivere per circa diciotto mesi e, se non potrò pel momento scrivere de' bei libri, almeno potrò leggerne; e quale felicità sarà più grande? In seguito spero d'essere capace di riacquistare le mie facoltà creatrici.
Ma se accadesse altrimenti, se non mi restasse più un amico al mondo, se nessuna casa mi fosse più aperta, neanche per pietà, se dovessi prendere la bisaccia e il tabarro logoro della miseria assoluta fino a quando io fossi libero da ogni risentimento, da ogni rancore, da ogni indignazione, potrei sempre affrontare la vita con molta più calma e fiducia che se il mio corpo fosse coperto di porpora e di lino prezioso e la mia anima scoppiasse di odio.
Nè avrò, veramente, nessuna difficoltà. Quando si desidera con fede l'amore, lo si trova là, che ci attende.
Inutile dire che il mio compito non termina qui. Se così fosse; sarebbe troppo facile. C'è ben altro davanti a me. Devo scalare delle montagne assai più irte; ho da attraversare delle valli infinitamente più cupe. E mi bisogna trarmi d'impaccio colle mie sole mani. Nè la religione, nè la morale, nè la ragione mi possono dare alcun giovamento.
No, la morale non mi aiuta. Io sono un antinomista nato. Sono di quelli che son fatti per le eccezioni e non per le regole. Ma mentre io vedo che non c'è niente di male in ciò che si compie, mi accorgo però che c'è qualcosa di cattivo in ciò che si diventa. È bene anche aver imparato questo.
La religione non mi aiuta. La fede che altri nutrono per ciò che è invisibile io la dedico a quel che si può toccare e osservare. I miei dèi abitano nei templi costruiti dalla mano dell'uomo ed è solo nell'ambito dell'esperienza reale che la mia fede si definisce e si completa; essa è troppo integra, forse, perchè, come molti di coloro o tutti coloro che hanno collocato il loro cielo sopra la terra, io vi ho scoperto non pure la bellezza del paradiso, ma anche dell'inferno. Quando penso alla religione, sento che mi piacerebbe fondare un ordine monastico per coloro che non possono credere: si dovrebbe chiamare la Congrega degli Infelici e nei suoi riti, davanti a un altare, privo di qualsiasi fiamma di ceri, un prete senza pace nel cuore, celebrerebbe l'officio con del pane profano o un calice vuoto. Ogni cosa, per essere vera, deve diventare una religione, e l'agnosticismo, come una qualunque altra religione, dovrebbe avere le sue cerimonie. Non ha esso seminato dei martiri? Ebbene, dovrebbe mietere i suoi santi e lodare ogni giorno il Signore d'essersi nascosto agli occhi degli uomini. Ma, sia la fede o l'agnosticismo, nè l'una nè l'altro mi devono rimanere due fatti esterni. Bisogna che i loro simboli siano una mia creazione stessa.
Spirituale è soltanto ciò che foggia la sua propria forma. Se non posso riuscire a trovarne il segreto nel mio intimo «io», non lo scoprirò giammai: se non lo reco con me, non mi si rivelerà mai più.
La ragione non mi aiuta. Essa mi dice che le leggi secondo le quali mi hanno condannato sono ingiuste e crudeli e che il sistema sociale per cui ho sofferto è ingiusto e malvagio. Ma, tuttavia, occorre ch'io le creda giuste e rette. E, precisamente come nel campo dell'arte non ci si occupa se non del valore che un fatto particolare ha di per se stesso in un particolare momento, così succede nell'evoluzione etica del carattere.
Occorre ch'io ritenga come un bene per me tutto ciò che mi è accaduto. Il letto di tavole, il cibo nauseabondo, le due funi che si devono sfilacciare in istoppa sino a che le dita indolenzite divengono insensibili, le vili «corvées» con le quali cominciano e finiscono le giornate, gli aspri comandi che sembrano una necessità dell'ordine, l'orribile casacca che rende persino grottesco il dolore, il silenzio, la solitudine, la vergogna – tutto questo bisogna ch'io lo trasformi in esperienza spirituale. Non c'è neppure una degradazione del corpo che non contribuisca a spiritualizzare l'anima.
Voglio arrivare ad un punto tale che mi sia possibile dire semplicemente e senza ostentazione di sorta che le due grandi date della mia vita corrispondono ai giorni in cui mio padre mi mandò ad Oxford e in cui entrai in galera. Io non dirò che la prigione sia la miglior cosa che mi sia capitata, perchè questa frase avrebbe un sapore di eccessiva amarezza verso di me. Preferirei dire o sentir dire di me stesso ch'io sono stato una natura così tipica del mio tempo che, nella mia perversità e per l'amore di questa perversità, ho mutato le buone cose della mia vita in male e le cattive in bene.
Tuttavia, ciò che gli altri dicono o che io dico interessa poco. La cosa importante che mi si offre e che devo fare – se il breve periodo dei miei giorni a venire non sarà sciupato, nè perduto, nè troncato – consiste nell'assorbire in me tutto ciò che mi è stato fatto e d'incorporarmelo e di accettarlo senza rimpianto, senza paura, senza ripugnanza. Il male supremo è la superficialità. Tutto ciò di cui ci si rende conto è bene.
Nei primi tempi della mia prigionia, alcuni mi consigliarono di dimenticare chi io ero. Disastroso consiglio! Invece, soltanto rendendomi ragione di quel che sono ho potuto trovare un po' di conforto. Adesso, altri mi esortano a dimenticare, quando sarò libero, d'essere mai stato in carcere. So bene che sarà fatale ugualmente. Ciò significa che io sarei senza tregua torturato da un sentimento intollerabile di sventura e che tutte le cose create per me come per gli altri: la bellezza del sole e della luna, il corteo delle stagioni, la musica dell'aurora e il silenzio della notte fonda, la pioggia che scroscia tra le foglie o la rugiada che inargenta i prati, tutte queste meraviglie diventerebbero opache per me, perderebbero il loro potere di guarire e di comunicare la gioia. Rammaricarsi delle esperienze fatte, vuol dire arrestare il proprio sviluppo; negarle equivale a mettere una menzogna sulle labbra della nostra vita. Sarebbe come rinnegare l'anima.
Perchè, come il corpo assorbe sostanze di ogni sorta, cose volgari ed impure, ed anche quelle che un sacerdote o una visione hanno purificato, e le converte in forza e in agilità, in gioco armonico di muscoli, in carni delicate, in capelli ricciuti e multicolori, in labbra, in occhi ridenti, così l'anima a sua volta ha le proprie funzioni nutritive e può trasformare in nobiltà di pensieri e in passioni di gran valore ciò che per sè stesso è vile, crudele e degradante; e a maggior ragione essa può trovarvi i suoi più efficaci mezzi di affermazione e rivelarsi più perfettamente mediante ciò che era destinato alla profanazione e alla distruzione.
Mi occorre sottomettermi francamente al fatto d'essere stato il carcerato ordinario di una ordinaria prigione e, quantunque ciò sembri curioso, bisognerà ch'io impari a non provarne vergogna. È necessario accettare la cosa come un castigo, e, se uno è vergognoso della pena sofferta, tanto valeva non averla mai nemmeno patita.
Certamente, ci sono molte colpe di cui mi hanno accusato e che io non ho mai commesso; ma ce n'è gran numero che mi hanno rimproverato e che in realtà ho compiuto e un numero più grande ancora di quelle che ho commesso e delle quali non sono mai stato accusato. E poichè gli dei sono strani e ci puniscono tanto per ciò che è umano e buono in noi quanto per ciò che è cattivo e perverso, io devo sottomettermi alla legge che fa pagare il fio sì per il bene che per il male compiuto.
Non ho nessun dubbio sulla perfetta giustizia di ciò. Questo giova o dovrebbe giovare a comprendere due cose e a non provare nessuna vanità nè per l'una nè per l'altra. Se, dunque, io non ho alcuna vergogna del mio castigo (come spero), sarò capace di pensare, di camminare e di vivere libero.
Non pochi uomini, dopo la loro liberazione, portano con sè la prigione nell'aria che li circonda, e, alla fine, come delle povere creature avvelenate, si cacciano in qualche buco per morirvi. È ben triste ch'essi siano ridotti a questo e la società che ve li costringe è ingiusta, tremendamente ingiusta. La società s'arroga il diritto d'infliggere all'individuo dei castighi spaventevoli, ma essa ha anche il difetto supremo d'essere superficiale e di non giungere a comprendere ciò che fa.
Quando il castigo è subìto, la società abbandona l'uomo a se stesso, vale a dire proprio nel momento nel quale dovrebbe cominciare il suo più alto dovere verso di lui. Essa ha paura delle azioni e rifugge da coloro che ha punito come si evita un creditore del quale non ci si può liberare, o l'uomo a cui si è imposta una irreparabile sorte. Da parte mia io esigo che, se mi rendo ragione di quanto ho sofferto, la società deve capire ciò che mi ha inflitto, e, per conseguenza, non c'è amarezza nè odio da una parte nè dall'altra.
Oh, lo riconosco che, da un certo angolo visuale, le cose saranno per me molto diverse da quel che sono per gli altri; ed è necessario, per la natura stessa del mio caso, ch'esse siano così. I poveri ladri e gli ammoniti, incarcerati qui con me, sono, sotto molti rispetti, assai più felici ch'io non sia. Il cantuccio di città oscura o di campo verdeggiante che assistette alla loro colpa è piccolo. Per trovare gente che ignori il loro delitto essi non hanno da superare una distanza maggiore di quella che un uccello percorre dal crepuscolo all'alba. Ma, per me, il mondo è ridotto ad un palmo e, da qualsiasi lato io mi volga, il mio nome è vergato con lettere di piombo sulla roccia. Poichè io non sono entrato dall'oscurità nella sfera di luce effimera del delitto, ma bensì da una specie di eternità di gloria in una specie di eternità d'infamia, e mi sembra talvolta d'aver dimostrato – se pure occorre questa prova – che tra l'uomo famoso e l'infame non c'è che un passo e forse anche meno d'un passo.
Pertanto, nel fatto che gli uomini mi riconosceranno dovunque io vada e che conosceranno la mia vita, almeno nelle sue ore di follia, io vedo un bene per me; ciò mi costringerà ad affermarmi nuovamente come artista e al più presto possibile. Se riuscirò a creare una sola e bella opera d'arte, mi sarà possibile di trovare un antidoto al veleno della malizia, di smontare i sarcasmi dei vili e di sradicare la lingua del disprezzo.
Se la vita, com'essa è sicuramente, deve anche per me essere un problema, io non sono un quesito di minor valore per la vita stessa. Gli uomini dovranno assumere qualche attitudine a mio riguardo, attraverso un giudizio su di sè medesimi e su di me. Non faccio nessuna allusione personale. I soli con i quali mi piacerebbe di trovarmi in compagnia, ora, sono gli artisti e coloro che hanno sofferto: coloro che sanno cos'è la bellezza e che sanno cos'è il dolore; tranne costoro, nessun altro m'interessa. E non domando più niente alla vita. In tutto ciò che ho affermato fin qui, io non mi preoccupo che della mia attitudine mentale verso la vita considerata nel suo insieme. Presento che uno dei primi punti che devo toccare per la mia propria perfezione e perchè io sono così imperfetto, si è di non vergognarmi d'essere stato punito.
In seguito bisognerà imparare ad essere felice. Un tempo conoscevo la felicità per istinto o almeno, credevo di conoscerla. C'era sempre la primavera, nel mio cuore, una volta! Mi occorreva la gioia ed ero nato per essa. Sino all'estremo limite io riempivo la mia vita di piacere, come si colma sino all'orlo una coppa di vino. Adesso è da un punto di partenza del tutto nuovo che mi accosto alla vita, ed anche il concepire la felicità mi riesce, spesso, difficile. Mi ricordo, durante il mio primo semestre a Oxford, di aver letto nel Rinascimento di Walter Pater – un libro che ebbe sulla mia vita una così strana influenza! – che Dante pone nel profondo Inferno coloro che vivono spontaneamente nella tristezza. Andai subito in biblioteca e cercai quel passo della Divina Commedia, là dove è detto che al disotto della sinistra palude giacciono quelli che furono «tristi nella dolcezza dell'aria» ripetendo
Tristi fummo
Nell'aer dolce che dal sol s'allegra.
Sapevo che la chiesa condannava l'accidia, ma questa idea mi parve assolutamente fantastica, come un genere di peccato inventato da un sacerdote ignorante della vita reale. Non potevo neppure capire come Dante, il quale dice che «il dolore ci unisce a Dio», fosse così aspro verso gli innamorati della melanconia, dato che davvero ne esistessero. Non sospettavo allora che questa diverrebbe un giorno una delle più grande tentazioni della mia vita.
Durante la mia permanenza nel carcere di Wandsworth, io ero malato d'un languore di morte. Era il mio unico desiderio morire.
Poi, quando fui trasferito qui, dopo due mesi d'infermeria, e m'accorsi che la mia salute andava migliorando a poco a poco, fui preso dall'ira. Decisi di suicidarmi il giorno stesso in cui sarei uscito di prigione. Dopo qualche tempo, questo furioso accesso si calmò e stabilii, invece, di vivere, ma di fasciarmi tutto di tristezza come un re si panneggia nella sua porpora, di mutare in un luogo di pianto ogni casa della quale avessi varcato la soglia, di imporre a' miei amici la sottile tortura della mia ipocondria, d'insegnar loro che la tristezza è il vero segreto della vita, di tormentarli con un dolore che fosse loro estraneo, di soffocarli con la mia pena. Ora ho i sentimenti molto diversi. Capisco che sarebbe una ingratitudine ed una crudeltà da parte mia atteggiarmi in modo che, quando i miei amici m'incontrassero, fossero costretti a mostrarsi ancora più melanconici di me per testimoniarmi la loro simpatia; oppure – per riceverli e offrir loro un degno trattamento – invitarli a sedersi silenziosamente davanti a delle erbe amare o a dei cibi funerari. No; bisogna ch'io impari ad essere gaio e felice.
Le due ultime volte che io ebbi il permesso di vedere qui i miei amici, provai d'essere allegro per quanto possibile e di mostrare la mia gaiezza per compensarli, un poco, del disturbo che essi s'erano presi, venendo sin qua dalla capitale. Non fu che un compenso molto, molto lieve, lo so, ma son certo che a loro piacque. Son passati otto giorni sabato da che ho visto R... per un'ora e mi sforzavo di mostrare nel modo più espressivo possibile la gioia che provavo in quell'incontro.
Il fatto che ora, per la prima volta in tutta la mia prigionia, io sento un reale desiderio di vivere, mi prova che ho ragione nelle idee e nelle opinioni che formulo qui per me stesso.
Tanto lavoro ho davanti a me che mi parrebbe una terribile tragedia il morire prima di averne potuto compiere almeno una parte! Scorgo nell'arte e nella vita degli sviluppi imprevisti di cui ciascuno è un nuovo mezzo di perfezione.
Bramo di vivere per esplorare questo mondo nuovo per me. Volete dunque sapere in che consiste questo nuovo mondo? Credo che lo possiate anche indovinare. È il mondo nel quale ho vissuto. Il dolore, infine, e tutto ciò che il dolore insegna: ecco il mio nuovo mondo.
Vivevo, un tempo, esclusivamente per il piacere. Allontanavo da me i patimenti e il dolore in ogni loro aspetto; li odiavo; avevo risoluto d'ignorarli sino a quando mi fosse stato possibile – vale a dire di considerarli come delle forme d'imperfezione. Sofferenza e dolore non sarebbero entrati nell'orbita della mia vita. Non avevano nemmeno un posto nella mia filosofia. Mia madre, che conosceva la vita intera, mi citava spesso i versi di Goethe scritti da Carlyle sur una pagina d'un libro ch'egli le aveva donato una volta e tradotti così da lui stesso:
Colui che non ha mai mangiato il
suo pane nel dolore,
Che non ha mai passate le ore della
notte ad attendere piangendo il mattino
che tarda,
Colui non vi conosce, o potenze del
Cielo! –
Erano i versi che quella nobile regina di Prussia – trattata da Napoleone con tanta grossolana brutalità – recitava nella sua umiliazione e nel suo esilio; erano i versi che mia madre mi ripeteva spesso nel tormento della sua vita, prossima a spegnersi. Io rifiutai, allora, assolutamente, di riconoscere o d'ammettere l'enorme verità che essi contenevano. Mi rammento molto bene ch'io le ripetevo di non aver nessun desiderio di mangiare il mio pane nel dolore e di trascorrere le notti aspettando in pianto un'alba d'amarezza.
Non avevo nessuna idea che proprio là eravi nascosta una delle singolari sorprese tenute in serbo dal destino per me e che, veramente, non altro io farei se non mangiare il mio pane nel dolore per un anno intero. Ma è così che anch'io ho avuto la mia parte; e che, durante questi ultimi mesi, ho potuto comprendere, mercè ostacoli e lotte senza pari, qualcuno degli insegnamenti che si celano nell'intimo del dolore. Preti e gente che adoperano frasi senza misura parlano, alle volte, della sofferenza come d'un mistero. Invece essa è una rivelazione. Fa distinguere delle cose che non si erano mai vedute prima e permette di considerare l'insieme della storia da un punto di vista tutt'affatto diverso. Quel che intorno all'arte, ad esempio, si era sentito in modo vago e per istinto, ora lo si afferra intellettualmente ed emozionalmente con una chiarezza perfetta di visione e con una intensità assoluta, comprensiva.
Oramai io sono persuaso che, poichè il dolore è la suprema emozione di cui è suscettibile l'uomo, esso è ad un tempo il tipo e il modello di ogni grande arte. Ciò che l'arte ricerca continuamente è quella certa maniera d'essere nella quale anima e corpo divengono uni e indivisibili; nella quale l'esteriore è l'espressione dell'intimità, in cui la forma stessa è una rivelazione. Tali maniere d'essere non sono numerose; in un dato momento ci possono servire di modello la giovinezza e l'arte che si preoccupa della giovinezza; in un altro noi possiamo credere invece che, per la sua finezza e sensibilità d'espressione, per l'idea che suggerisce d'uno spirito diffuso negli oggetti esterni e che si riveste a volta a volta d'aria e di terra, di nebbia e di volumi e per la morbidezza de' suoi atteggiamenti, de' suoi toni, de' suoi colori – l'arte del paesaggio moderno realizza per noi pittoricamente ciò che i Greci ottennero con tanta perfezione plastica. La musica, nella quale ogni soggetto è assorbito dall'espressione e non può separarsene, è un esempio complesso di quel che io voglio dire, così come un fiore o un fanciullo sono degli esempi semplici; ma il dolore è il tipo più alto nella vita e nell'arte.
Dietro la gioia e il sorriso ci può essere un temperamento ruvido, aspro e scaltro. Ma dietro il dolore non c'è che il dolore. L'angoscia, contrariamente al piacere, non si maschera mai. La verità, in arte, non consiste in una corrispondenza tra l'idea madre e l'esistenza accidentale; essa non è la identità della forma con l'ombra o della forma riflessa dal cristallo con la forma stessa; non è l'eco rinviata dall'anfratto d'una collina – così come non è, nella valle, una sorgente d'acqua argentata che mostra la luna alla luna e Narciso a Narciso. La verità in arte è l'unità d'una cosa con sè stessa, è l'esteriore come diretta emanazione dell'interiore; è l'anima connaturata con la carne e il corpo con lo spirito. Per questa ragione non esiste nessuna verità che sia comparabile al dolore. Ci sono alcuni momenti in cui il dolore sembra divenire la Verità Unica. Le altre cose possono essere delle illusioni dell'occhio o del desiderio, create per accecare l'uno e soddisfare l'altro, ma è solo col dolore che si sono creati i mondi e alla nascita di un fanciullo o di una stella presiede il dolore.
Ma – di più: v'è nel dolore una realtà intensa, straordinaria. Ho detto di me stesso ch'ero in comunione simbolica coll'arte e colla cultura della mia età. Ebbene: non c'è un solo infelice, chiuso con me in questa galera miserabile, che non si trovi in comunione simbolica col segreto stesso della vita. Perchè il segreto della vita è di soffrire. È questo che si nasconde in tutte le cose. Quando cominciamo a vivere, quel che è dolce a noi sembra tanto dolce e quel che è amaro ci sembra tanto amaro che noi rivolgiamo inevitabilmente tutti i nostri sforzi verso il piacere e non cerchiamo soltanto di «nutrirci di miele per un mese o due», ma non vogliamo altro alimento, in tutta la nostra vita, ignorando così che corriamo rischio d'affamare la nostra anima.
Mi sovviene d'essere entrato una volta in questo argomento con una delle più belle figure che abbia mai conosciuto, una donna di cui è indicibile la simpatia, la nobile bontà verso di me, prima e dopo la tragedia della mia prigionia; essa mi ha realmente aiutato, quantunque ella lo ignori, a portare il fardello delle mie pene più di qualsiasi altra creatura al mondo; e tutto ciò con il solo fatto della sua esistenza, perchè essa è quello che è: un ideale e una forza influente ad un tempo, una suggestione di ciò che si potrebbe divenire quanto un aiuto effettivo per divenirlo, un'anima che comunica la sua dolcezza all'aria che si respira e fa sembrare il mondo dello spirito semplice e naturale come la limpidità del sole e del mare; per lei la bellezza e il dolore camminano dandosi la mano e recano la stessa novella. Nell'occasione di cui parlavo mi ricordo d'averle detto che c'era in una sola strada-budello di Londra abbastanza sofferenza per mostrare che Dio non ama l'uomo e che, in qualunque luogo il dolore si rivelasse, (fosse pure quello d'un fanciullo piangente in un piccolo giardino per una colpa non commessa) la faccia intera della creazione ne era completamente sfigurata.
Ebbene, avevo del tutto torto. Ella me lo disse, ma io non le credetti. Non ero nell'ordine d'idee nel quale si arriva a una simile scoperta. Adesso constato che l'amore è la sola spiegazione possibile della somma straordinaria di dolore che esiste nel mondo. Non posso concepire nessun'altra spiegazione. Sono convinto che non ce n'è una diversa, e se veramente il mondo è stato costruito col dolore, le mani che lo hanno edificato son quelle dell'amore, perchè l'anima dell'uomo, per cui il mondo fu creato, non poteva altrimenti raggiungere il limite della sua perfezione. Il piacere per un bel corpo, ma il dolore per una bella anima.
Ma quando dico che sono convinto di queste cose, io parlo con troppo orgoglio. Di lontano, simile a una perla perfetta, si scorge la città di Dio. La vista ne è così meravigliosa che sembra che un fanciullo possa raggiungerla in un giorno d'estate. Ma per me e per coloro che sono simili a me, è differente. Si può, sì, assimilarsi una cosa in un solo istante; ma poi la si perde nelle lunghe ore che seguono interminabili, con piedi di piombo. È troppo difficile rimanere sulle «cime su cui l'anima sa d'innalzarsi». Noi pensiamo sotto la specie dell'eterno, ma pure noi procediamo lentamente col tempo e il tempo come lentamente cammina, per noi che siamo in prigione! Non occorre ch'io ne parli ancora e nemmeno della stanchezza e dello scoraggiamento che s'insinuano dentro le celle o nella cella del nostro cuore con una così strana insistenza che bisogna (per così dire) lustrare e adornare la casa, affinchè essi entrino come ospiti volgari o padroni crudeli dei quali si è, per caso o per elezione, lo schiavo.
Benchè ora i miei amici non lo credano, è pur vero che per essi (che vivono liberi, nell'ozio e nelle comodità) è più facile imparare lezioni d'umiltà che per me, per me che comincio la mia giornata mettendomi in ginocchio a lavare il pavimento della mia cella. Perchè la vita della prigione, colle sue privazioni e i suoi sacrifici innumerevoli, spinge alla rivolta. E il più terribile non è già che essa spezzi il cuore – i cuori non sono fatti per essere infranti? – ma che lo trasformi in una pietra. Tali volte, si sente che solo con una fronte di bronzo e delle labbra sprezzanti si può arrivare alla fine della giornata. Ma colui che si trova in istato di ribellione non può ricevere il dono della grazia, (per usare la frase che la Chiesa ama, con tanta ragione, oserei dire), perchè, nella vita come nell'arte, lo stato di rivolta preclude le vie dell'anima e non lascia passare i soffi del cielo. Tuttavia, se pur devo impararle in qualche luogo, è qui che mi eserciterò nelle lezioni d'umiltà e devo essere pieno di gioia, se i miei piedi sono sulla buona via e il mio volto guarda verso la «porta che è chiamata bella», sebbene io debba cadere ancora tante volte nel fango e spesso disorientarmi in mezzo alla bruma.
Questa Vita Nuova, come la chiamo sovente pel mio amore di Dante, non è a rigore una vita nuova, ma semplicemente, la continuazione, per via di sviluppi e di evoluzioni, della mia prima vita. Quando ero ad Oxford, l'ultimo anno, una mattina in cui passeggiavamo per gli stretti viali gorgheggianti del Magdalen College, mi ricordo d'aver detto a un amico che io volevo gustare tutti i frutti del giardino del mondo e che stavo per metter piede nella vita con questo desiderio chiuso nel profonda della mia anima. È così, infatti, che vi entrai e così che io vissi.
Il mio solo errore fu di limitarmi esclusivamente agli alberi di quel che mi parve il lato luminoso del giardino e di fuggire l'altra parte, impaurito com'ero delle zone d'ombra e della sua oscurità. La non riuscita nel mondo, la sventura, la povertà, il dolore, la disperazione, la sofferenza, le lagrime stesse e le parole monche che sfuggono alle labbra in pena, il rimorso che costringe a camminare sui rovi, la coscienza che condanna, il volontario umiliarsi che avvilisce, la miseria che ricopre i suoi capelli di cenere, l'angoscia che si lacera con un cilicio e mescola il fiele nel calice della sua bevanda – di tutte queste cose insieme io ero spaventato. E siccome ero risoluto a non esperimentarne mai nessuna, fui poi costretto a gustarle ad una ad una, a nutrirmene e ad abbeverarmene, a non avere altro nutrimento durante una intera stagione.
Neppure per un istante io ho rimorso d'aver vissuto per il piacere. Pienamente mi abbandonai ad esso, come è necessario fare tutto quel che si fa. Non c'è voluttà che io non conoscessi. In una coppa di vino gettai la perla della mia anima. Discesi al suono dei flauti pel sentiero fiorito delle primavere. Mi cibai di miele. Ma non sarebbe stato buon consiglio continuare la medesima vita, perchè ciò sarebbe equivalso ad una limitazione. Occorreva procedere oltre. Anche l'altra metà del giardino aveva dei segreti per me. Certo, tutto ciò è detto e preveduto nei miei libri. Una parte nel Principe Felice; un'altra, nel Giovine Re, specialmente nel passo nel quale il vescovo dice al fanciullo inginocchiato: «Colui che ha creato il dolore non è più saggio di te?» È una frase che, quando la scrissi, mi parve veramente più di una semplice frase. Una gran parte di verità è dissimulata sotto l'accento fatale che, simile a un filo di porpora, serpeggia attraverso la trama di Dorian Gray. Nel Critico considerato come artista il presagio si rivela in molte maniere, nell'Anima dell'Uomo è manifesto in chiare lettere, anche troppo facili a leggersi; e non è, esso mònito, uno dei ritornelli che ripetuti motivi rendono Salome simile a uno squarcio musicale e le dànno l'unità organica d'una ballata? Inoltre è incarnato nel poema in prosa dell'uomo che, col bronzo della statua del «Piacere effimero» deve foggiare l'immagine del «Dolore Eterno». Non poteva essere diversamente. In ciascun momento della vita si è quel che si sta per essere, oltre a ciò che si è già stati. L'arte è simbolica, perchè tutto un simbolo è l'uomo.
Se potrò conquistarla completamente, questa Vita Nuova, essa sarà la definitiva realizzazione della vita artistica; in quanto la vita artistica è semplicemente lo sviluppo di sè stesso. L'umiltà per l'artista consiste nell'accettare con cuore franco tutte le esperienze, come l'amore per l'artista è il puro senso della bellezza che rivela al mondo il suo corpo e la sua anima.
In Mario l'Epicureo, Walter Pater cerca nel senso profondo, solenne e dolce della parola, di riconciliare la vita artistica con quella della religione. Ma Mario, quasi, non è che uno spettatore – uno spettatore ideale cui è concesso di «contemplare lo spettacolo della vita con delle emozioni adeguate», ciò che Wordsworth definisce lo scopo vero del poeta; tuttavia è uno spettatore un po' troppo preoccupato della delicata grazia del santuario del dolore che ha pur sotto gli occhi.
Io vedo un vincolo molto più intimo ed immediato tra la vera vita di Cristo e la vera vita dell'artista e provo un grande piacere pensando che, assai tempo prima d'essere dominato e legato al carro del dolore, io avevo scritto, nell'Anima dell'Uomo, che colui il quale volesse condurre una vita simile a quella di Cristo dovrebbe essere interamente e assolutamente sè stesso e avevo preso come esempi non solo il pastore sulla montagna e il prigioniero nella sua cella, ma sì anche il pittore per cui il mondo è una festa di colori e il poeta pel quale l'universo intero è un canto. Mi rammento, una volta che si discuteva in un caffè di Parigi, d'aver detto ad Andrea Gide: la metafisica ha poco interesse reale per me e la morale nessuno; ma tutto ciò che è uscito dalla bocca di Platone o di Cristo può essere trasportato immediatamente nella sfera dell'arte e trovarvi la propria espressione integrale.
Non solo noi possiamo notare in Cristo quel vincolo intimo della personalità con la perfezione in cui consiste la vera differenza tra il movimento classico e il romantico nella vita; ma è un fatto che la sua stessa natura era identica a quella dell'artista – una immaginazione intensa come una fiamma. Egli ebbe nel campo dei rapporti umani quella tale simpatia immaginativa che, nel dominio dell'arte, forma il segreto unico della creazione. Comprese la lebbra del lebbroso, la tenebra del cieco, la crudele miseria di coloro che vivono non cercando altro che il piacere, la strana povertà del ricco. Qualcuno mi ha scritto, durante il periodo più acuto delle mie angoscie «Caduto dal vostro piedestallo, non siete più interessante». Oh, quanto egli era lontano, dicendo questo, dal «segreto di Gesù»! – per adoperare una espressione di Matteo Arnold. L'uno e l'altro gli avrebbero potuto insegnare che ciò che succede ad un uomo succede ugualmente a voi. Se volete una massima da leggere dall'alba alla notte, nelle ore di gioia e nelle ore di tristezza, incidete sulle pareti della vostra casa queste lettere (che saranno dorate dal sole, inargentate dalla luna): «Tutto quel che capita a me stesso, capiterà anche ad altri».
Senza dubbio, Cristo va collocato assieme con i poeti. La sua concezione dell'Umanità era una risultante diretta della sola immaginazione – che può comprenderla. Egli considerò l'uomo come il panteista aveva considerato Dio. Fu il primo a concepire l'unità delle razze divise. Avanti ch'Egli apparisse, c'erano stati degli dèi e degli uomini, e Cristo sentendo per mezzo della sua mistica simpatia che ciascuno di essi era incarnato in sè, si denomina, a seconda, o il figlio di Dio o il figlio dell'Uomo. Più di qualsiasi altro nella storia Egli desta in noi quella facoltà del meraviglioso cui si rivolge sempre l'elemento romanzesco. C'è ancora in me qualcosa d'incredibile nell'idea di questo giovine artigiano galilèo che s'immagina di poter portare sulle sue spalle il peso del mondo intero: tutto quel ch'era già stato compiuto e sofferto, i delitti di Nerone, di Cesare Borgia, di Alessandro VI e di colui che fu Imperatore di Roma e sacerdote del sole, le torture di coloro i cui nomi sono legioni e che riposano nei cimiteri, le nazioni oppresse, i fanciulli martiri delle officine, i ladri, i carcerati, i proscritti, coloro che sono diventati muti nel servaggio e de' quali solamente Dio comprende il silenzio; e tutto questo non era una semplice immaginazione, ma un fatto vero, compiuto, in modo che ora tutti quelli che cercano di penetrare nella sua personalità – quantunque non si curvino davanti a' suoi altari, nè s'inginocchino innanzi a' suoi preti – s'avvedono, in qualche modo, che la macchia del loro peccato è lavata ed hanno la rivelazione della bellezza del loro soffrire.
Dicevo che Cristo va messo assieme con i poeti. È vero. Shelley e Sofocle l'accompagnano. Ma tutta la sua vita intera è il più meraviglioso dei poemi. Quanto a «pietà e terrore», non c'è niente di simile nel ciclo complessivo della tragedia ellènica. La purità del protagonista innalza tutto il piano della sua vita ad un'altezza d'arte romantica donde – a causa dell'orrore – sono eliminate le tribolazioni di Tebe e della schiatta dei Pelòpidi; ed essa mostra ancora quanto avesse torto Aristotile ad affermare, nel suo trattato sul dramma, che riuscirebbe impossibile sopportare lo spettacolo d'un personaggio irreprensibile nel dolore. Nè in Eschilo nè in Dante, questi genî austeri della più accorata poesia, nè in Shakespeare, il più umano di tutti i grandi artisti, e nemmeno nell'insieme dei miti e delle leggende celtiche (ne' quali la bellezza del mondo s'intravvede sotto un velo di lacrime e in cui la vita d'un uomo non è da più della vita di un fiore) si può trovare qualcosa che, per la semplice emozione unita alla sublimità dell'effetto tragico, stia alla pari o soltanto s'approssimi all'ultimo atto della passione di Cristo.
La cena con i suoi discepoli, da uno dei quali è già stato venduto per una somma di danaro; l'angosciosa agonia nell'orto tranquillo illuminato dalla luna; il falso amico che gli si avvicina per tradirlo con un bacio; l'amico – che credeva ancora in Lui e sul quale Egli, come su una roccia granitica, aveva sperato di poter costruire un rifugio per l'Uomo – che lo rinnega, invece, nell'ora in cui il gallo saluta l'aurora; il suo isolamento assoluto, la sua sottomissione, la sua rassegnazione; inoltre: le scene nelle quali il gran sacerdote dell'ortodossia gli lacera con furia le vesti, e il magistrato civile dell'impero chiede dell'acqua, sperando invano di lavarsi quella macchia di sangue che dovrà contrassegnarlo come la rossa figura della storia; la cerimonia dolorosa della corona di spine – una delle cose più meravigliose nella cronaca dei tempi; la crocefissione dell'innocente sotto gli occhi di sua madre e del discepolo che l'amava, i soldati che si giocano a dadi gli abiti del martire; la morte terribile con la quale egli ha dato al mondo il suo più eterno simbolo; e poi la sepoltura finale nella tomba dell'uomo ricco; il suo corpo fasciato di bende egiziane e profumato di aromi costosi, come se fosse stato il figlio di un re... Quando si considera tutto ciò unicamente dal punto di vista dell'arte, bisogna pure essere riconoscenti alla Chiesa del fatto che il supremo rito della Chiesa stessa consista nella rappresentazione della tragedia senza spargimento di sangue: mistica rappresentazione della Passione del Signore per mezzo di dialoghi, di costumi e di gesti. Ed è per me una ragione di piacere e di rispetto commosso il pensare che il coro greco, altrimenti perduto per l'arte, sia sopravvissuto infine nel chierico che risponde al prete celebratore della messa.
E però la vita di Cristo – a tal punto dolore e bellezza si possono fondere nella loro manifestazione piena di significato – è realmente un idillio, quantunque essa termini col velario del tempo che si lacera, colle tenebre che si addensano sulla faccia della terra e colla pietra trascinata fino all'ingresso della sepoltura. Si pensa sempre a Cristo come ad un fidanzato in mezzo a' suoi compagni e, d'altronde, è proprio così ch'egli si compiace di chiamarsi in alcuni luoghi; come ad un pastore che trascorra di valle in valle col suo gregge alla ricerca di verdi prati e di ruscelli d'argento; come a un cantore che provi colla sua musica di costruire le mura della città di Dio; o come a un amante le cui capacità d'amore sono troppo vaste per il nostro piccolo mondo. I suoi miracoli mi sembrano squisiti come il primo soffio della primavera ed altrettanto naturali. Non ho alcuna difficoltà a credere che il fascino della sua persona doveva essere tale da poter dare la pace alle anime tormentate con la sua sola presenza e che coloro i quali gli toccavano la tunica e le mani dimenticavano le proprie sofferenze; e che, quando egli passava sulla grande via della vita, uomini che non avevano mai visto nulla nel mistero di vivere, ad un tratto si sentivano aprire gli occhi ed altri, rimasti sempre sordi a tutte le voci, tranne che a quella della voluttà, udivano per la prima volta la voce dell'amore e la trovavano «così musicale come la lira d'Apollo»; nè ho difficoltà a credere che le malvagie passioni s'involavano al suo avvicinarsi e gli uomini, le esistenze dei quali erano sempre state meschine, simili alla morte, balzavano fuori della tomba – per così dire – appena egli li chiamava; oppure, quando egli predicava sulla montagna, la moltitudine obliava la fame, la sete e le cure del mondo; e quando egli conversava con gli amici e i discepoli durante la cena, il cibo grossolano sembrava delicato e l'acqua assumeva il gusto del vino e tutta la casa s'empiva del profumo dolce del nardo.
Nella Vita di Gesù – questo delizioso quinto evangelo, l'evangelo secondo San Tommaso, si potrebbe chiamarlo – Renan dice in qualche passo che il grande segreto di Cristo fu quello di farsi amare dopo la morte quanto era stato amato in vita.
Certamente, se il suo posto è tra i poeti, egli è il principe degli amanti. Egli vide che l'amore è il principio primordiale del mondo, il segreto che cercavano i saggi – ed è soltanto per mezzo dell'amore che ci si può accostare al lebbroso e al signore.
Ma, oltre a tutto ciò, Cristo è il supremo individualista. L'umiltà, in quanto accettazione artistica di ogni esperienza, è un semplice modo di manifestarsi. È l'anima dell'uomo che Cristo cerca di raggiungere senza tregua. Egli la chiama «regno di Dio» e la trova in ciascuno di noi. La còmpara a delle piccole cose, a una sottile semenza, a un pugno di lievito, ad una perla. E non si afferra la realtà della propria anima se non liberandosi di tutte le passioni estranee, di ogni coltura sovrapposta, di ogni possesso acquisito – sia esso buono o cattivo.
Io mi ostinai contro tutto, con tenacia e con ribellione, sino a che non restasse in me più che una sola cosa al mondo. Avevo perduto il mio nome, la mia posizione, la mia felicità, la mia libertà, la mia ricchezza. Ero povero e prigioniero. Ma mi rimanevano ancora i miei figli. Ad un tratto anch'essi mi furono tolti. Fu un colpo così tremendo che non seppi più cosa fare; mi gettai in ginocchio, curvai la testa e piansi, esclamando: «Il corpo del Signore è come quello d'un fanciullo; io non sono più degno nè dell'uno nè dell'altro». Ed ecco: in questo istante mi parve di salvarmi. Vidi allora che la sola cosa per me era di accettare tutto. Da quel momento in poi – per quanto ciò paia curioso – io fui più felice. Si è che io avevo toccato la mia anima nella sua essenza suprema. In molte maniere me l'ero inimicata, ma essa mi attendeva ancora come un amico. Quando si entra in comunione coll'anima, si diventa puri come fanciulli – Cristo l'ha detto.
È veramente tragico che così poche persone riescano a «possedere la loro anima» prima di morire. «Nulla è più raro in un uomo – dice Emerson – di un'azione che sia proprio sua». È assolutamente vero. La maggior parte degli esseri sono degli altri esseri. I loro pensieri sono l'opinione di qualcun altro, le loro esistenze una parodia, le loro passioni un'eco di riflesso. Cristo non fu soltanto il supremo individualista, ma anche il primo degli individualisti della storia. Si è tentato di considerarlo come uno dei tanti filantropi e l'hanno pure accomunato agli altruisti, come un'ignorante e un sentimentale.
Ma non fu, realmente, nè una cosa, nè l'altra. Certo, egli ha il senso della pietà per i poveri, per coloro che sono relegati nelle prigioni, per gli umili, per i miserabili, ma egli ha molta più compassione per i ricchi, per gli edonisti, per coloro che sacrificano la loro libertà e divengono gli schiavi delle cose, per quelli che portano abiti preziosi e abitano in palazzi regali.
Le ricchezze e le voluttà a lui sembrano invero delle tragedie più grandi che la penuria e il dolore. Quanto all'altruismo, poi, chi sapeva meglio di lui che non è la volontà, ma bensì la vocazione quella che ci spinge a compiere il bene e che non si potrebbero cogliere dei grappoli su dei roveti, nè dei fichi sui cardi?
Vivere per gli altri, come scopo cosciente e definito, non era già la sua fede. Non era la base della sua fede. Quando egli dice: «perdonate ai vostri nemici», non afferma questo per amor del nemico, ma per amor di sè stesso, perchè l'amore è più bello dell'odio. Consigliando al giovane ricco: «va e vendi tutto che possiedi e dònalo ai poveri» non è ai poveri che Cristo pensa, ma all'anima del giovane, l'anima che era rovinata dalla ricchezza. Nella visione della vita egli è d'accordo con l'artista il quale sa che, per l'inevitabile legge del perfetto sviluppo di sè stesso il poeta deve cantare, lo scultore pensare nel bronzo e il pittore fare del mondo lo specchio delle proprie emozioni; appunto come il biancospino deve sbocciare in primavera, il grano tingersi d'oro nel giugno e la luna, ne' suoi puntuali viaggi, deve cambiarsi di scudo in falce e di falce in iscudo.
Ma, mentre Cristo non ha mai detto agli uomini: «Vivete per gli altri» egli ha mostrato, però, che non c'è nessuna differenza tra la nostra e l'altrui vita. Con questo mezzo egli ha dato all'uomo una personalità estesissima e titanica. Dopo la sua apparizione, la storia di ogni individuo particolare si è trasformata o può trasformarsi nella storia stessa del mondo. Senza dubbio, anche la cultura ha intensificato la personalità dell'uomo. L'arte ci ha dato degli spiriti innumerevoli come miriadi. Coloro che hanno temperamento artistico seguono Dante nell'esilio e imparano «come sa di sale – lo pane altrui e com'è duro calle – lo scender e il salir per l'altrui scale»; essi acquistano per un momento la serenità e la calma di Goethe e tuttavia non ignorano quel che Baudelaire ha gridato a Dio:
O Signore, dammi la forza e il coraggio di contemplare il mio corpo e il mio cuore senza vergogna.
Con loro proprio svantaggio, forse, traggono dai sonetti di Shakespeare il segreto del suo amore e se ne impadroniscono; essi contemplano con occhi nuovi la vita moderna, perchè hanno ascoltato dei notturni di Chopin o perchè hanno maneggiato dei gioielli greci o hanno letto la storia della passione che un uomo ebbe un tempo lontano per una donna dalla capigliatura fine come l'oro e dalla bocca simile a una melagrana. Ma la simpatia del temperamento artistico si rivolge di necessità a ciò che ha trovato la sua propria espressione. Con delle parole o con dei colori, con la musica o col marmo, dietro la maschera dei personaggi d'Eschilo o con le fistule traforate d'un pastore siciliano, dovettero rivelarsi l'uomo e la sua intimità.
Per l'artista, l'espressione è il solo aspetto secondo il quale egli possa concepire la vita. Per lui ciò che è muto è morto. Ma per Cristo, invece, non era così. Con una immaginazione meravigliosa e vasta, che talvolta riempie di spavento, egli assunse per regno il mondo intero dell'immobilità, il mondo senza voce del dolore e ne divenne l'interprete. Scelse come suoi fratelli coloro che sono muti sotto il servaggio e «il silenzio dei quali non è inteso altro che da Dio». Egli volle divenire l'occhio dei ciechi, l'orecchio dei sordi e un grido sulle labbra di coloro che avevano la lingua recisa. Il suo desiderio era d'essere una tromba per le miriadi d'uomini che non avevano mai potuto esprimersi, una tromba con la quale egli lancerebbe il loro anelito verso il cielo. Con la natura artistica d'un essere pel quale sofferenza e dolore erano mezzi, attraverso cui giungere alla realtà della sua concezione del bello, egli sentì che un'idea non ha valore se non quando s'incarna, se non quando se ne forma un'immagine, e fece di sè stesso l'immagine dell'Uomo del Dolore; ed è appunto con questa figura che egli ha affascinato e dominato l'arte come nessuna divinità greca era riuscita a fare mai.
Poichè gli dei dell'Ellade, nonostante il bianco ed il roseo delle loro agili membra, non erano, in realtà, ciò che mostravano d'essere.
La fronte ben tornita d'Apollo era simile al disco del sole che sorge all'aurora dietro una collina e i suoi piedi erano come i soffi della brezza del mattino, ma egli era stato crudele contro Marsia e aveva rapito a Niobe i suoi figlioli; nell'egida d'acciaio degli occhi di Minerva non c'era mai stata pietà per Aracne; il fasto e i pavoni di Giunone erano tutto ciò che esisteva di veramente nobile in lei e il Padre degli Dei esso stesso mostrò troppa tenerezza per le figlie dei mortali. Le due figure più profondamente suggestive della mitologia greca furono, per la religione, Demetra, dea della Terra, che non era ammessa nell'Olimpo, e, per l'arte, Diònysos figlio di una donna effimera che morì nel darlo alla luce.
Eppure la vita stessa, nella sua più modesta e più umile sfera, produsse una meraviglia più ammirevole che la madre di Proserpina o il figlio di Semele. Dalla bottega del falegname di Nazareth sorse una personalità infinitamente più grande di tutte quelle create dalla leggenda e dal mito e destinata – cosa strana! – a rivelare al mondo il senso mistico del vino e delle reali bellezze del giglio nella valle, come nessuno aveva fatto ancora, nè sul Citerone, nè a Enna.
Il canto d'Isaia: «Egli è il disprezzato e l'ultimo degli uomini, un uomo di colore che conosce l'angoscia e noi gli abbiamo nascosta la nostra faccia» gli era parso una profezia e la profezia fu compiuta nella sua persona. Ogni opera d'arte che è creata è il compimento d'una profezia, perchè ciascuna opera d'arte è la conversione d'un'idea in una immagine. Così pure ogni creatura umana deve essere il compimento d'una profezia, perchè ciascuna creatura umana dovrebbe essere la realizzazione di qualche ideale, sia nello spirito di Dio che nello spirito dell'uomo. Cristo trovò il tipo e lo delineò; talchè il sogno di un poeta virgiliano, a Gerusalemme o a Babilonia, nel lungo cammino dei secoli, s'incarnò in colui che il mondo «attendeva».
Per me, una delle cose più dolorose della storia si è che la vera rinàscita di Cristo – che produsse la cattedrale di Chartres, il ciclo delle leggende d'Artù, la vita di San Francesco d'Assisi, l'arte di Giotto e la Divina Commedia di Dante – non abbia avuto la libertà di svilupparsi secondo le sue proprie linee interne, ma invece sia stata interrotta e violentata dalla fredda rinàscita classica che ci ha dato gli affreschi di Raffaello, l'architettura di Palladio, la tragedia francese convenzionale, la cattedrale di S. Paolo, la poesia di Pope e tutto ciò, insomma, che è creato dal di fuori, secondo regole morte, che non emana dall'intimo di un potente soffio inspiratore. Ma dovunque si verifica un movimento romantico in arte, là, in un modo o nell'altro, si trova Cristo o l'anima di Cristo. Egli è in Romeo e Giulietta, nel Racconto d'inverno, nella poesia provenzale, nella Ballata del Vecchio marinaio, nella Belle dame sans merci e nella Ballata della carità, di Chatterton.
Dobbiamo all'anima di Cristo le cose e i generi più diversi. I miserabili di Hugo, I fiori del male di Baudelaire, la nota pietosa dei romanzi russi, Verlaine e i suoi poemi; le vetrate, le tappezzerie e i lavori quattrocenteschi di Burne-Jones e di William Morris le appartengono non meno che il campanile di Giotto, Lancillotto e Ginevra, Thannhäuser e i marmi violenti di Michelangiolo, l'architettura gotica, l'amore per i fanciulli e l'amore per i fiori. A queste due ultime cose, veramente, l'arte classica non accorda che poco posto, appena quel tanto che basta per farli crescere e giuocare; eppure dal dodicesimo secolo ai nostri giorni essi non hanno mai cessato di comparire nell'arte in attitudini varie e in età diverse, a un tratto e capricciosamente sorgendo, appunto come i fanciulli ed i fiori: la primavera dà sempre l'idea che i fiori si siano nascosti e che ricompaiano al sole per la paura che gli uomini si stanchino di cercarli e vi rinuncino; e la vita d'un fanciullo non è altro che un giorno d'aprile con delle pioggie e delle zone di sole per i narcisi.
Ora è questo carattere immaginativo della natura di Cristo che lo rende il centro palpitante dello spirito romantico. Le strane figurazioni del poema drammatico e della ballata sono create dalla fantasia d'un altro, ma Gesù di Nazareth si è interamente creato per proprio conto. Il canto d'Isaïa, in vero, aveva da fare con la venuta di Cristo, tanto quanto il gorgheggio dell'usignuolo coll'alzarsi della luna – nulla di più e nulla di meno. Egli fu la negazione come pure l'affermazione della profezia. Per ogni speranza che realizzava, un'altra ne distruggeva. «In ogni bellezza – dice Bacone – c'è qualche stranezza di proporzione»; e di coloro che, come lui, sono delle forze dinàmiche – Cristo dice che sono come il vento che «soffia dove gli pare e nessuno può dire, nè donde venga, nè dove vada». Perciò il suo ascendente è così grande sugli artisti. Egli ha tutti i colori della vita: il mistero, la stranezza, il patetico, la suggestione, l'estasi e l'amore. Si rivolge allo spirito del miracolo e crea quel tale stato d'animo, solo nel quale può essere compreso.
E per me è una gioia, ora, il considerare che s'egli è «tutta immaginazione» il mondo stesso è di una identica sostanza. Ho detto, nel Dorian Gray, che i grandi delitti del mondo accadono nell'intimo del cervello. Ma non è pure nel cervello che tutto accade? Adesso sappiamo che noi non vediamo con gli occhi, nè udiamo con le orecchie. Essi non sono che dei canali per trasmettere con più o meno di esattezza le impressioni dei sensi. È dentro il cervello, che il papavero è rosso, e la mela odora e l'allodola canta.
Da qualche tempo io studio con cura i quattro poemi in prosa che riguardano la figura di Cristo. Per Natale sono riuscito a procurarmi un Testamento Greco ed ogni mattina, dopo aver spazzato la mia cella e forbito i miei utensili, leggo un passo dei Vangeli, una dozzina di versetti presi a caso, non importa dove. È una deliziosa maniera di cominciar la giornata. Ciascuno, anche vivendo una vita turbinosa e disordinata, dovrebbe fare così. Ripetizioni interminabili, ad ogni proposito e fuori scopo, ci hanno sciupato la freschezza, l'ingenuità, la grazia semplice e romantica dei Vangeli. Li sentiamo leggere e citare troppo spesso e troppo male, ed ogni insistenza di questo genere è anti-spirituale. Quando si torna al testo greco, pare di entrare in un'aiuola di gigli, uscendo da una casa angusta ed oscura.
Il piacere è raddoppiato per me dal pensiero che è assai probabile che noi adoperiamo le medesime frasi, ipsissima verba, usate da Cristo. Si ritenne per certo, a lungo, ch'egli si esprimesse in aràmico. Anche Renan lo credeva. Ma ora sappiano che gli abitanti della Galilea, come gli Irlandesi dei nostri giorni, erano bilingui e il greco era il linguaggio ordinario che serviva per le relazioni quotidiane da un capo all'altro della Palestina e, veramente, da un punto all'altro di tutto il mondo orientale. Ero spiacente di non poter conoscere le parole di Cristo, se non a traverso la traduzione di una traduzione. Sì, è per me una delizia pensare che, almeno per la semplice conversazione, Càrmide avrebbe potuto ascoltarlo e Socrate parlare con lui e Platone comprenderlo; ch'egli pronunciò esattamente: ἐγώ είμι ὄ ποιμἠν ὀ ϰαλὅς (io sono il buon pastore); che quando pensava ai gigli del campo, i quali non lavorano e non filano, egli s'espresse precisamente cosí: Κατα μὰϑετει τὰ ϰρίνα τοῦ πῶς αύξάνεί αγρού οῦ ϰοπιᾶ ούδὲ νηϑε e che la sua ultima parola, quando gridò: «Tutto è finito, la mia vita è terminata, ha toccato il vertice della sua perfezione», fu proprio quella che ci riporta San Giovanni: τετὲλεσται e nulla più.
Leggendo i Vangeli – specialmente il Quarto, quello di San Giovanni o del Gnostico, chiunque sia colui che assunse il suo nome e il suo abito – io vedo di continuo che l'immaginazione è messa innanzi come la base di ogni vita spirituale e materiale; e, inoltre, per Cristo l'immaginazione era una semplice forma dell'amore e l'amore era sovrano nel senso più esteso del termine. Circa sei settimane fa il medico mi accordò il permesso di mangiare del pane bianco invece del ruvido pane nero o bigio del regime ordinario. È una vera ghiottoneria. Parrà strano che del pane secco possa essere una ghiottoneria. Per me lo è a tal punto che, alla fine di ciascun pasto, io mangio accuratamente le briciole rimaste sul mio piatto di metallo o cadute sulla grossa salvietta che ci serve di tovaglia per non sporcare la tavola; e non lo faccio per fame – il vitto che mi dànno è sufficiente – ma solo per non perdere nulla di ciò che mi è dato. È in questo modo che bisogna considerare l'amore.
Cristo, come tutte le figure affascinanti, aveva il potere non soltanto di dire lui stesso delle cose belle, ma anche di farsi dire delle belle cose dagli altri. E a me piace la storia, che ci racconta San Marco, d'una donna greca la quale, dicendole Cristo (per mettere alla prova la sua fede) di non poterle dare il pane dei figli d'Israele, – replicò che i piccoli cani – Κυνάιρια – accucciati sotto la tavola, si nutrono delle briciole che i bimbi fanno cadere.
La maggior parte degli uomini vivono per l'amore e per l'ammirazione, ma invece è per mezzo dell'ammirazione e dell'amore che noi dovremmo vivere. Se alcuno ci mostra dell'amore, noi dovremmo riconoscere che ne siamo perfettamente indegni. Nessuno è degno d'essere amato. Il fatto che Dio ama l'uomo ci prova che, nell'ordine divino delle cose ideali, è stabilito che un eterno amore sarà dato a chi ne è eternamente indegno. Ovvero, se questa frase sembra troppo amara, diciamo che tutti gli uomini sono degni d'amore, tranne coloro che possono esserlo. L'amore è un sacramento che bisognerebbe accogliere in ginocchio e Domine, non sum dignus dovrebbe essere la frase di coloro che lo ricevono, sulle loro labbra e nel loro cuore.
Se io scriverò ancora nel senso di creare un'opera d'arte, due sono i soggetti, sopra tutto, sui quali e per mezzo dei quali voglio esprimermi; uno è «Cristo come precursore dell'atteggiamento romantico nella vita» l'altro: «La vita artistica considerata ne' suoi rapporti con la condotta umana». Il primo è, senza alcun dubbio, assai seducente, perchè io vedo in Cristo non solo il principio essenziale del supremo tipo romantico, ma anche tutte le contingenze e le stesse perversità del temperamento romantico. Egli fu il primo a dire agli uomini di vivere come i fiori e ha fissato sempre la frase. Cristo prese i fanciulli come tipo e modello per le aspirazioni umane. Li propose come esempio ai loro genitori – cosa che io ho sempre pensato, se è vero che si deve giovarsi di ciò che è perfetto.
Dante descrive l'anima dell'uomo come proveniente da Dio «che piangendo e ridendo pargoleggia» ed anche Cristo aveva veduto che l'anima di ciascuno di noi dovrebbe essere a guisa di fanciulla – che piangendo e ridendo pargoleggia. Sentì che la vita è mutevole, fluida, attiva e che permetterle di stereotiparsi in una forma qualsiasi, significa farla morire. Cristo disse che gli uomini non devono preoccuparsi eccessivamente dei loro interessi materiali e comuni; che solo il liberarsi dalle faccende pratiche è una cosa importante. Gli uccelli non si affannano per interesse di sorta. Perchè l'uomo, dunque, se ne cruccia? È delizioso, quando afferma: «Non curatevi del domani; l'anima non val più che la carne? E il corpo più della veste?» Un greco avrebbe potuto usare quest'ultima frase. Essa è piena di sentimento greco. Ma solo Cristo poteva enumerarle tutte e due e riassumere così perfettamente la vita.
La sua morale è tutta di simpatia, appunto come dev'essere la morale. Se non avesse mai detto altro che queste parole: «I suoi peccati le sono perdonati, perchè ha molto amato», metterebbe il conto di morire per averle dette. La sua giustizia è una giustizia tutta poetica, appunto come la giustizia dev'essere. Il malfattore andrà in paradiso, perchè è stato infelice; io non trovo una ragione migliore per mandarvelo. Gli artigiani che non hanno lavorato che un'ora sola nella vigna e durante la fresca brezza della sera, riscuotono lo stesso salario di coloro che hanno sudato tutto il giorno in mezzo ai tralci, sotto la sferza del sole. Probabilmente, nessuno meritava di essere pagato. O, forse, gli artigiani erano differenti? Cristo non aveva nessun trasporto per i sistemi meccanici, privi d'anima, che trattano gli uomini come se fossero degli oggetti e trattano tutto il mondo alla stessa stregua: per lui non esistevano leggi; c'erano semplicemente delle eccezioni; come se ogni uomo od ogni cosa non trovassero alcun simile.
Ciò che forma il tono stesso dell'arte romantica era per Cristo il vero fondamento della vita naturale. Non ne scorgeva altro. E quando gli fu condotta innanzi una donna sorpresa in flagrante adulterio e gli fu indicata la sentenza della legge e gli venne chiesto ciò che occorreva fare, egli continuò a scrivere col suo dito sulla sabbia come se non avesse udito, e quando lo si esortò a rispondere, alzò la testa e disse: «Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra». Mette conto di vivere per pronunciare una simile frase.
Come tutte le nature poetiche, egli amava gl'ignoranti. Ben egli sapeva che nell'anima d'un essere ignorante c'è sempre posto per una grande idea. Ma non poteva sopportare gli stupidi, specie coloro che sono resi tali dall'educazione: gli uomini pieni d'opinioni delle quali non ne capiscono neppur una – tipo particolarmente moderno, messo in luce da Cristo quando lo dipinge come il tipo di colui che possiede la chiave della conoscenza, ma che, incapace di servirsene per conto proprio, impedisce anche agli altri di usarla, quantunque essa possa aprire la porta del regno del Cielo. Contro i Filistei egli condusse la sua più fiera campagna. È la guerra che devono combattere tutti i figli della luce. Il Filisteo era la figura caratteristica dell'età e dell'ambiente nel quale Cristo viveva. Con la loro opaca rispettabilità, la loro noiosa ortodossia, con la loro esclusiva preoccupazione del lato volgarmente materialistico della vita e la loro prosopopea di se stessi e della propria importanza, i Giudei di Gerusalemme, al tempo di Cristo, erano l'immagine esatta del filisteismo britannico del nostro tempo. Cristo si beffò dei «sepolcri imbiancati» e la sua frase rimase eterna. Trattò il successo materiale come una cosa da disprezzarsi assolutamente. Non voleva vedere in esso nulla d'importante. Considerava la ricchezza come un ingombro per l'uomo. Non voleva affatto sentir parlare di sacrificio della vita a un qualunque «sistema» di pensiero o di morale. Mostrò che le forme e le cerimonie erano fatte per l'uomo e non già l'uomo per le forme, le convenzioni e le cerimonie. Prese l'idolatria del sabato a bersaglio delle sue sfide. Le filantropie a freddo, le ostentate carità pubbliche, i massacranti formalismi così cari allo spirito dei mediocri – tutto denunciò con uno sdegno implacabile. Per noi l'ortodossia è semplicemente un'acquiescenza facile e idiota, ma per essi e nelle loro mani era una tirannide terribile e paralizzatrice. Cristo la ripudiò. Sostenne e provò che soltanto lo spirito contiene un valore. Quasi con un maligno piacere dimostrava loro che, malgrado lo studio continuo della legge e dei profeti, essi non avevano, in realtà, la più piccola idea di quel che le une e gli altri significassero. Al contrario della loro suddivisione di ogni giornata in una serie fissa di pratiche prescritte, come un tritume di menta e di ruta, egli predicò l'enorme valore di vivere per l'ora presente.
Coloro ch'egli salvò dai peccati, furono salvi soltanto per merito di alcuni momenti belli nella loro vita. Nel veder Cristo, Maria Maddalena spezza il ricco vaso d'alabastro donàtole da uno de' suoi amanti e sparge gli aromi sui piedi stanchi e polverosi del Maestro; ed è appunto in forza di questo momento unico ch'ella è posta per sempre, con Ruth e Beatrice, in mezzo alle ghirlande di rose bianche del Paradiso. Tutto ciò che Cristo ci insegna con piccoli mòniti si è che ogni istante della nostra vita deve essere bello, che l'anima ha da essere pronta per l'arrivo dello sposo, sempre attenta alla voce dell'amante – poichè il Filisteismo è semplicemente quel lato dell'indole dell'uomo che non s'illumina alla fiamma dell'immaginazione. Cristo vede tutte le più splendide facoltà della vita come delle attitudini luminose: la stessa immaginazione è la luce del mondo. Il mondo è creato da lei e tuttavia non la comprende; il che si spiega, poichè l'immaginazione è un manifestarsi dell'amore ed è l'amore e la facoltà d'amare che distinguono tra loro gli esseri umani.
Senonchè, gli è nelle sue relazioni con i peccatori che Cristo è sopra tutto romantico, nel senso più reale della parola. Il mondo aveva sempre venerato i santi, perchè sono i più prossimi alla perfezione di Dio. Cristo, invece, guidato da un istinto divino, sembra che abbia sempre amato il peccatore come il più prossimo alla perfezione dell'uomo. Il suo desiderio originario non era già quello di redimere gli uomini – come non era di lenire il dolore. Trasformare un ladro interessante in un onest'uomo noioso – non era proprio il suo scopo. Egli avrebbe avuto una ben misera idea della Società per la Redenzione dei Carcerati e d'altre iniziative moderne del medesimo genere. La conversione d'un pubblicano in un fariseo non gli sarebbe parsa un atto molto degno di gloria. Ma egli considerava il peccato e la sofferenza in una maniera che il mondo non ha peranco compreso, come due cose belle e sante, come forme di perfezione.
Questa sembra un'idea pericolosa ed è pericolosa, di fatti, come tutte le grandi idee. Ma non c'è nessun dubbio ch'era veramente il credo di Cristo. Ed io non esito a ritenerla una verità straordinaria.
Certo, occorre che il peccatore si penta. Ma perchè? Per la semplice ragione che, altrimenti, non potrebbe rendersi conto di ciò che ha fatto. L'istante del pentimento è quello stesso dell'iniziazione. È anche più: è il mezzo col quale si muta il proprio passato. I Greci non reputavano possibile tutto ciò. Spesso affermano nei loro aforismi gnòmici: «Nemmeno gli Dei potrebbero mutare il loro passato». Ebbene – Cristo ha mostrato che il più comune dei peccatori può farlo e che anzi è l'unica cosa che può fare.
Se ne fosse stato richiesto, Cristo, ne sono sicuro, avrebbe risposto che nell'istante in cui il figlio prodigo cadde in ginocchio davanti al padre e ruppe in singhiozzi, egli trasformò le sue orgie, le sue umiliazioni e la sua degradazione in altrettanti momenti belli e santi della propria vita. È difficile, lo so, per la maggior parte degli uomini, l'afferrare una idea siffatta. Oso dire che bisogna andare in prigione per poterla comprendere. E se così è, vale veramente la pena di vivere in una galera.
C'è qualche cosa di così unico, in Cristo! Certo – come ci sono delle false aurore prima dell'aurora vera e dei giorni d'inverno incredibilmente dolci di sole che ingannano il croco e gli fanno sciupare l'oro anzi tempo o spingono il troppo ingenuo uccello al canto per invitare la sua compagna a costruire un nido su delle frasche ignude – così ci furono dei cristiani avanti Cristo. E siamone loro riconoscenti. Ma il male si è che non ce ne furono più dopo di lui. Faccio un'eccezione: San Francesco d'Assisi. Ma Dio gli aveva dato sin dalla nascita un'anima di poeta ed egli stesso, nella sua prima giovinezza, aveva tolto in mistiche nozze la sua sposa Povertà; con l'anima d'un poeta e il corpo d'un mendicante, San Francesco non percorre troppo difficilmente la via della perfezione. Egli comprese Cristo e così divenne simile a Lui. Non abbiamo bisogno del Liber conformitatum per apprendere che la vita di San Francesco è la vera Imitazione di Cristo; – poema che, comparato al Liber, non è che una prosa.
Sicuramente, il fascino di Cristo si è ch'egli è in tutto e per tutto simile ad un'opera d'arte. Non c'insegna nulla, in realtà; ma pel solo fatto d'essere condotti alla sua presenza si diventa qualcosa di più. E ciascuno di noi è predestinato a questa presenza. Almeno una volta nella sua vita, ogni uomo cammina con Cristo sino ad Emmaüs.
Ora – per ciò che riguarda l'altro soggetto, vale a dire il rapporto della Vita Artistica con la Condotta Umana, vi sembrerà certamente strano ch'io l'abbia scelto. La gente si mostra a dito il carcere di Reading e dice: «Ecco là a che cosa conduce una vita artistica!» Che monta? essa potrebbe menare anche a dei luoghi peggiori. Gli uomini meccanizzati pei quali la vita è una continua speculazione, dipendente da uno scrupoloso calcolo di mezzi e di sistemi, – essi lo sanno sempre dove vogliono arrivare e ci arrivano. Si mettono in cammino col desiderio ideale d'essere sagrestani della loro parrocchia e, qualunque sia la sfera in cui agiscono, finiscono sempre coll'essere sagrestani della loro parrocchia, e nulla più. Un individuo che brama di divenire qualcosa di diverso da sè stesso, cioè: d'essere membro del Parlamento o pizzicagnolo che s'arricchisce o avvocato famoso o giudice o qualche cos'altro di ugualmente noioso, riesce con ogni probabilità a divenire ciò che desidera. Ed è così che trova il suo castigo. Coloro che vogliono una maschera sono condannati a portarla per sempre.
Ma con le energie dinamiche della vita e con coloro ne' quali queste forze s'incàrnano, tutto è diverso. Quelli che desiderano soltanto di essere sè stessi non sanno mai dove vanno. Non possono saperlo. In un senso del termine, è necessario e naturale il conoscere sè stessi, – come disse l'oràcolo ellenico; questo è il primo passo della conoscenza. Ma riconoscere che l'anima d'un uomo è inconoscibile – ecco l'ultimo risultato della saggezza. Il mistero finale risiede in noi stessi. Dopo aver pesato il calore e la massa del sole, misurate le fasi della luna, disegnate le mappe dei sette cieli, stella per stella, – è ancora l'«io» in sè, che rimane. Chi può calcolare l'orbita della propria anima? Quando il figlio si pose in cammino per rintracciare gli asini di suo padre, egli non sapeva che l'uomo di Dio lo aspettava con la crèsima della consacrazione e che la sua anima era già quella di un re.
Spero di vivere abbastanza per produrre un'opera di tal carattere ch'io possa dire alla fine dei miei giorni: «Sì!; ecco a che cosa può condurre un uomo, una vita Artistica!» Due delle vite più perfette ch'io mi conosca sono quelle di Verlaine e del principe Kropotkine. Entrambi hanno passato degli anni in prigione; il primo è l'unico poeta cristiano dopo Dante; l'altro possiede una bella anima di Cristo candido, come ci si attende che debbano venirne dalla Russia. Durante gli ultimi sette od otto mesi, – nonostante una serie di crucci che mi son venuti dal mondo esterno (quasi senza interruzione) – mi sono messo in contatto immediato con uno spirito nuovo che agisce in questo carcere per mezzo degli uomini e delle cose e che mi ha soccorso in modo indicibile; cosicchè io, che per tutto il primo anno della mia reclusione non ho fatto che torcermi le mani, ben mi ricordo, e gridare con una impotente disperazione: «Quale tracollo! Quale spaventevole fine!», adesso invece tento di dirmi e, qualche volta, quando non mi torturo da me stesso, realmente e sinceramente mi dico: «Quale nuovo principio! Quale meraviglioso principio!» Può darsi che sia così, in realtà. Può darsi che la cosa divenga così. E allora quanto io dovrei a questa personalità nuova che trasforma l'esistenza di ognuno, anche qua dentro!
Vi sarà possibile comprenderlo, quando vi dirò che, se fossi stato liberato nel maggio scorso (come desideravo), avrei lasciato questo luogo con l'anima piena di amaro odio contro di esso e contro i carcerieri – ma questo sentimento cattivo avrebbe poi avvelenato la mia vita. Ho subìto un anno di reclusione di più, ma un senso vivo d'umanità è pur stato in carcere con tutti noi ed ora, quando me ne andrò, io mi rammenterò sempre le grandi premure che quasi tutti qui hanno avuto per me; e il giorno della mia liberazione rivolgerò un grazie a non pochi, e domanderò loro in ricambio che si ricordino qualche volta di me.
I sistemi della prigione sono assolutamente e interamente crudeli. Molto darei per poterli cangiare. Ho intenzione di fare questo tentativo. Ma quantunque un sistema sia così difettoso, lo spirito d'umanità – che è poi lo spirito d'amore (lo spirito di Cristo che non si trova dentro le chiese) – riesce almeno a farlo sopportare senza troppa amarezza, se non proprio a mutarlo radicalmente.
So anche che, fuori, mi aspettano innumerevoli e deliziose cose, da quelle che San Francesco chiama «frate vento e sorella piova» alle vetrine dei negozi e ai tramonti delle grandi città. Se facessi un elenco di tutto ciò che ancor mi rimane, non so dove mi fermerei, perchè veramente Dio ha creato il mondo, tanto per me quanto per gli altri. Forse io uscirò di qui in possesso di qualche cosa che prima non avevo. Non ho bisogno di dirvi che per me le riforme della morale sono insignificanti e volgari come quelle della teologia. Ma, mentre la risoluzione d'essere un uomo migliore è un atto sperimentale ed ipocrita – essere divenuto, invece, più profondamente uomo è il privilegio di coloro che hanno sofferto; – ed io credo d'esserlo divenuto.
Se, quando sarò libero, uno de' miei amici darà una festa senza invitarmi, io non troverò nulla a ridire. Posso essere perfettamente felice solo con me stesso. Con la libertà, i fiori, i libri e la luna, chi non sarebbe felice? D'altra parte, le feste non sono più fatte per me. Ne ho date troppe, perchè debba curarmene ancora. Questo lato della vita è finito per me – assai fortunatamente, oso dire. Ma se, quando sarò libero, uno de' miei amici avesse un dolore e m'impedisse di prendervi parte, ne risentirei un'amarezza infinita. S'egli mi sbarrasse le porte della casa in lutto, io ritornerei chissà quante volte a supplicarlo d'esservi ammesso, pur d'avere la mia parte di ciò cui ho diritto. S'egli mi reputasse incapace e indegno di piangere con lui, ne proverei l'umiliazione più sanguinosa; considererei la sua ripulsa come la maniera più terribile per avvilirmi. Ho un diritto di partecipare al dolore e colui che può contemplare la bellezza del mondo, sentendone anche la sofferenza, comprendendo entrambe le meraviglie, – colui è in contatto con le cose divine e s'è avvicinato al segreto di Dio per quanto è possibile.
Giova credere che nella mia arte, non meno che nella mia vita, vi sarà una nota più profonda ancora – una nota di più grande unità di passione e d'impulso. È l'intensità e non la latitudine lo scopo vero dell'arte moderna. Nell'arte non dobbiamo più occuparci del tipo, ma dell'eccezione. Io non posso dare alle mie sofferenze nessuna delle forme reali che assunsero. L'Arte comincia là dove l'Imitazione finisce; ma qualcosa penetrerà nella mia opera, una pienezza di memoria verbale, di cadenze più ricche, di effetti più curiosi, di un ordine architettonico più semplice – per lo meno di un'altra qualità estetica.
Quando Marsia fu «strappato dalla vagina delle sue membra» – dalla vagina delle membra sue, per usare la frase di Dante, d'una concisione terribile, addirittura tacitiana – egli non ebbe più nessun canto sulle sue labbra, dicono i Greci. Apollo aveva vinto. La lira aveva vinto la zampogna. Ma forse i Greci si sono ingannati. Io odo il grido di Marsia in una gran parte dell'arte moderna. È amaro in Baudelaire, dolce e lamentevole in Lamartine, mistico in Verlaine. Si ritrova nelle catharsi lente della musica di Chopin. E nelle donne di Burne-Jones. Anche Matteo Arnold ce lo fa udire, sebbene egli ci parli, nel suo canto di Callicle, del trionfo «della dolce e suadente lira» e «della famosa ultima vittoria», con una così bella, tersa nota di lirismo. Nel mormorio irrequieto di dubbio e di affanno che pervade i suoi versi, nè Goethe nè Wordsworth giovarono in alcun modo a Matteo Arnold, per quanto egli li abbia seguiti di volta in volta; e quando vuol dolersi del fato di Tirsi o celebrare lo scolaro Gypsy, gli occorre pur prendere la zampogna per esprimere il suo tormento. Ma, insomma, sia o non sia stato muto il fauno di Frigia – io non posso essere silenzioso. L'espressione mi è tanto necessaria quanto le foglie e i fiori lo sono per i rami neri degli alberi che s'intravvedono al di là delle mura della prigione e che senza posa si àgitano nel vento. Tra la mia arte e il mondo – c'è ora un vasto gorgo, ma tra l'arte e me stesso non ce n'è alcuno, almeno io lo spero.
A ciascuno di noi – la sua sorte. Il mio destino è stato di pubblica infamia, di lunga prigionia, di miseria, di rovina, di sventura, di fiele, ma io non ne sono degno – in ogni caso non ne sono ancor degno. Mi sovviene d'aver detto spesso che avrei potuto sopportare una tragedia reale, pur ch'ella mi si presentasse con un mantello di porpora e con la maschera d'un nobile dolore; ma ciò che v'è di orribile nella vita moderna si è ch'essa riveste la tragedia coi cenci della commedia, in modo che le più grandi realtà sembrano banali o grottesche o prive di stile. Questa è la perfetta verità intorno all'esistenza moderna. Si dice che tutti i martiri sembrano meschini a chi li osserva. Il secolo decimonono non fa eccezione alla regola.
Tutto, nella mia tragedia, è stato orrido, ripugnante, privo di stile: la nostra casacca stessa ci rende grotteschi. Noi siamo i buffoni del dolore; siamo i pagliacci dal cuore spezzato. Siamo designati in modo speciale per essere gli zimbelli dei belli-spiriti. Il 13 novembre 1895 fui condotto da Londra a qua. Quel giorno, dalle due alle due e mezza, fui costretto a restare sulla banchina centrale della stazione di Clapham Junction, in uniforme da prigioniero colle manette ai polsi – come uno spettacolo per la folla. Mi avevano fatto uscire dall'infermeria senza darmi un momento di riposo. Ero più grottesco di qualsiasi altro immaginabile oggetto. Nel vedermi, la gente si metteva a ridere. Ad ogni treno, il circolo dei curiosi si ingrossava. Nulla li avrebbe divertiti maggiormente. E tutto ciò, è naturale, fino a che non seppero chi io ero; ma appena ne furono informati, risero anche di più. Per una mezz'ora intera io rimasi là, sotto la pioggia sottile di novembre, in mezzo alla folla che mi scherniva!
E durante un anno da quel giorno, ad ogni volger di sole, alla medesima ora, io piangevo per uno stesso spazio di tempo. Oh, non è una cosa tanto tragica come sembra! Per i prigionieri, le lagrime fanno parte dell'esperienza quotidiana. Una giornata in carcere senza pianto è una giornata in cui il cuore è duro e non è una giornata in cui il cuore possa essere felice.
Adesso, però, comincio a provare più rimorso per coloro che risero di me, che per me stesso. Certo, quando essi mi videro, io non ero più sul mio piedestallo – ero alla gogna. Ma sono le nature assai poco fantasiose che si preoccupano solamente degli uomini eretti sur un piedestallo. Un piedestallo può essere una cosa del tutto irreale. Una gogna, invece, è una terribile realtà. Essi avrebbero dovuto saper meglio interpretare il dolore. Ho detto già che dietro il dolore c'è sempre il dolore. Sarebbe più esatto dire che dietro il dolore c'è sempre un'anima. Ora – beffarsi di un'anima in pena è cosa terribile. Nell'economia stranamente semplice del mondo non si riceve se non ciò che si dona e a coloro che non hanno abbastanza forza per penetrare l'aspetto esterno delle cose e sentire la pietà, quale pietà si può dare se non quella del disprezzo?
Riferisco queste cose semplicemente perchè si comprenda quanto mi è stato difficile trarre dal mio castigo ben altro che amarezza e disperazione. Eppure mi tocca estrarne una cosa diversa e, di quando in quando, ho dei periodi di sottomissione e di rassegnazione. La primavera intera può essere racchiusa nell'unica gèmmula d'una pianta e il nido dell'allodola a fior della terra può contenere la gioia che annuncerà la comparsa d'innumerevoli aurore color di rosa e di porpora. Così, forse, ciò che mi resta ancora di bellezza di vita è racchiuso in qualche àttimo d'abbandono, di diminuzione di me stesso e d'umiliazione. Tuttavia, io posso semplicemente continuare a perseguire il mio proprio sviluppo e, accogliendo tutto ciò che mi è accaduto, rendermene degno.
Alcuni avevano l'abitudine di dire ch'io ero troppo individualista. Ora, più che mai, mi occorre essere individualista. Devo cavar fuori da me stesso molto di più di quel ch'io ne abbia tratto sin qui ed esigere dal mondo assai meno di quanto gli abbia mai domandato. La mia rovina, in vero, deriva non da eccessivo individualismo, ma dal suo difetto. L'azione ignominiosa, imperdonabile ed eternamente disprezzabile della mia vita fu di avere accondisceso a rivolgermi alla società per ottenerne aiuto e protezione. Scendere a questo sarebbe stato un errore, dal punto di vista dell'individualismo, ma quale scusante invocare, dopo aver compiuto una cosa simile? Naturalmente una volta messe in moto le macchine della Società, essa si rivolse contro di me e disse: «Come! tu hai vissuto fino ad ora disprezzando le mie leggi, ed ora vieni a domandarmi aiuto per mezzo di queste leggi stesse? Bene: ti saranno applicate col massimo rigore. Sarai obbligato a sottometterti alle leggi che hai invocato». L'effetto è questo: ch'io sono in carcere. Certo, nessun uomo cadde così ignobilmente e con dei metodi tanto ignobili.
L'elemento filisteo della vita non consiste nell'incapacità di comprendere l'arte. Ci sono degli esseri piacevoli, come ad esempio i pescatori, i pastori, gli operai, i contadini ed altri che non s'intendono d'arte, e pure sono il vero sale della terra. Filisteo è quegli che sostiene ed aiuta le forze meccaniche, pesanti, ingombranti e cieche della società; e che non arriva ad ammettere un'energia dinàmica quando s'imbatte in essa, sia incarnata in un uomo o in un'azione qualunque.
Han giudicato spaventevole da parte mia il fatto d'aver invitato a pranzo dei cattivi soggetti e d'essermi compiaciuto in loro compagnia. Ma, dal punto di vista nel quale io mi ponevo come uomo d'arte, essi erano deliziosamente suggestivi ed eccitanti. Il pericolo formava la metà del piacere... In quanto artista, avrei dovuto interessarmi solo d'Ariele e non mettermi a lottare con Calibano...
Uno de' miei grandi amici – d'un'amicizia decennale – venne a trovarmi qualche tempo fa e disse che non credeva nemmeno a una parola di tutto ciò che si era macchinato contro di me e s'augurava ch'io mi persuadessi d'essere considerato da lui assolutamente innocente e vittima d'una vile congiura.
Non potei frenare le mie lagrime nell'ascoltarlo e gli risposi che, nonostante le accuse interamente false formulate contro di me e a malgrado delle colpe attribuitemi per malvagità imperdonabile, tuttavia la mia vita era stata piena di piaceri crudeli e che non m'era più possibile restare suo amico o trovarmi ancora in sua compagnia altro che a patto ch'egli accettasse la mia confessione e vi credesse pienamente. Fu per lui un grave colpo; ma noi siamo rimasti amici e almeno non ho ottenuto il dono della sua amicizia con l'ipocrisia.
Le forze dell'emozione, come ho detto in qualche passo delle Intenzioni, sono altrettanto limitate in latitudine ed in durata quanto le energie fisiche. La piccola coppa che è foggiata in modo da contenere una data misura di liquido non può contenerne una stilla di più, anche se le cantine della Borgogna traboccassero di vino e i vignaiuoli pestassero sino al ginocchio il raccolto dei sassosi vigneti di Spagna. Non c'è errore più diffuso del pensare che coloro i quali sono le cause o le occasioni d'una grande tragedia siano poi partecipi dei sentimenti che si convengono alla tragedia stessa; nessun errore è più fatale che aspettarsi questi sentimenti da parte loro. Il martire, nel suo «sudario di fiamma» può contemplare il volto del Signore, ma per colui che ammucchia le fascine o che attizza i ceppi affinchè ardano, lo spettacolo non è più impressionante della morte d'un bue per il macellaio, o della caduta d'un albero pel boscaiolo o d'un fiore per il falciatore dei prati. Le grandi passioni sono per coloro che hanno una grande anima e i grandi avvenimenti non possono essere veduti e compresi se non da quelli che sono al loro stesso livello.
In tutto il dramma, dall'angolo visuale artistico, io non conosco nulla che sia da paragonarsi alla creazione shakesperiana di Rosencrantz e Guildenstern, nulla che sia più suggestivo in quanto a finezza d'osservazione. Essi sono i camerati di Amleto. Ne furono già i compagni. Recan con sè il ricordo delle piacevoli giornate trascorse assieme. Nel momento in cui essi incontrano Amleto, nel dramma, egli vacilla sotto un peso insostenibile per chiunque abbia il suo temperamento. I morti sono balzati in armi dalla tomba per imporgli un compito al tempo stesso troppo grande e troppo angusto per lui. È un sognatore costretto alla azione. Amleto è un poeta e gli si comanda di misurarsi con la doppia complessione della causa e dell'effetto, con la vita nella sua contingenza pratica (della quale nulla conosce) e non con la vita nella sua essenza ideale ch'egli penetra tanto bene. Egli non ha nessuna idea di ciò che convenga fare e la sua follìa consiste nel simulare la follìa. Bruto si servì della demenza come d'un mantello per nascondervi sotto la spada, la daga della sua volontà, ma la pazzia d'Amleto è una semplice maschera per dissimulare la propria debolezza. Facendo dello spirito, abbandonandosi a degli scherzi, egli crede di ottenere una via di scampo. Si ostina a giocare coll'azione come un artista gioca con una teoria. Fa la spia a' suoi stessi atti e, sentendosi parlare, egli sa che non sono altro che «parole, parole, parole». Invece di tentare di essere l'eroe della sua storia, cerca d'essere lo spettatore della sua tragedia. Dubita di tutto, compreso sè stesso, e tuttavia il suo dubbio non l'aiuta, perchè non è effetto di uno scetticismo, ma di una volontà che si scinde.
Di tutto ciò Rosencrantz e Guildenstern non capiscono niente. Essi sorridono, si piegano, fanno i graziosi e quel che l'uno dice l'altro lo ripete, sempre sul medesimo tono. Quando, infine, per mezzo del dramma intercalato nel dramma e delle tenerezze che si scambiano gli attori, Amleto «sorprende la coscienza» del Re e lo caccia dal suo trono, miserabile e spaventato, Guildenstern e Rosencrantz non vedono nel suo gesto che una penosa infrazione alle regole dell'etichetta di corte. Sino a questo punto e non più oltre essi possono giungere «nella contemplazione dello spettacolo della vita con delle emozioni adeguate». Eglino sono i più vicini al suo segreto e non ne sanno nulla. E non gioverebbe a niente il rivelarlo loro. Essi sono la piccola coppa che contiene una determinata misura e basta. Verso la fine, com'è detto, essi hanno trovato o troveranno una morte improvvisa, caduti in un'insidia tesa per un altro. Ma una fine tragica di tal fatta, benchè lo spirito d'Amleto la sfiori un poco con la sorpresa e la giusta aria della commedia, non si conviene realmente a dei personaggi come loro. Essi non muoiono mai. Horazio, il quale, per «difendere dinnanzi ai malcontenti Amleto e la sua causa»,
Absents him from felicity a while
And in this harsh world draws his breath in pain,
muore, ma Guildenstern e Rosencrantz sono immortali come Angelo e Tartufo e devono essere collocati assieme a loro. Essi sono la metamorfosi che la vita moderna ha fatto dell'antico ideale dell'amicizia. Colui che scriverà un nuovo trattato de Amicitia dovrà serbar loro un cantuccio e tesserne l'elogio in prosa tuscolana. Sono tipi oramai fissati per tutti i tempi. Censurarli equivarrebbe a mostrare «una mancanza d'apprezzamento». Si trovano semplicemente fuori della loro sfera – ecco tutto. Quanto a sublimità d'anima, non c'è pericolo di contagio. Gli alti pensieri e le grandi emozioni sono isolati dal fatto stesso della loro esistenza.
Se tutto va bene, io sarò liberato verso la fine di maggio e spero di partir subito per qualche piccolo villaggio marittimo straniero, con R... e M...
Il mare, come dice Euripide in uno de' suoi poemi su Ifigenia, lava le macchie e le ferite del mondo.
Spero di vivere almeno un mese con i miei amici, di ritrovare la calma e l'equilibrio, un cuore meno torturato e delle aspirazioni più tranquille. Provo uno strano desiderio per le grandi cose semplici e primordiali, come il mare che è una madre per me al pari della terra. Mi sembra che tutti noialtri si contempli troppo la natura, e, viceversa, si viva troppo poco in comunione con essa: vedo una grande ragione nell'attitudine dei Greci. Essi non ragionavano mai intorno ai tramonti del sole e nemmeno disputavano per decidere se le ombre sui prati erano violacee o no. Ma vedevano che il mare è fatto per il nuotatore e la sabbia per il corridore. Amavano gli alberi per l'ombra che diffondono e la foresta per il suo raccolto silenzio nell'ora del meriggio. Il vignaiuolo intrecciava dell'edera ne' suoi capelli per difendersi dai raggi del sole, quando s'affaticava intorno ai tralci pur mo' nati; e l'artista e l'atleta, i due tipi che l'Ellade ci ha dato, intrecciavano in ghirlande le foglie d'alloro amaro e la cicuta che non sarebbero state altrimenti utili all'uomo.
Siam soliti denominare la nostra età utilitaria e non c'è una cosa sola di cui noi sappiamo esattamente gli usi. Abbiamo dimenticato che l'acqua può forbire, il fuoco purificare e che la terra è la madre di noi tutti. Per conseguenza – la nostra arte è priva di luce, come la luna, e si diverte con delle ombre, mentre l'arte dei Greci ha i lampeggiamenti del sole e interpreta direttamente le cose. Sono convinto che c'è una purificazione nelle forze elementari e voglio ritornare ad esse e con esse vivere.
Certo, per uno spirito moderno come me, «figlio del mio tempo» contemplare semplicemente il mondo sarà sempre una delizia. Tremo di piacere, pensando che il giorno in cui sarò libero il citiso ed i lillà fioriranno nei giardini ed io vedrò il vento agitare, con una rabbrividente bellezza, l'oro dell'uno e la pallida porpora dell'altro, in modo che la terra avrà per me tutti i profumi d'Arabia. Linneo cadde in ginocchio e pianse di felicità, quando vide per la prima volta le estese brughiere d'un altipiano inglese tutte gialle dei fiori agresti e aromatici dei giunchi, ed io so che per me, posseduto dallo stesso desiderio dei fiori, ci son delle lagrime che m'aspettano nei petali d'una rosa. È sempre stato così, sino dalla mia infanzia. Non c'è una sola sfumatura nascosta in fondo al calice d'un fiore, non c'è la curva e molle linea d'una conchiglia cui la mia anima – per una misteriosa e sottile simpatia con l'anima delle cose – non faccia eco. Come Teofilo Gauthier io son uno di quelli pei quali il mondo esterno esiste.
Pur tuttavia, ora ho coscienza che sotto tutta questa bellezza, per quanto soddisfacente essa sia, c'è qualche spirito nascosto le cui forme e i cui contorni dipinti non sono che pure manifestazioni ed è con questo spirito ch'io voglio mettermi in armonia. Sono stanco delle formule fisse degli uomini e delle cose. Il Mistico nell'Arte, il Mistico nella Vita, il Mistico nella Natura – ecco ciò che io cerco. Ho assolutamente bisogno di trovarlo in qualche luogo.
Ogni volta che si subisce un giudizio, tutta la vita vien giudicata – come tutte le sentenze sono delle sentenze di morte; ed io sono stato ben tre volte in giudizio! La prima volta, lasciai la sala per essere arrestato; la seconda, per essere ricondotto al carcere di detenzione; la terza, per venir cacciato in galera per due anni. La società, come noi l'abbiamo costituita, non avrà più alcun posto da offrirmi; ma la Natura le cui sottili pioggie cadono dolcemente sui giusti e sugli ingiusti avrà nelle sue roccie delle fessure dentro cui mi nasconderò e delle valli inesplorate nel silenzio delle quali potrò piangere senza essere distratto!
Essa appenderà delle stelle alle pareti della notte, affinchè io possa camminare senza inciampi in mezzo alle tenebre, e manderà il vento a soffiare sull'orma de' miei passi, in modo che nessuno mi dìa una caccia a morte; la natura mi laverà nelle sue grandi acque e mi risanerà con le sue erbe amare.
envoyé par dq82 - 22/2/2015 - 15:45
Si veda anche The Ballad of Reading Gaol, sempre di Oscar Wilde.
Bernart Bartleby - 22/2/2015 - 18:13
×
![]()
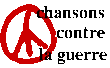








Il titolo dell’opera preannuncia in un certo senso che lo scrittore scaverà profondamente nella sua anima per esternare pensieri, rimembranze, ossessioni ed evoluzioni intellettuali che caratterizzarono ed accompagnarono la sua permanenza in carcere. Attraverso l'accuratezza e l'erudizione dei periodi wildeiani, è inevitabile tra l'altro, nella lettura della lettera, ripercorrere passo passo gli avvenimenti della vita dello scrittore, dall'incipit della sua amicizia con il narciso Alfred Douglas, passando per le sue esperienze processuali durante lo scandalo che lo fece condannare per omosessualità, sino alla sua denigrante esperienza carceraria.
La lettera risale ai primi mesi del 1897, anno in cui Wilde si trova nella prigione di Reading, detta anche della Regina, scontando una pena di due anni ai lavori forzati per il reato di sodomia. È durante le interminabili giornate in carcere che egli decide la sua stesura, poiché come scriverà lo stesso Wilde: "Noi che siamo in carcere, e nelle cui esistenze non c'è nessun avvenimento, eccetto il dolore, dobbiamo misurare il tempo con i palpiti della sofferenza e la ricapitolazione dei momenti amari".
Il fine dell'epistola è essenzialmente pedagogico nei riguardi del giovane "Bosie", nomignolo col quale veniva chiamato Lord Douglas. Wilde intende infatti portare la coscienza del giovane, tanto atrofizzata da quella totale mancanza di immaginazione (evidenziata più volte dallo scrittore nel corpus della lettera) e annebbiata da quell'ate (accecamento) proveniente da un odio, che fa le veci di un "padrone indulgente", ad uno stadio di maturazione e comprensione. Affermerà Wilde ad inizio epistola, riferendosi a Lord Douglas: "Non dubito che in questa lettera [...] vi sarà molto che ferirà nel vivo la tua vanità. In questo caso, leggi e rileggi questa lettera finché la tua vanità sarà morta del tutto. Se vi troverai in essa qualche cosa di cui ti riterrai accusato ingiustamente, ricorda che bisognerebbe essere grati per ogni colpa di cui si è accusati ingiustamente. Se vi sarà in essa un solo passo che porterà lacrime ai tuoi occhi, piangi, come piangiamo noi in carcere, dove per le lacrime non esiste distinzione tra il giorno e la notte. Sarà la sola cosa che potrà salvarti".
Nella prima parte del testo Wilde si pone come obiettivo quello di spiegare le grandi differenze comportamentali tra se stesso e Bosie; infatti nonostante i due provengano dalla stessa classe sociale, il loro modo di confrontarsi con la vita è molto diverso. Oscar ha frequentato l’Università a pieni voti, Bosie è stato invece “pigro a scuola, peggio che pigro all’Università”.
Tra le grandi e profonde differenze intellettuali e comportamentali dei due protagonisti del De Profundis vi sono inoltre la natura gentile e aderente all'amore di Wilde, in contrapposizione a quella violenta, a volte volgare, e dominata dall'odio di Lord Douglas; l'innata erudizione e tendenza all'"arte come filosofia e alla filosofia come arte" del genio sorprendente di Wilde, in contrasto con la sterile immaginazione e cultura del vanitoso "Bosie", che tanto interferì nella produzione artistica dello scrittore e dilaniò la sua vocazione all'arte nei periodi in cui i due si frequentarono assiduamente, che il tempo che Wilde trascorreva con il giovane si dimostrò "infruttuoso". Douglas era solito tra l'altro seguire Wilde nelle sue occasioni mondane, godere della sua fama, ma soprattutto del suo patrimonio, dal quale attingeva assiduamente somme enormi di denaro, spesso senza alcun riguardo e avvertimento.
Attraverso parole amare, ma sagge, Wilde non smette un attimo di rimproverarsi le debolezze dimostrate in ogni occasione nei riguardi di Alfred, che insaziabile di piaceri e sfarzi superflui e colmo di presunzione ed arroganza, non fu solo fautore della sua incarcerazione, ma anche della bancarotta che segnò un periodo di povertà fino alla fine dei suoi giorni.
I momenti trascorsi con Bosie sono quindi sterili e improduttivi: al ragazzo non importa il genio di Wilde, tanto che raramente i due si trovarono a parlare per più di cinque minuti di argomenti degni di trattazione, a lui preme solamente di andare a consumare la prima colazione al Café Royal o da Berkeley, pranzare al Savoy o a Tite Street, cenare infine da Willies, locali dell'epoca naturalmente esclusivi e dei cui conti indubbiamente si occupava Wilde.
Quest'ultimo decide, come spiegherà espressamente nella lettera, di tagliare ogni legame con il giovane, prevedendo il buio baratro in cui lo trascinerà più avanti il ragazzo, come però si può intuire, non ne sarà mai definitivamente capace, a causa della sua natura alquanto generosa e altruista. Nel corso del lungo arco di tempo in cui i due si incontrarono, si alternano periodi di circa tre mesi, in cui la pace padroneggia anche se non totalmente, e successivi litigi accompagnati da scenate pubbliche "volgari" ed oltremodo "violente" da parte del giovine nei confronti dell'illustre scrittore. Altra figura, che si mostrò in tutta la propria malvagità, ignoranza e rozzezza, fu quella del marchese di Queensberry, nonché padre del narciso Lord Douglas. La presenza di quest'uomo fu determinante per la rovina di Wilde. Fu questi infatti ad accusarlo di sodomia, persegitandolo e minacciandolo. Famoso è il biglietto intrinseco di ignoranza della lingua lasciato dal marchese nel club di Wilde: "Ad Oscar Wilde, che si atteggia a somdomita" (sic).
Wilde si trovò così ad essere non solo oggetto, ma anche vittima, della continua lotta che caratterizzava Lord Douglas e il padre. Il giovane sacrificò e strumentalizzò, accecato dall'odio, la vita di colui che più lo aveva seguito, amato e perdonato nel corso della sua vita, Wilde, per una causa in cui non credeva davvero, ma che perseguiva egoisticamente.
Oscar, adesso in prigione, comprende che sarebbe stato meglio per lui se non fosse mai entrato nel mezzo ai continui problemi tra Douglas e suo padre: John Sholto Douglas, Nono Marchese di Queensberry. Alfred era diventato sempre più un concentrato di odio e vanità e obbliga Wilde a fare causa al suo stesso padre, elemento che poi si ritorcerà contro di lui, ovvero con l’incarcerazione. In carcere Oscar si rende conto di come la sua vita sia stata un giocattolo nelle mani di questo ragazzo e i tre anni passati insieme gli siano stati fatali oltre al fatto che la sorte abbia creato diversi destini per i due aristocratici:
“A te [Bosie] sono toccati in sorte libertà, piaceri, divertimenti, una vita di agi; e tu non ne sei degno. A me è toccato un destino di pubblica infamia, una lunga prigionia, e infelicità, rovina, disonore; e di questo, nemmeno io sono degno; non ancora per lo meno.”
Wilde ha avuto le sue illusioni, avrebbe voluto una vita come “una commedia brillante” e che Alfred diventasse uno dei suoi molti affascinanti personaggi; ma niente di tutto ciò è avvenuto e solo in prigione egli capisce quanto abbia sbagliato. Egli ha sempre e solo vissuto per il piacere e per la perfezione, il dolore lo ha evitato in ogni momento fino a quando, in cella, ne comprende la vera essenza: “Il dolore è la suprema emozione di cui l’uomo è capace”.
La lettera che Wilde sta scrivendo è la confessione di tutti i peccati commessi ma è anche un continuo rimprovero all’atteggiamento di Bosie, che proprio nel momento del bisogno scompare e addirittura tenta di pubblicare alcune lettere private inviategli dal suo amato.
Due anni sono tanti da passare in prigione ed egli li passa aprendo il suo cuore e continuando a sperare in un riavvicinamento con il suo intimo amico, ma la tristezza di questa situazione è che l’amore che Wilde prova per Alfred non potrà mai equiparare quello del giovane verso di lui, ciò pare non turbare l’animo dello scrittore il quale pensa per lo più a una possibile risposta alla lettera e soprattutto a un incontro fuori dal carcere.
Tutto ciò che succederà quando uscirà non gli interessa, sa che sarà pieno di debiti e non sarà più invitato alle grandi cene ma cosa sono queste cose davanti all’Amore? Wilde afferma e sottolinea che non gli si possono chiudere per sempre le porte in faccia, è per questo che vuole rivederlo, anche se lontano da occhi indiscreti.
La cosa più struggente è leggere nell’introduzione che Alfred negherà di aver mai ricevuto questa lettera. Tuttavia, dopo che Oscar viene scarcerato, i due non possono fare a meno di cercarsi così riprendono la loro relazione per breve tempo, in Italia, in sordina. Quando però, le rispettive famiglie, vengono a conoscenza di questo, impongono il proprio dissenso alla relazione, ancora una volta, minacciando di togliere ai due la sussistenza economica (ed è chiaro che Wilde, uscito dal carcere e senza alcun avere, non può permettersi di perdere persino quel po' di denaro passatogli dai propri parenti).
Quando Wilde alla fine deciderà di non volerlo vedere mai più, descriverà i loro incontri come “the most bitter experience of a bitter life.”
La lettera si conclude con un consiglio per Alfred ovvero quello di non aver paura del passato, ciò che è meglio fare è accettarlo e andare avanti. Oscar termina presentandosi, anzi salutandosi, come il maestro di Bosie, un maestro che forse ancora non gli ha insegnato tutto della vita ma che sicuramente con questa lettera gli ha descritto il significato del Dolore e la sua bellezza. Se questa doveva essere inizialmente una lettera di pentimento, un primo passo per trasformare il proprio passato, ma anche di odio e di rimprovero verso il suo amante, infine si mostra come una missiva di perdono e di amore, non molto ricambiato.
Dopo la sua scarcerazione, Wilde affidò il manoscritto dell'opera (con il titolo di Epistola: In Carcere et Vinculis) al suo fedele amico Robert Ross, pregandolo di farne due copie, una delle quali avrebbe dovuto essere spedita a Lord Alfred Douglas. Il testo venne pubblicato per la prima volta nel 1905 - cinque anni dopo la morte di Wilde - con il titolo di De Profundis; fu però rimaneggiato da Ross che tolse dalla versione definitiva qualsiasi allusione a Bosie e alla famiglia Queensberry. Una nuova versione, leggermente accresciuta, sarebbe stata edita nel 1908, insieme a due lettere scritte dall'ex detenuto Wilde all'editore del giornale "Daily Chronicle". Intanto Ross aveva donato al British Museum il manoscritto del De Profundis, ma ad una condizione: che l'opera integrale non sarebbe stata resa nota se non dopo il 1960.
Quando però nel 1913 Douglas denunciò per diffamazione lo scrittore Arthur Ransome, per averlo accusato, in una biografia dedicata ad Oscar Wilde, di essere stato la causa della rovina del poeta irlandese, alcuni brani dell'epistola riguardanti Bosie vennero pubblicati sul "London Press", e Douglas perse la causa. Egli avrebbe dapprima dichiarato di avere ricevuto una copia del manoscritto, ma di averla gettata nel fuoco, per poi contraddirsi, affermando di non avere mai ricevuto niente. Ross in seguito fece pubblicare altri brani inediti del libro.
Nel 1947 grazie al figlio dello stesso Wilde, Vyvyan Holland, il De Profundis fu pubblicato in versione integrale. Holland però si era basato sul dattiloscritto lasciatogli in eredità da Robert Ross, il quale conteneva diversi errori, correzioni dello stesso Ross ed alcune omissioni. Soltanto nel 1962, grazie al minuzioso lavoro dello studioso Rupert Hart-Davis, il quale prese in esame il manoscritto depositato al British Museum, la lunga e meravigliosa epistola di Wilde poté tornare a vedere finalmente la luce nella sua versione integrale e corretta (fu inserita nel volume The Letters of Oscar Wilde).
Messa in musica dal compositore Frederic Rzewski.