The West’s asleep. Let England shake.
weighted down with silent dead.
I fear our blood won't rise again.
England’s dancing days are done.
Another day, Bobby, for you to come home
and tell me indifference won.
Smile, smile Bobby, with your lovely mouth.
Pack up your troubles, let’e head out
to the fountain of death
and splash about, swim back and forth
and laugh out loud,
until the day is ending.
and the birds are silent in the branches,
and the insects are courting in the bushes,
and by the shores of lovely lakes
heavy stones are falling.
weighted down with silent dead.
I fear our blood won't rise again.
England’s dancing days are done.
Another day, Bobby, for you to come home
and tell me indifference won.
Smile, smile Bobby, with your lovely mouth.
Pack up your troubles, let’e head out
to the fountain of death
and splash about, swim back and forth
and laugh out loud,
until the day is ending.
and the birds are silent in the branches,
and the insects are courting in the bushes,
and by the shores of lovely lakes
heavy stones are falling.
envoyé par Bartleby - 9/2/2011 - 10:28
Il conflitto globale permanente
di Rachele Cinarelli da Carmilla

PJ Harvey ha pubblicato il suo primo album nel 1992. In questi vent’anni di carriera, la critica rock ha voluto affibbiarle l'etichetta di rockeuse maledetta dai connotati fortemente eroticizzati, un giudizio che ha anche accompagnato l'interpretazione dei suoi testi. L'inglese Polly Jean ha sempre giocato vari ruoli: prima la ragazza dimessa di Dry, poi la diva conturbante con il volto talmente truccato da sembrare la maschera sciolta di Maria Callas di To Bring You My Love, poi la trentenne cool col vestito giusto nel posto giusto (Is This Desire, Stories from the City, Stories from the Sea), il tutto a volte prestando il fianco alla categorizzazioni, flirtando con i giornali di moda, e a volte togliendosi le etichette di dosso (ad esempio, definendo il paragone ricorrente con Patti Smith “giornalismo pigro”). Infine, negli ultimi dischi, ha messo in atto un forte “ritorno alle radici” sia estetico, sia di scelta musicale (l'uso dell'auto harp per la composizione delle canzoni). In tutte queste fasi però ha sempre saputo preservare il nocciolo del proprio lavoro, cioè la composizione pura e onesta di canzoni, frutto di solitudine e ricerca. E soprattutto quel porre il brano all'ascoltatore in maniera imparziale, senza mai imporsi sulla canzone, ma lasciando libere tutte le possibili interpretazioni.
A 41 anni, PJ Harvey ha scritto il suo capolavoro. Si poteva affermare molto prima che ricevesse il Mercury Prize 2011 (il premio per miglior disco britannico dell'anno), come testimoniano le numerose recensioni entusiastiche all'uscita del disco.
Let England Shake è qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo allo stesso tempo. Può essere considerato un concept album per eccellenza, proprio nell'accezione classica di fine anni Sessanta e inizio Settanta, quando il long playing, con l'avvento della psichedelia, ha smesso di essere una collezione di singoli di successo e ha cercato di conquistarsi una propria dignità artistica legando i brani uno all'altro. Oggi assistiamo paradossalmente alla cancellazione totale di questa nozione, e la musica e il disco vengono riportarti a una collezione di brani singoli vendibili/scaricabili, di cui pochi a volte si ricordano il titolo o persino l'esecutore.
In questo senso quindi, Let England Shake riesce a rappresentare un’eccezione. Il concetto alla base di questo album, il filo rosso che lega tra loro tutti i brani è la guerra. O meglio, i cicli di conflitto che spesso riguardano gli stessi luoghi in tempi differenti, dove vediamo all’opera un aggressore ricorrente, il mondo occidentale. La lavorazione di questo disco è durata tre anni, in cui PJ Harvey ha ricercato testimonianze di guerra attraverso varie fonti, dai blog delle vittime della guerra in Iraq e in Afghanistan, fino ai resoconti e alle testimonianze della disfatta di Gallipoli del 1915, operazione fiasco guidata dalla Triplice Intesa durante la Prima Guerra Mondiale (la penisola turca era già stata teatro di guerra durante l'avanzata degli Ottomani nel 1366). Ha dichiarato che, contrariamente alla maggior parte delle volte, prima sono arrivati i testi e poi la musica. Testi influenzati da pilastri della letteratura anglosassone come Harold Pinter, TS Eliot, James Joyce, ma anche da quelli di canzoni folk russe (This Glorious Land, In The Dark Places). Ciò che colpisce è sicuramente l'assoluta chiarezza e pulizia della composizione, l’uso di un linguaggio letterario non familiare alla maggioranza delle composizioni pop-rock. Parole di cui Harvey si fa narratrice con una voce che risulta quasi neutrale da quanto eterea, e che sembra continuamente toccare i limiti della sua estensione vocale.
La memoria della campagna dei Dardanelli riecheggia in brani come All And Everyone, The Colour Of The Earth, On Battleship Hill, mentre il richiamo al Medio Oriente è chiaro in Written On The Forehead (People throwing dinars/ at the belly dancers/ in a sad circus/ behind a trench of burned oil). Come la stessa autrice ha dichiarato riferendosi ai conflitti e ai teatri di guerra “non importa quando è successo, perché questo circolo perenne si ripete ancora, ancora e ancora”. Ci racconta che il conflitto è continuo e globale. Harvey si costruisce una posizione da narratrice che sembra enfatizzata anche in concerto, dove rimane a sinistra del palco rispetto allo spettatore, separata dal resto dei musicisti (Mick Harvey, John Parish, Jean-Marc Butty), e vestita di bianco o di nero, i due colori contrari e anche assoluti, poiché entrambi possono significare l'assenza di colore o la somma di tutti. L’insieme viene risaltato dalla corporatura ossuta, dai movimenti calcolatissimi, dai capelli neri decorati con piume di uccello che rimandano alla tradizione celtica, in cui l’uccello è il messaggero degli dei, il tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Gli uccelli vengono ripresi anche nella copertina dell'album, dove i gabbiani sembrano esplodere da una macchia d'inchiostro.
L'elemento naturale richiamato nelle esibizioni dal vivo non è casuale. Nei testi, oltre agli esseri umani è vittima anche la Natura, ferita e violentata. In The Last Living Rose il cielo si muove, l'oceano brilla, la siepe si agita e l'ultima rosa tremola, in segno di qualcosa che sta per arrivare. In The Words That Maketh Murder gli arti macellati dei soldati stanno in mezzo agli alberi, e le mosche brulicano su tutto, mentre in The Colour Of The Earth, il colore della terra appunto è rosso sangue. I campi non vengono più arati con gli attrezzi, ma con i carri armati e le marce dei soldati, e i frutti della terra sono bambini orfani e deformati in This Glorious Land. Infine in On Battleship Hill, il profumo di timo portato dal vento ricorda che la natura crudele vincerà ancora, quasi a ribellarsi alla follia umana cercando di sanarla.
La musica che fa da base a questa narrazione universale ha in sé gli elementi della classica formazione rock: chitarra elettrica, basso e batteria. Le chitarre sono solo ritmiche, attutite da effetti di eco e riverberi, il basso è rafforzato da inserti di sassofono, e su questo scheletro si aggiungono strumenti come l'auto harp, lo xilofono, il piano, cori di voci maschili e femminili. Le ritmiche sono piene, circolari, sciancate: in esse si inseriscono elementi di reggae nero e bianco: il sample di Winston “Niney” Holness in Written on the Forehead e la batteria dei Police in This Glorious Land. Altri campionamenti inaspettati e disorientanti come il bugle della Regimental March (ancora This Glorious Land) e il canto popolare della Baghdad anni Venti Kassem Miro sulla traccia England, la citazione di Summertime Blues di Eddie Cochran in The Words that Maketh Murder. Qui l'ironico What if I take my problem to the United Nations? assume un significato serio e attualissimo. Campionamenti che sembrano provenire da una radio accesa da qualche parte nel mondo, pezzi di tradizioni musicali che si uniscono o sovrappongono a sottolineare il carattere globale delle tematiche trattate. Ma anche a dirci che, nonostante queste, Let England Shake è un disco fortemente melodico e incalzante nelle ritmiche, tanto far battere le mani, o canticchiare le parole.
A un primo ascolto, il disco può apparire ostico dal punto di vista musicale e anche troppo “patriota”. In realtà la continua menzione dell'Inghilterra non è affatto celebrativa, ma anzi, sembra enfatizzare la storia inglese, fatta di sanguinosi conflitti interni, colonialismo e imperialismo. È quindi un’esortazione alla nazione, come si percepisce chiaramente nel brano omonimo che apre il disco. Anche il progetto video che lo accompagna insiste su questo concetto. Per ogni traccia dell'album infatti è stato realizzato un video, con la collaborazione del fotoreporter Seamus Murphy, attivo in zone calde del pianeta, in cui si intrecciano scene di vita quotidiana britannica assieme a flash di immagini di guerra.
Let England Shake può essere considerato un disco combat-rock, ma è un disco che rinnova totalmente il genere di protesta. Compie questo passo importante perché riesce a liberarsi completamente dalla retorica, e arrivare al carattere di universalità delle diverse storie che formano la Storia. Uno scarto su cui molti folk singer di protesta e di professione che abbondano in Italia a vari livelli dovrebbero meditare.
di Rachele Cinarelli da Carmilla

PJ Harvey ha pubblicato il suo primo album nel 1992. In questi vent’anni di carriera, la critica rock ha voluto affibbiarle l'etichetta di rockeuse maledetta dai connotati fortemente eroticizzati, un giudizio che ha anche accompagnato l'interpretazione dei suoi testi. L'inglese Polly Jean ha sempre giocato vari ruoli: prima la ragazza dimessa di Dry, poi la diva conturbante con il volto talmente truccato da sembrare la maschera sciolta di Maria Callas di To Bring You My Love, poi la trentenne cool col vestito giusto nel posto giusto (Is This Desire, Stories from the City, Stories from the Sea), il tutto a volte prestando il fianco alla categorizzazioni, flirtando con i giornali di moda, e a volte togliendosi le etichette di dosso (ad esempio, definendo il paragone ricorrente con Patti Smith “giornalismo pigro”). Infine, negli ultimi dischi, ha messo in atto un forte “ritorno alle radici” sia estetico, sia di scelta musicale (l'uso dell'auto harp per la composizione delle canzoni). In tutte queste fasi però ha sempre saputo preservare il nocciolo del proprio lavoro, cioè la composizione pura e onesta di canzoni, frutto di solitudine e ricerca. E soprattutto quel porre il brano all'ascoltatore in maniera imparziale, senza mai imporsi sulla canzone, ma lasciando libere tutte le possibili interpretazioni.
A 41 anni, PJ Harvey ha scritto il suo capolavoro. Si poteva affermare molto prima che ricevesse il Mercury Prize 2011 (il premio per miglior disco britannico dell'anno), come testimoniano le numerose recensioni entusiastiche all'uscita del disco.
Let England Shake è qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo allo stesso tempo. Può essere considerato un concept album per eccellenza, proprio nell'accezione classica di fine anni Sessanta e inizio Settanta, quando il long playing, con l'avvento della psichedelia, ha smesso di essere una collezione di singoli di successo e ha cercato di conquistarsi una propria dignità artistica legando i brani uno all'altro. Oggi assistiamo paradossalmente alla cancellazione totale di questa nozione, e la musica e il disco vengono riportarti a una collezione di brani singoli vendibili/scaricabili, di cui pochi a volte si ricordano il titolo o persino l'esecutore.
In questo senso quindi, Let England Shake riesce a rappresentare un’eccezione. Il concetto alla base di questo album, il filo rosso che lega tra loro tutti i brani è la guerra. O meglio, i cicli di conflitto che spesso riguardano gli stessi luoghi in tempi differenti, dove vediamo all’opera un aggressore ricorrente, il mondo occidentale. La lavorazione di questo disco è durata tre anni, in cui PJ Harvey ha ricercato testimonianze di guerra attraverso varie fonti, dai blog delle vittime della guerra in Iraq e in Afghanistan, fino ai resoconti e alle testimonianze della disfatta di Gallipoli del 1915, operazione fiasco guidata dalla Triplice Intesa durante la Prima Guerra Mondiale (la penisola turca era già stata teatro di guerra durante l'avanzata degli Ottomani nel 1366). Ha dichiarato che, contrariamente alla maggior parte delle volte, prima sono arrivati i testi e poi la musica. Testi influenzati da pilastri della letteratura anglosassone come Harold Pinter, TS Eliot, James Joyce, ma anche da quelli di canzoni folk russe (This Glorious Land, In The Dark Places). Ciò che colpisce è sicuramente l'assoluta chiarezza e pulizia della composizione, l’uso di un linguaggio letterario non familiare alla maggioranza delle composizioni pop-rock. Parole di cui Harvey si fa narratrice con una voce che risulta quasi neutrale da quanto eterea, e che sembra continuamente toccare i limiti della sua estensione vocale.
La memoria della campagna dei Dardanelli riecheggia in brani come All And Everyone, The Colour Of The Earth, On Battleship Hill, mentre il richiamo al Medio Oriente è chiaro in Written On The Forehead (People throwing dinars/ at the belly dancers/ in a sad circus/ behind a trench of burned oil). Come la stessa autrice ha dichiarato riferendosi ai conflitti e ai teatri di guerra “non importa quando è successo, perché questo circolo perenne si ripete ancora, ancora e ancora”. Ci racconta che il conflitto è continuo e globale. Harvey si costruisce una posizione da narratrice che sembra enfatizzata anche in concerto, dove rimane a sinistra del palco rispetto allo spettatore, separata dal resto dei musicisti (Mick Harvey, John Parish, Jean-Marc Butty), e vestita di bianco o di nero, i due colori contrari e anche assoluti, poiché entrambi possono significare l'assenza di colore o la somma di tutti. L’insieme viene risaltato dalla corporatura ossuta, dai movimenti calcolatissimi, dai capelli neri decorati con piume di uccello che rimandano alla tradizione celtica, in cui l’uccello è il messaggero degli dei, il tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Gli uccelli vengono ripresi anche nella copertina dell'album, dove i gabbiani sembrano esplodere da una macchia d'inchiostro.
L'elemento naturale richiamato nelle esibizioni dal vivo non è casuale. Nei testi, oltre agli esseri umani è vittima anche la Natura, ferita e violentata. In The Last Living Rose il cielo si muove, l'oceano brilla, la siepe si agita e l'ultima rosa tremola, in segno di qualcosa che sta per arrivare. In The Words That Maketh Murder gli arti macellati dei soldati stanno in mezzo agli alberi, e le mosche brulicano su tutto, mentre in The Colour Of The Earth, il colore della terra appunto è rosso sangue. I campi non vengono più arati con gli attrezzi, ma con i carri armati e le marce dei soldati, e i frutti della terra sono bambini orfani e deformati in This Glorious Land. Infine in On Battleship Hill, il profumo di timo portato dal vento ricorda che la natura crudele vincerà ancora, quasi a ribellarsi alla follia umana cercando di sanarla.
La musica che fa da base a questa narrazione universale ha in sé gli elementi della classica formazione rock: chitarra elettrica, basso e batteria. Le chitarre sono solo ritmiche, attutite da effetti di eco e riverberi, il basso è rafforzato da inserti di sassofono, e su questo scheletro si aggiungono strumenti come l'auto harp, lo xilofono, il piano, cori di voci maschili e femminili. Le ritmiche sono piene, circolari, sciancate: in esse si inseriscono elementi di reggae nero e bianco: il sample di Winston “Niney” Holness in Written on the Forehead e la batteria dei Police in This Glorious Land. Altri campionamenti inaspettati e disorientanti come il bugle della Regimental March (ancora This Glorious Land) e il canto popolare della Baghdad anni Venti Kassem Miro sulla traccia England, la citazione di Summertime Blues di Eddie Cochran in The Words that Maketh Murder. Qui l'ironico What if I take my problem to the United Nations? assume un significato serio e attualissimo. Campionamenti che sembrano provenire da una radio accesa da qualche parte nel mondo, pezzi di tradizioni musicali che si uniscono o sovrappongono a sottolineare il carattere globale delle tematiche trattate. Ma anche a dirci che, nonostante queste, Let England Shake è un disco fortemente melodico e incalzante nelle ritmiche, tanto far battere le mani, o canticchiare le parole.
A un primo ascolto, il disco può apparire ostico dal punto di vista musicale e anche troppo “patriota”. In realtà la continua menzione dell'Inghilterra non è affatto celebrativa, ma anzi, sembra enfatizzare la storia inglese, fatta di sanguinosi conflitti interni, colonialismo e imperialismo. È quindi un’esortazione alla nazione, come si percepisce chiaramente nel brano omonimo che apre il disco. Anche il progetto video che lo accompagna insiste su questo concetto. Per ogni traccia dell'album infatti è stato realizzato un video, con la collaborazione del fotoreporter Seamus Murphy, attivo in zone calde del pianeta, in cui si intrecciano scene di vita quotidiana britannica assieme a flash di immagini di guerra.
Let England Shake può essere considerato un disco combat-rock, ma è un disco che rinnova totalmente il genere di protesta. Compie questo passo importante perché riesce a liberarsi completamente dalla retorica, e arrivare al carattere di universalità delle diverse storie che formano la Storia. Uno scarto su cui molti folk singer di protesta e di professione che abbondano in Italia a vari livelli dovrebbero meditare.
CCG/AWS Staff - 29/11/2011 - 09:31
Recensione da Sentire Ascoltare
di Stefano Solventi
Che White Chalk fosse un album definitivo per PJ Harvey, la chiusura della parabola introspettiva iniziata con Dry, era facilmente ipotizzabile. In venti anni sette dischi (tolti quelli assieme a John Parish) ed altrettante maschere, ognuno una tappa sentimentale, culturale e geografica, uno specchio in cui riflettersi, cui concedere l'onere della prova. Dalla periferia alla metropoli e ritorno, con l'obiettivo di indagare i tumulti e ricomporre l'inquietudine. Fino ad accettare se stessa - il contrasto tra le proprie radici e le aspirazioni, tra anima e natura - come una dolce inevitabile maledizione.
Con Let England Shake inizia quindi a tutti gli effetti una nuova fase nella carriera di PJ. Niente più maschere, niente più ricerca di sé: sarà un caso se per la prima volta Polly non compare in copertina? La sua emotività è libera di indagare altrove, di aprirsi al mondo prendendosene cura, mettendo al centro della questione il tema evergreen della guerra, o meglio l'idea del conflitto come mito fondante di un popolo. Lo fa esplicitamente senza rinunciare ad una spiazzante elusività, ovvero parlando a nuora perché suocera intenda, all'Inghilterra assunta come simbolo arcaico di un imperialismo globale che - mutando modi, forme, alibi, nome - continua ad essere la spinta che pianifica le sorti della nostra civiltà. In questo senso, Let England Shake è un disco d'altri tempi, nel quale puoi addirittura avvertire la fragranza folle e urticante dei Sixties californiani antagonisti (in All And Everyone, con la sua madreperlacea solennità, sembra ammiccare al lirismo emblematico dei Jefferson Airplane). E' solo un rumore di fondo tra gli altri di un programma che con gli ascolti svela un variegato ventaglio di frequenze e radici, non a caso inaugurato dalla grottesca ambiguità della title track, imperniata sul sample di Istanbul (Not Constantinople), uno swing ibrido inciso negli anni Cinquanta dai The Four Lads.
Siamo lontanissimi dalla vecchia, selvatica PJ. La rocker aspra e convulsa degli esordi ha lasciato progressivamente il posto ad una cantastorie conturbante e riflessiva, che ha imparato a manipolare l'irrequietezza per farne narrazione, a trasfigurare la patologia in racconto, lo schizzo furibondo in una trama di cromatismi ammalianti. C'è ancora un lato rabbioso che sgomita per farsi luce, ma è come domato, ricondotto nei ranghi come una frase che sta tra le righe (vedi il folk blues indiavolato di Bitter Branches). L'abito sonoro - allestito assieme ai fidi John Parish, Mick Harvey e Jean-Marc Butty, con Flood ad occuparsi del missaggio - è parco ma prezioso, fatto di percussioni terrigne e frugali, di chitarre semiacustiche ed elettriche dal timbro morbido, mai invasive, spesso echoizzate come un sogno esotico. Poi c'è l'autoharp, diventato un po' il feticcio della rinata Polly Jean (e quanto se ne sia ormai impadronita è palese in The Words That Maketh Murder, sorta di pseudo-rumba col veleno dentro), quindi discreti ma incisivi interventi di sax e trombone, le apparizioni commoventi del piano, pochi e vaghi sfondi di tastiera.
Il canto stesso di Polly è ormai strumento versatile, capace di sconcertanti mutazioni secondo le necessità espressive, vedi il lalleggiare ruvido in England, con quella studiata mancanza di grazia che rievoca la struggente devozione delle preghiere popolari, oppure l'incedere beffardello e l'isteria pilotata nel finale di The Glorious Land, o ancora l'afflato operistico della flamencata On Battleship Hill. Soprattutto, la scrittura rivela una bellezza desueta, scostante, capace di esaltarsi nei dettagli d'arrangiamento (In The Dark Places sarebbe stata l'ennesima ballad ingrugnita altezza Uh Huh Her, non fosse per la magnifica apertura di sax e cori nel bridge), di misurarsi con frequenze diverse (vedi quella specie di post-reggae di Written On The Forehead, quasi un Moby nobilitato Brian Eno) senza tradire l'unicità del mood e la poetica di fondo.
Oltrepassata la soglia dei quarant'anni, PJ Harvey è diventata artista dalle molte sfaccettature e imprevedibili prospettive. La sua figura forse non sarà mai più centrale come lo è stata in passato: l'epoca reclama interpreti nuovi e diversi, ed è giusto così. Ma tutto lascia credere che saprà condurre una marginalità intensa e staordinariamente peculiare.
di Stefano Solventi
Che White Chalk fosse un album definitivo per PJ Harvey, la chiusura della parabola introspettiva iniziata con Dry, era facilmente ipotizzabile. In venti anni sette dischi (tolti quelli assieme a John Parish) ed altrettante maschere, ognuno una tappa sentimentale, culturale e geografica, uno specchio in cui riflettersi, cui concedere l'onere della prova. Dalla periferia alla metropoli e ritorno, con l'obiettivo di indagare i tumulti e ricomporre l'inquietudine. Fino ad accettare se stessa - il contrasto tra le proprie radici e le aspirazioni, tra anima e natura - come una dolce inevitabile maledizione.
Con Let England Shake inizia quindi a tutti gli effetti una nuova fase nella carriera di PJ. Niente più maschere, niente più ricerca di sé: sarà un caso se per la prima volta Polly non compare in copertina? La sua emotività è libera di indagare altrove, di aprirsi al mondo prendendosene cura, mettendo al centro della questione il tema evergreen della guerra, o meglio l'idea del conflitto come mito fondante di un popolo. Lo fa esplicitamente senza rinunciare ad una spiazzante elusività, ovvero parlando a nuora perché suocera intenda, all'Inghilterra assunta come simbolo arcaico di un imperialismo globale che - mutando modi, forme, alibi, nome - continua ad essere la spinta che pianifica le sorti della nostra civiltà. In questo senso, Let England Shake è un disco d'altri tempi, nel quale puoi addirittura avvertire la fragranza folle e urticante dei Sixties californiani antagonisti (in All And Everyone, con la sua madreperlacea solennità, sembra ammiccare al lirismo emblematico dei Jefferson Airplane). E' solo un rumore di fondo tra gli altri di un programma che con gli ascolti svela un variegato ventaglio di frequenze e radici, non a caso inaugurato dalla grottesca ambiguità della title track, imperniata sul sample di Istanbul (Not Constantinople), uno swing ibrido inciso negli anni Cinquanta dai The Four Lads.
Siamo lontanissimi dalla vecchia, selvatica PJ. La rocker aspra e convulsa degli esordi ha lasciato progressivamente il posto ad una cantastorie conturbante e riflessiva, che ha imparato a manipolare l'irrequietezza per farne narrazione, a trasfigurare la patologia in racconto, lo schizzo furibondo in una trama di cromatismi ammalianti. C'è ancora un lato rabbioso che sgomita per farsi luce, ma è come domato, ricondotto nei ranghi come una frase che sta tra le righe (vedi il folk blues indiavolato di Bitter Branches). L'abito sonoro - allestito assieme ai fidi John Parish, Mick Harvey e Jean-Marc Butty, con Flood ad occuparsi del missaggio - è parco ma prezioso, fatto di percussioni terrigne e frugali, di chitarre semiacustiche ed elettriche dal timbro morbido, mai invasive, spesso echoizzate come un sogno esotico. Poi c'è l'autoharp, diventato un po' il feticcio della rinata Polly Jean (e quanto se ne sia ormai impadronita è palese in The Words That Maketh Murder, sorta di pseudo-rumba col veleno dentro), quindi discreti ma incisivi interventi di sax e trombone, le apparizioni commoventi del piano, pochi e vaghi sfondi di tastiera.
Il canto stesso di Polly è ormai strumento versatile, capace di sconcertanti mutazioni secondo le necessità espressive, vedi il lalleggiare ruvido in England, con quella studiata mancanza di grazia che rievoca la struggente devozione delle preghiere popolari, oppure l'incedere beffardello e l'isteria pilotata nel finale di The Glorious Land, o ancora l'afflato operistico della flamencata On Battleship Hill. Soprattutto, la scrittura rivela una bellezza desueta, scostante, capace di esaltarsi nei dettagli d'arrangiamento (In The Dark Places sarebbe stata l'ennesima ballad ingrugnita altezza Uh Huh Her, non fosse per la magnifica apertura di sax e cori nel bridge), di misurarsi con frequenze diverse (vedi quella specie di post-reggae di Written On The Forehead, quasi un Moby nobilitato Brian Eno) senza tradire l'unicità del mood e la poetica di fondo.
Oltrepassata la soglia dei quarant'anni, PJ Harvey è diventata artista dalle molte sfaccettature e imprevedibili prospettive. La sua figura forse non sarà mai più centrale come lo è stata in passato: l'epoca reclama interpreti nuovi e diversi, ed è giusto così. Ma tutto lascia credere che saprà condurre una marginalità intensa e staordinariamente peculiare.
DonQuijote82 - 25/9/2011 - 22:34
I versi “Smile, smile Bobby, pack up your troubles” fanno chiaro riferimento ad una celebre “marching song” britannica del 1915.
"Pack Up Your Troubles in Your Old Kit-Bag, and Smile, Smile, Smile" fu scritta da George Asaf (pseudonimo del songwriter George Henry Powell, 1880-1951) con musica del di lui fratello Felix Powell. Nient’altro che un’allegra marcetta per tirar su il morale alla truppa e favorire nuovi arruolamenti per il Grande Macello… Però nei primi anni 60 il presentatore radiofonico Charles Chilton riprese questa e molte altre canzoni patriottarde e da trincea per la sua dissacrante commedia antimilitarista “Oh, What a Lovely War!”, subito trasposta in musical teatrale (Joan Littlewood) ed in film (Richard Attenborough) dove “Pack up your troubles” veniva cantato dai soldati feriti e mutilati appena arrivati alla stazione di Londra. Inutile sottolineare lo stridente contrasto tra le parole della canzone, il ritmo di marcetta militare e l'andatura sbilenca dei feriti… Cazzo, c’era ben poco da ridere!
Ecco il testo della canzone originale:
PACK UP YOUR TROUBLES IN YOUR OLD KIT-BAG, AND SMILE, SMILE, SMILE
Private Perks is a funny little codger
With a smile a funny smile.
Five feet none, he's and artful little dodger
With a smile a funny smile.
Flush or broke he'll have his little joke,
He can't be suppress'd.
All the other fellows have to grin
When he gets this off his chest, Hi!
Refrain in coro (ripetuto due volte dopo ogni strofa)
Pack up your troubles in your old kit-bag,
And smile, smile, smile,
While you've a lucifer to light your fag,
Smile, boys, that's the style.
What's the use of worrying?
It never was worth while, so
Pack up your troubles in your old kit-bag,
And smile, smile, smile.
Private Perks went a-marching into Flanders
With his smile his funny smile.
He was lov'd by the privates and commanders
For his smile his funny smile.
When a throng of Bosches came along
With a mighty swing,
Perks yell'd out, "This little bunch is mine!
Keep your heads down, boys and sing, Hi!
Private Perks he came back from Bosche-shooting
With his smile his funny smile.
Round his home he then set about recruiting
With his smile his funny smile.
He told all his pals, the short, the tall,
What a time he'd had;
And as each enlisted like a man
Private Perks said 'Now my lad,' Hi!
Traduzione italiana del ritornello da Cinema: gli anni della contestazione (“Lucifer” era una marca di fiammiferi dell’epoca)
Caccia le preoccupazioni nel tascapane
E sorridi, sorridi, sorridi
Quando hai un "lucifer" per accendere la tua sigaretta
Sorridete, ragazzi, questo è lo stile
A cosa serve preoccuparsi?
Non è mai valsa la pena, allora
Caccia le preoccupazioni nel tascapane
E sorridi, sorridi, sorridi
"Pack Up Your Troubles in Your Old Kit-Bag, and Smile, Smile, Smile" fu scritta da George Asaf (pseudonimo del songwriter George Henry Powell, 1880-1951) con musica del di lui fratello Felix Powell. Nient’altro che un’allegra marcetta per tirar su il morale alla truppa e favorire nuovi arruolamenti per il Grande Macello… Però nei primi anni 60 il presentatore radiofonico Charles Chilton riprese questa e molte altre canzoni patriottarde e da trincea per la sua dissacrante commedia antimilitarista “Oh, What a Lovely War!”, subito trasposta in musical teatrale (Joan Littlewood) ed in film (Richard Attenborough) dove “Pack up your troubles” veniva cantato dai soldati feriti e mutilati appena arrivati alla stazione di Londra. Inutile sottolineare lo stridente contrasto tra le parole della canzone, il ritmo di marcetta militare e l'andatura sbilenca dei feriti… Cazzo, c’era ben poco da ridere!
Ecco il testo della canzone originale:
PACK UP YOUR TROUBLES IN YOUR OLD KIT-BAG, AND SMILE, SMILE, SMILE
Private Perks is a funny little codger
With a smile a funny smile.
Five feet none, he's and artful little dodger
With a smile a funny smile.
Flush or broke he'll have his little joke,
He can't be suppress'd.
All the other fellows have to grin
When he gets this off his chest, Hi!
Refrain in coro (ripetuto due volte dopo ogni strofa)
Pack up your troubles in your old kit-bag,
And smile, smile, smile,
While you've a lucifer to light your fag,
Smile, boys, that's the style.
What's the use of worrying?
It never was worth while, so
Pack up your troubles in your old kit-bag,
And smile, smile, smile.
Private Perks went a-marching into Flanders
With his smile his funny smile.
He was lov'd by the privates and commanders
For his smile his funny smile.
When a throng of Bosches came along
With a mighty swing,
Perks yell'd out, "This little bunch is mine!
Keep your heads down, boys and sing, Hi!
Private Perks he came back from Bosche-shooting
With his smile his funny smile.
Round his home he then set about recruiting
With his smile his funny smile.
He told all his pals, the short, the tall,
What a time he'd had;
And as each enlisted like a man
Private Perks said 'Now my lad,' Hi!
Traduzione italiana del ritornello da Cinema: gli anni della contestazione (“Lucifer” era una marca di fiammiferi dell’epoca)
Caccia le preoccupazioni nel tascapane
E sorridi, sorridi, sorridi
Quando hai un "lucifer" per accendere la tua sigaretta
Sorridete, ragazzi, questo è lo stile
A cosa serve preoccuparsi?
Non è mai valsa la pena, allora
Caccia le preoccupazioni nel tascapane
E sorridi, sorridi, sorridi
Dead End - 10/1/2013 - 11:39
×
![]()
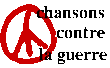








[2011]
Da “Let England shake”, con John Parish e Mike Harvey.
Leggi anche
Il conflitto globale permanente
articolo di Rachele Cinarelli
Recensione di Stefano Solventi
Let England Shake - The Last Living Rose - The Glorious Land - The Words That Maketh Murder - All and Everyone - On Battleship Hill - In the Dark Places - Bitter Branches - Hanging in the Wire - Written on the Forehead - The Colour of the Earth
iTunes Bonus Tracks:
The Big Guns Called Me Back Again - The Nightingale
contiene nelle musica un campionamento di Instanbul (not Constantinople), uno swing del 1953 e nel testo una citazione della marching song della I guerra mondiale Pack Up Your Troubles in Your Old Kit-Bag.